Introduzione: cibo, lingua, identità
«La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria (Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene)
La lingua della cucina e dell’alimentazione costituisce un settore primario del lessico, dall’innegabile valore anche simbolico: essa esprime un’esperienza fondamentale e quotidiana, con un forte ascendente nelle radici delle singole comunità, e al tempo stesso una marcata proiezione esterna, proprio in quanto fattore identitario. Nelle vicende della storia italiana, segnata da un complesso rapporto fra realtà piccole e grandi, da una significativa frammentazione non meno politica che sociale e culturale, si è venuta col tempo definendo una rete di consuetudini alimentari e gastronomiche, riconoscibili e interscambiabili, pur nel mantenimento delle proprie specificità originarie.
Dalle molteplici realtà del Medioevo, alla prospettiva interregionale dei trattati rinascimentali, all’operazione tardo-ottocentesca di Pellegrino Artusi, che ha cercato di creare un codice alimentare unitario, espresso in una lingua comprensibile a tutti, nella tradizione italiana è sempre stato fortissimo il legame fra particolare e universale, fra ciò che è specifico e ciò che aspira a una generale diffusione. Questo è oggi evidente a livello della pratica di cucina, nei continui richiami dei grandi cuochi alla riscoperta e alla validità delle tradizioni locali, rivisitate con spirito nuovo e con le tecniche più innovative; e nella lingua della cucina è plasticamente reso dal convergere dei termini di provenienza dialettale in un fondo di lingua comune, al tempo stesso sensibilmente aperta all’immissione di termini stranieri (francesismi, anglismi, in primo luogo, ma anche parole arabe o orientali, a esprimere bene le nuove frontiere dell’alimentazione).
E insieme, mentre il concetto ‘interno’ di identità della cucina si articola secondo tutta questa serie di specificazioni, si nota il fenomenale successo del modello italiano del cibo all’estero, che trascina con sé le parole dell’italiano – talora adattate, talora anche maltrattate e storpiate – a dar conto di una identità riconoscibile ma anche esposta a tradimenti, tanto più evidenti quanto più proiettati all’esterno.
1. La lingua italiana e la cucina
L'arte culinaria fu, fin dalle origini, un elemento che contribuì alla formazione dell'identità dell'Italia. A dimostrazione di questo basti pensare che i primi ricettari, comparsi negli ultimi secoli del Medioevo, pur muovendosi in ambito europeo, riportano delle ricette ad usum Romanorum, ad usum Campanie, definite pugliesi, lombarde, ecc. Inoltre, dal Quattrocento all'Ottocento vi si trovano, in un'ottica comparativa, prodotti legati al territorio (le galline padovane; le carote di Viterbo; i rombi di Ravenna; le sardelle e i carpioni dell'Adda, e così via).
I ricettari diventano, così, anche specchio di un'Italia fatta di territori politicamente divisi che comunicavano tra loro in una rete commerciale che permetteva anche lo scambio culturale e linguistico. In questa ottica, la cucina, intesa non solo come arte di preparare ma anche di gustare cibo nutrendosi, diventa punto di incontro, frutto della circolazione di tante realtà locali in un comune circuito di scambi in cui si incontravano usi gastronomici e dialetti differenti. Che l'Italia fosse un Paese da sempre linguisticamente diviso, infatti, emerge chiaro anche dai ricettari.
Per esempio, si può pensare al significato che nel Medioevo la parola maccherone ― giunta fino a noi e ancora oggi usata per indicare un tipo di pasta alimentare a sezione rotonda, di varia lunghezza e dimensione ― assumeva a seconda dei diversi ambiti geografici di provenienza: i maccheroni lombardo-veneti erano una sorta di gnocchi; quelli alla napoletana erano simili alle tagliatelle o tagliolini; quelli romaneschi erano simili a cannelloni o cannoncini; quelli siciliani dovevano essere simili ai bucatini; quelli fiorentini del Trecento sono ritenuti comunemente simili agli gnocchi, ma da alcuni studiosi più simili a piccole lasagne.
In particolare, che il legame tra lingua, intesa soprattutto come lessico, e cibo potesse diventare funzionale proprio in un'Italia appena unita lo avrebbe dimostrato La Scienza in Cucina (1891) di Pellegrino Artusi, che, per offrire un ricettario comprensibile a tutti gli italiani, optò per il «volgare toscano», traducendo praticamente anche in cucina quell'idea di «unità della lingua parlata, che pochi curavano e molti osteggiavano, forse per un falso amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti» (Artusi, La Scienza in cucina, ricetta n. 455 Cacciucco)
1.1. Ricetta del cacciucco, dalla "Scienza in cucina" di Pellegrino Artusi
[“CACCIUCCO”, Pellegrino Artusi, Scienza in cucina, ed. 1891, pp. 203-24]
288. - Cacciucco
Cacciucco! Lasciatemi far due chiacchiere su questa parola la quale forse non è intesa che in Toscana e sulle spiaggie del Mediterraneo, per la ragione che ne’ paesi che costeggiano l’Adriatico è sostituita dalla voce brodetto. A Firenze, invece, il brodetto è una minestra che s’usa per Pasqua d’uova, cioè una zuppa di pane in brodo, legata con uova frullate ed agro di limone. La confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia, in Italia, è tale che poco manca a formare una seconda Babele.
Dopo l’unità della patria mi sembrava logica conseguenza il pensare all’unità della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai proprii dialetti.
Tornando al cacciucco dirò che questo, naturalmente, è un piatto in uso più che altrove nei porti di mare, ove il pesce si trova fresco e delle specie occorrenti al bisogno. Ogni pescivendolo è in grado d’indicarvi le qualità che meglio si addicono a un buon cacciucco; ma buono quanto si voglia è sempre un cibo assai grave e bisogna guardarsi dal farne una scorpacciata.
Per grammi 700 di pesce trinciate fine mezza cipolla e mettetela a soffriggere con olio, prezzemolo e due spicchi d’aglio intero. Appena che la cipolla avrà preso colore aggiungete grammi 300 di pomodoro a pezzi, o conserva, e condite con sale e pepe. Cotti che sieno i pomodori versate sui medesimi un dito d’aceto, se è forte e due se è debole, diluito in un buon bicchier d’acqua. Lasciate bollire ancora per qualche minuto, poi gettate via l’aglio e passate il resto spremendo bene. Rimettete al fuoco il succo passato, insieme col pesce che avrete in pronto come sarebbero, parlando dei più comuni, sogliole, triglie, palombo, ghiozzi, canocchie, che in Toscana chiamansi cicale, ed altre varietà della stagione, lasciando interi i pesci piccoli e tagliando a pezzi i grossi. Assaggiate se sta bene il condimento; ma in ogni caso non sarà male aggiungere un po’ d’olio tenendosi piuttosto scarsi nel soffritto. Giunto il pesce a cottura e fatto il cacciucco, si usa portarlo in tavola in due vassoi separati; in uno il pesce asciutto, nell’altro tante fette di pane, grosse undito, quante ne può intingere il succo che resta.
Il pesce, se è fresco, ha l’occhio vivace e lucido; lo ha pallido ed appannato, se non è fresco. Un altro indizio della sua freschezza è il color rosso delle branchie; ma queste potendo essere state colorite ad arte col sangue, toccatele con un dito e portatevelo al naso, l’odore vi farà la spia. Un altro carattere del pesce fresco è la sodezza delle carni, perchè se sta molto nel ghiaccio diventa frollo e morbido al tatto.
2. I ricettari e la lingua del cibo
Se si volesse parlare di lingua della cucina italiana dalle origini, si dovrebbe far riferimento al latino, al volgare di base toscana e al francese. Il latino è presente fin dalle prime raccolte di ricette e il suo uso si ritrova ancora successivamente nel De honesta voluptate et valetudine del Platina, il quale, in pieno Umanesimo, ripropose in latino parte del ricettario quattrocentesco di Maestro Martino. Il volgare toscano divenne ben presto la base della lingua usata per i ricettari, accompagnata molto spesso da termini e fenomeni propri di altre aree linguistiche.
Il francese, invece, diventata la lingua prediletta dell'Europa del Secolo dei Lumi, si affermò in campo culinario a partire dalla fine del Seicento, arricchendo il lessico della cucina italiana di molti francesismi. Quando, però, si parla di lingua del cibo, e in particolare dei ricettari, non si può non far riferimento alla struttura della ricetta, alla disposizione dei contenuti e al modo in cui l'autore, per lo più cuoco di professione, si rivolge al pubblico (generalmente operatori del settore o ricchi signori fino alla scelta fatta da Pellegrino Artusi di indirizzarsi alle famiglie borghesi).
La struttura della ricetta a cui siamo oggi abituati, con una prima parte costituita dall'elenco degli ingredienti e una seconda in cui si espongono le fasi di realizzazione del piatto, sì è affermata soltanto grazie all'Artusi, mentre prima della sua Scienza in cucina ci si limitava all'indicazione delle azioni da compiere.
La scrittura delle prime raccolte di ricette presentava molte difficoltà: fino alla prima metà del Seicento, infatti, l'uso di una sintassi monotona, basata su verbi e ingredienti semplicemente accostati, non faceva emergere in maniera chiara le sequenze operative da seguire. Soltanto verso la fine del XVII secolo si sarebbe passati a una sintassi meglio organizzata, grazie all'uso di avverbi e di tempi verbali diversificati. L'affermazione dello stile spezzato nel Settecento avrebbe poi lasciato lo spazio a una scrittura più lineare nell'Ottocento, come dimostrato dallo stile narrativo semplice e comprensibile a tutti usato da Artusi.
Anche il modo in cui l'autore si rivolge al lettore cambia nel tempo: inizialmente gli si rivolgeva con il tu; poi, a partire dalla fine del Seicento, si sarebbe passati, grazie anche all'influenza dei ricettari francesi, all'uso del voi. Una scrittura, dunque, in movimento, quella della ricetta, cosa dovuta anche alla varietas.
2.1. I ricettari del Trecento e del Quattrocento
Nel XIV secolo si assiste alla nascita delle prime raccolte di ricette di cucina in volgare. Giunteci sotto forma di manoscritti, generalmente accompagnate da testi di argomentazione simile, si presentano brevi e il più delle volte prive di un titolo specifico. Si tratta, infatti, di testi anonimi, nati per lo più come appunti presi da cuochi al servizio di ricchi signori, come promemoria per sé e per la propria cerchia di collaboratori.
Le tradizioni cui fanno capo questi antichi ricettari sono due: quella del Liber de coquina, intitolata così dal ricettario più antico conosciuto, scritto in latino, e quella che non circolò fuori dalla nostra penisola, ma durò più a lungo, dei 12 ghiotti, di probabile origine toscana, detta così per i numerosi riferimenti all'interno delle ricette a dodici ricchi goditori che dovevano essere i destinatari delle ricette e che si ipotizza possano identificarsi con la brigata spendereccia dantesca (Inf. XXIX, vv. 121-129).
Alla prima fanno capo due manoscritti conservati nella Bibliotheque Nationale de France.
Tra gli altri principali testi imparentati con il Liber de coquina vanno ricordati quello inedito contenuto in un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana; il Libro della cocina o Anonimo Toscano (Biblioteca Universitaria di Bologna), e il così detto Anonimo Meridionale A, conservato presso la Biblioteca Internazionale Gastronomica di Sorengo.
Il capostipite della seconda famiglia di ricettari, invece, è stato identificato con un manoscritto del 1338-39, redatto in Toscana e tutt'oggi conservato a Firenze. Di qui esso si sarebbe diffuso a Bologna, in Liguria, nel Veneto e nel sud della penisola.
Passando al Quattrocento, il primo testo in volgare organizzato in maniera più definita e scritto in uno stile più chiaro è il Libro de arte coquinaria di Maestro Martino, composto probabilmente intorno al 1450 e conservato in originale a Washington. A esso si sarebbero ispirati altri autori, tra cui Bartolomeo Sacchi detto il Platina (dal luogo d'origine, Piadena in provincia di Mantova) che nel De honesta voluptate et valetudine traduce in latino le competenze culinarie ricavate dall'opera di Martino. Il Platina fu uno degli autori più stimati del Quattrocento italiano. Il suo trattato, infatti, – edito la prima volta a Roma in lingua latina nel 1474 (primo fra i libri di cucina stampati in Italia), poi a Venezia nel 1487 in lingua volgare – fu tradotto in tutta Europa, in francese, tedesco e inglese.
2.1.1. "Limonìa di polli" dall'Anonimo Toscano
Solitamente ordinate senza un criterio specifico e unico, le prime ricette pervenuteci sono caratterizzate dalla mancanza di indicazione delle dosi, dovuta probabilmente al fatto che la ricetta nasceva come semplice appunto per un pubblico composto da operatori del settore, che ben sapevano regolare la quantità degli ingredienti usati sulla base dei propri bisogni.
Le preparazioni proposte sono caratterizzate per lo più dalla presenza abbondante di spezie, vero e proprio simbolo di ricchezza per l'epoca, e dal trionfo, accanto allo speziato, dell'agrodolce. Questo gusto, presente in tutti i ricettari medievali, sarebbe cambiato solo nel Settecento, con l'avvento della nouvelle cuisine nata in Francia. Molti, poi, sono i piatti dai nomi esotici, in particolar modo arabi. Vediamo qui la ricetta, presente in Anonimo Toscano, di una limonìa (pietanza preparata con pollo, mandorle, succo di limone e altri ingredienti):
Di limonia di polli dall'Anonimo Toscano (Il libro della cucina del sec. XIV: testo di lingua non mai fin qui stampato, a cura di F. Zambrini, Bologna, G. Romagnoli, 1863 p. 45)
Friggansi li polli col lardo e cipolle, e pestisi l'amido non mondo, e distemperisi col bruodo de la carne del porco, e colisi, e cocansi con li detti polli e spezie. E se non avessi amido, spessisi il bruodo colle tuorla d'ova; e quando sirà presso l'ora del ministrare, metti in quello, succhio di limoni, o di lomìe, o di cetrangule.
2.1.2. "Migliaccio" dal testo di Maestro Martino
[Migliaccio], dal Libro de arte coquinaria di Maestro Martino, Cap. IV (E. Faccioli, L'arte della cucina in Italia: libri di ricette e trattati sulla civiltà della tavola dal XIV al XIX secolo, vol 1, Torino, Einaudi 1987, p. 161)
Per fare un migliaccio per quattro o cinque persone pistarai molto
bene una libra di cascio del più frescho che possi havere, tanto che
ti para essere ritornato in lacte; et haverai tre o quattro once di fiore
di farina et octo o dece bianchi d'ova, et meza libra di zuccharo, mescolando
tutte queste cose et incorporandole bene insieme. Et se non
havessi fior de farina, habi una mollicha di pan biancho, et grattugiato
ben menuto, mettendola in loco de la farina. Et haverai la padella
senza pasta o crosta, et sullo fondo dentro vi metterai di bono strutto,
facendone un solo che sia alto un dito vel circha, et metterai la ditta
padella sulle brascie tanto che 'l strutto sia ben caldo, et dentro vi
buttirai questa tal compositione daendoli il focho temperato sotto et
sopra como è ditto all'altre torte. Et quando serà cotta cavala fore, et
di sopra vi metti di bono zuccharo et acqua rosata.
2.2. I ricettari del Cinquecento e del Seicento
Nel Cinquecento in cucina cambia la distribuzione dei compiti fra il cuoco e i suoi aiutanti: i ruoli cardine diventano quelli dello scalco, del trinciante e del bottigliere. Il primo era addetto all'allestimento della tavola e dei banchetti, il secondo al taglio delle carni e l'ultimo alla mescita dei vini. Non a caso è questo il periodo in cui diminuisce la produzione di ricettari e aumenta quella di trattati di scalcheria e di monografie sull'arte del trinciare. Tra i ricettari veri e propri, ha particolare importanza La singolar dottrina del gentiluomo fiorentino Domenico Romoli, detto il Panunto (XVI sec.), pubblicata a Venezia nel 1560 e l'Opera di Bartolomeo Scappi, "cuoco secreto", cioè personale, di Papa Pio V, pubblicata a Venezia nel 1570.
È questo anche il periodo in cui vedono la luce i Banchetti di Christoforo di Messisbugo, pubblicati a Ferrara nel 1549. Importante, a livello culinario e linguistico, è la presenza di piatti e prodotti di varia provenienza, alcuni dei quali attestati per la prima volta (es. zambudelli, 'sorta di salume'; cannellini 'confetti di forma allungata a base di cannella'). Come nei testi non toscani prodotti all'epoca, anche in quest'opera lo sforzo di adeguarsi al modello toscano convive con fenomeni e termini dell'uso locale parlato e del latino.
In tutti i ricettari menzionati, le ricette proposte mantengono, in linea con il calendario liturgico, l'alternanza di menù per i giorni “di magro” e per i giorni “di grasso”, risolta a volte con ricette descritte nelle versioni “grassa” o “magra”. Dal punto di vista del gusto, sulla quantità, come status symbol, si inizia a prediligere la qualità; l'uso dello zucchero prende il sopravvento a discapito di quello delle spezie, e il burro viene prediletto come collante per le salse. Ma la vera svolta si sarebbe avuta nel Settecento. Il Seicento, infatti, viene ricordato come un periodo di passaggio in cui mentre in Italia il numero di ricettari pubblicati diminuiva, in Francia se ne iniziava a produrre un numero altissimo. Tra i testi pubblicati in questo periodo è importante soltanto L'Arte di ben cucinare di Bartolomeo Stefani (1662) e Il cuoco francese ove è insegnata la maniera di condire ogni sorta di vivande (1682), del signor de La Varenne, in realtà traduzione di tre testi anonimi francesi.
2.2.1. "Per far minestra di panata in giorno grasso e magro"
Per far minestra di panata in giorno grasso e magro, dall'Opera di Bartolomeo Scappi Cuoco secreto di Papa Pio Quinto, in Venezia, presso Alessandro Vecchi MDCV, Libro VI, Cap. 69, c. 285v.
Piglisi mollica di pane bianco d'un giorno tagliata a dadi di grossezza d'una nocella,
bagnisi con brodo magro bollente, lascisi stare per un quarto d'hora cavisi po'
d'esso brodo, e rimettesi in brodo buono di cappone mezzo consumato, che non sia
troppo salato, facciasi finir di cuocere e diasegli un poco di corpo con rossi d'ova di
modo che venga quagliata e habbia quel grassetto giallo di sopra. L'estate in luogo
dell'ova pestisi seme di mellon mondo, e facciasene latte соn del medesimo brodo magro
et un mezzo quarto d'hora prima che s'habbia da servire, vi si metta dentro
col latt, e non si lasci bollire perché aggrupperebbe. In tal panata sarà in arbitrio
di mettere zuccaro fino et in loco del latte del seme di mellone si può mettere latte
di mandorle facendole levare il bollo con essa panata, e nelli giorni di venere e sabbato
in loco del brodo si adopererà butiro fresco lavato, et in giorno di vigilia oglio di mandorle dolci. In questo modo si potrebbe fare il pan grattato.
2.2.2. "Boscottini alla Savoiarda"
Boscottini alla Savoiarda, dall'Arte di ben cucinare di Bartolomeo Stefani (da C. Benporat, Storia della gastronomia italiana, Mursia, Milano 1990, p. 178).
Per farne meza cotta, pigliarai sei ova, una libra di zuccaro fino,
avertendo che l'ova siano fresche, nate nell'istesso giorno, pigliarai
un vaso ben pulito, e vi romperai dentro dette ova, e di
quelle sei chiare ne getterai via una, il zuccaro sia ben pestato
nel mortaro, e tamisato, di questa ne metterai quattr'oncie nel
mortaro, e due ne serbarai per fargli sopra il ghiaccio; pigliarai
un mazzetto di bacchette ben scorzate, e ben pulite, per mez'hora
andrai sbattendo dette ova col zuccaro, e quando li vorrai
fare, aggiongerai oncie sei di farina, li farai nella carta, ò nelle
cassette, overo nelle teggie ontate di butiro.
2.2.3. L'Opera e i Banchetti: contenuti a confronto
L'Opera di Bartolomeo Scappi (1570), che avrebbe riscosso grande successo anche all'estero, è costituita da sei libri: il primo dedicato agli insegnamenti di cucina; il secondo a preparazioni di vario tipo (frittate, salse, piatti a base di carni, e così via); il terzo ai pesci; il quarto ai menù di cene, colazioni, pranzi e banchetti; il quinto ai pasticci e il sesto agli alimenti per gli ammalati. Seguono poi una parte dedicata alla descrizione dei funerali di papa Paolo III e del conclave che si aprì successivamente (1549-50), durante il quale Scappi organizzò pranzi e cene, e 27 tavole che illustrano utensili, macchine e ambienti.
Quest'ordine così complesso e ben organizzato del testo si ritrova per la prima volta in un altro testo cinquecentesco di grande importanza: i Banchetti di Messisbugo (1549). Uscito cinquant'anni prima dell'opera di Scappi, il trattato di Messisbugo si divide in due parti: la prima è dedicata ai numerosi banchetti che l'autore allestì, come scalco, nei venticinque anni che operò alla corte di Ferrara (1524-1548); la seconda, invece, contiene oltre un centinaio di ricette reputate degne di un grande cuoco.
Se si confrontano i conviti descritti nei Banchetti e quelli dell'Opera, emerge uno stile più sobrio alla corte ferrarese rispetto alla magnificenza della corte papale. Nonostante questo, molti piatti proposti nei Banchetti sono di presunta o reale derivazione francese e tedesca, cosa che dimostra il cosmopolitismo della corte di Ferrara. Si veda, ad esempio, la seguente ricetta "alla francese": A fare un pastello baptuto, alla francese di carne di Vitello, o Castrone (da Benporat Claudio, Storia della gastronomia italiana, Mursia, Milano 1990, p. 116):
Prima Pigliarai carne di Uitello di Cossetto, o Castrone, e la netterai bene, da quelle pellegatte, e pellefine che li potrai cauare senza lauarla, dopoi la lauerai molto bene, e li darai un boglio per farla che sia più biancha, & poi che el la serà raffreddata, la pistarai con i Coltelli minutamente, poi pigliarai grasso di manzo della rognolata, e lo netterai da quelle pellesine che se li truouauano, e poi pistarai insieme con la detta carne, e quando serà ben pista a tuo modo, li metterai Gengeuro, e Peuere dentro, e Noci moscate piste, & un poco di Zaffrano, & un poco de Garofani pisti o intieri, e messederai bene ogni cosa insieme, la misura serà secondo la quantità, e grandezza che uorrai fare a tuo giudicio, e se li metterai un pochetto di Persutto tagliato minuto dentro, non li disdirà niente, poi farai la tua Cassa grande, o picciola, tonda del medesimo modo che è quella delle frutte, ma uuole essere un poco duretta la pasta, e sbattuta sopra una Tauola per spacio di mez'hora, poi fatta la Cassa, la imperai del pastume sopra detto, e li porrai sopra il suo coperto a cuocere nel Forno adaggio, & uuole essere mangiato caldo uno poco di Cipolla anchora pista nel pastume, è buonissima.
2.3. I ricettari dell'Ottocento
Quando si parla di produzione letteraria ottocentesca in cucina ci si riferisce ai ricettari pubblicati dal primo decennio del XIX secolo al 1891, anno in cui venne pubblicata la prima edizione della Scienza in cucina di Pellegrino Artusi. Si tratta di testi poco originali e per lo più anonimi, ma anche scritti da illustri medici o cuochi di professione, che hanno però il merito di illustrare spesso pratiche e usi propri locali o regionali mantenuti nelle cucine piccolo e medio borghesi. In questo periodo, infatti, accanto all'aristocrazia e ai ceti popolari, anche in Italia si andava affermando la classe borghese, che a proprio modo cominciava a volere esprimere il proprio status anche a tavola. Proprio l'esigenza di rivolgersi a questa nuova classe avrebbe poi portato, da Artusi in poi, alla scelta del volgare toscano e alla diminuzione dell'uso di termini francesi.
Tra i ricettari ottocenteschi, ricordiamo qui La cucina sana, economica ed elegante di Francesco Chapusot, pubblicato a Torino nel 1846; il Trattato di cucina, pasticceria moderna di Giovanni Vialardi, pubblicato a Torino nel 1854; Il Nuovo cuoco milanese economico di Giovanni Francesco Luraschi, edito a Milano nel 1829; La cuciniera genovese ossia la vera maniera di cucinare alla genevose di Giambattista e Giovanni Ratto, edito a Genova nel 1871; La nuova cucina economica di Vincenzo Agnoletti, edito a Roma nel 1803 e La cucina teorico-pratica del cavalier don Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino, edito a Napoli nel 1837, di cui si ricorda l'appendice in dialetto napoletano, in cui vengono proposti piatti dal sapore popolare.
I ricettari di questo periodo sono anche espressione di gusti differenti tra un Sud, in cui prevalgono la pasta, il pomodoro e l'olio d'oliva, e un Nord in cui si afferma l'uso del riso, della polenta e del burro. La lingua di questi ricettari è caratterizzata dalla presenza di dialettismi e francesismi, che rendevano difficoltosa la comprensione da parte di un pubblico ampio e diversificato. A dimostrazione di questo, basta leggere le accuse mosse ad Antonio Vialardi da Olindo Guerrini che, in una lettera d'elogio inviata ad Artusi, con sottoscrizione "Lorenzo Stecchetti", definiva "incomprensibili" molti ricettari pubblicati prima della Scienza in Cucina, non solo per scelte lessicali, ma anche per la mancanza di riferimenti pratici; e così terminava: «Per trovare una ricetta pratica e adatta per una famiglia bisogna andare a tentone, indovinare, sbagliare. Quindi benedetto l'Artusi! […]».
2.3.1. "Pastina alla Milanese" e "Maccaruncielle"
Pastina alla Milanese da La cucina teorico-pratica del cavalier Ippolito Cavalcanti (la ricetta è ripresa da Benporat Claudio, Storia della gastronomia italiana, Mursia, Milano 1990, pp. 337-338).
Prendete una quarta di farina di semola, unitevi oncie tre butirro liquefatto manipolatela come sopra con poco sale e pepe, bagnatela con acqua ed uno spruzzo di aceto e ben manipolato, ma che sia liquida montate un chiaro o due d'uova, unitevi il suo rosso, il tutto incorporate, servitene per li mariné.
Maccaruncielle da La cucina teorico-pratica del cavalier Ippolito Cavalcanti (la ricetta è ripresa da Benporat Claudio, Storia della gastronomia italiana, Mursia, Milano 1990, p. 366).
Scaura tre rotola de maccaruncielle, e chille de la Costa so chiù accellente, chillo de Gragnano pure songhe buon'assaje, e io llo saccio pecchè ncasa de no Signore, che sta de casa vicino a la Nunziata, nne tene sempe li casciune de tutte sciorte de pasta, benedica: pecchè tene no creddeto co uno de Gragnano, e te può figurà chillo puverommo, che sciorte de pasta lle manna, sempe la meglio, pecchè cchiù de na vota ngiaggio manciato, pecchè dinto a chella casa nge'è trasuta na Signorina, che io voglio tanto bene, e quanno chillo Signore se mette a dà na tavola, non te può fiurà com'è sguazzone, pecchè ng'è lo ditto nuosto che dice, ma chesto non pozzo dicere mò: scaura addonga li maccarune vierde vierde, li sculi, e poi li mbruogli co no miezo ruotolo de caso de sardegna, pecchè chillo Signore accossì lli ffa, e lo brodo de lo stufato.
2.3.2. «Lettera del poeta Lorenzo Stecchetti (Olindo Guerrini)...»
«Lettera del poeta Lorenzo Stecchetti (Olindo Guerrini) a cui mandai in dono una copia del mio libro di cucina, terza edizione:
On. Signor mio,
Ella non può immaginate che gradita sorpresa mi abbia fatto il suo volume, dove si compiacque di ricordarmi! Io sono stato e sono uno degli apostoli più ferventi ed antichi dell'opera sua che ho trovato la migliore, la più pratica, e la più bella, non dico di tutte le italiane che sono vere birbonate, ma anche delle straniere. Ricorda ella il Vialardi che fa testo in Piemonte?
«GILLÒ ABBRAGIATO. - La volaglia spennata si abbrustia, non si sboglienta, ma la longia di bue piccata di trifola cesellata e di giambone, si ruola a forma di valigia in una braciera con butirro. Umiditela soventemente con grassa e sgorgate e imbianchite due animelle e fatene una farcia da chenelle grosse un turacciolo, da bordare la longia. Cotta che sia, giusta di sale, verniciatela con salsa di tomatiche ridotta spessa da velare e fate per guarnitura una macedonia di mellonetti e zuccotti e servite in terrina ben caldo».
Non è nel libro, ma i termini ci sono tutti.
Quanto agli altri Re dei Cuochi, Regina delle Cuoche ed altre maestà culinarie, non abbiamo che traduzioni dal francese o compilazioni sgangherate. Per trovare una ricetta pratica e adatta per una famiglia bisogna andare a tentone, indovinare, sbagliare. Quindi benedetto l'Artusi! È un coro questo, un coro che le viene di Romagna, dove ho predicato con vero entusiasmo il suo volume. Da ogni parte me ne vennero elogi. Un mio caro parente mi scriveva: “Finalmente abbiamo un libro di cucina e non di cannibalismo, perché tutti gli altri dicono: prendete il vostro fegato, tagliatelo a fette, ecc.” e mi ringraziava.
Avevo anch'io l'idea di fare un libro di cucina da mettere nei manuali dell'Hoepli. Avrei voluto fare un libro, come si dice di volgarizzazione; ma un poco il tempo mi mancò, un poco ragioni di bilancio mi rendevano difficile la parte sperimentale e finalmente venne il suo libro che mi scoraggiò affatto. L'idea mi passò, ma mi è rimasta una discreta collezione di libri di cucina che fa bella mostra di sé in uno scaffale della sala da pranzo. La prima edizione del suo libro, rilegata, interfogliata ed arricchita (?) di parecchie ricette, vi ha il posto d'onore. La seconda serve alla consultazione quotidiana e la terza ruberà ora il posto d'onore alla prima perché superba dell'autografo dell'Autore.
Così, come Ella vede, da un pezzo conosco, stimo e consiglio l'opera sua ed Ella intenda perciò con che vivissimo piacere abbia accolto l'esemplare cortesemente inviatomi. Prima il mio stomaco solo provava una doverosa riconoscenza verso di Lei; ora allo stomaco si aggiunge l'animo. È perciò, Egregio Signore, che rendendole vivissime grazie del dono e della cortesia, mi onoro di rassegnarmi colla dovuta gratitudine e stima.
Bologna, 19-XII-96
Suo Dev.mo
Olindo Guerrini
(dalla Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, a cura di A. Capatti, Milano, Rizzoli 2010, pp. 33-34).
2.4. I ricettari femminili del Novecento
Il primo testo di cucina scritto da una donna fu pubblicato da Giulia Ferraris Tamburini che, per l'editore milanese Hoepli, presentò nel 1900 Come posso mangiare bene?. Avrebbero seguito poi Dalla cucina al salotto (1905); Far molto con poco. L'arte di creare buoni piatti coi residui di cucina (1909) e La cuoca medichessa (1913) di Lidia Morelli, Fuoco sacro di Ida Baccini (1903) e L'infermiera in cucina di Angelica De Vito Tommasi. Si tratta di ricettari in cui il nuovo modello di donna, che lavora fuori casa, inizia ad aver bisogno di preparare in minor tempo possibile “oltre mille ricette di vivande comuni, facili ed economiche per gli stomachi sani e per quelli delicati”, come recita il frontespizio del libro di Come posso mangiar bene?. Vengono proposti, così, piatti di antico sapore, che, nella nuova veste, si rivelano spesso né di buon gusto, né economici.
Unica eccezione, la bolognese Maria Dall'Olio, collaboratrice della famosa rivista di Adolfo Giaquinto Il Messaggero della Cucina, che, nelle sue Norme pratiche sull'alimentazione dei malati e dei convalescenti, presenta ricette meno legate al passato in quanto a condimenti e tempi di cottura. Ad ogni modo, il fine generale che si ponevano queste autrici ― fiere rappresentanti di una borghesia affermata ― era quello di "ammaestrare le massaie" nella cura della casa e delle cose di cucina. Una delle autrici più prolifiche fu Lidia Morelli, che si firmava come Donna Clara, i cui testi, con le loro numerose edizioni, testimoniano il cambiamento di stile dei ricettari femminili: da un tono cattedratico a uno sempre più colloquiale. L'attività della Morelli, tra i Ricettari pubblicati per l'azienda Cirio, le Agende per le massaie d'Italia, i Libri di casa Domus, non conosce interruzioni e avrebbe continuato anche dopo la Seconda Guerra. Con i suoi libri la Morelli ha in qualche modo descritto cinquant'anni di vita italiana. Un'autrice molto amata fu Moretti Foggia Della Rovere (1872‑1947), che curava una rubrica gastronomica seguitissima sulla Domenica del Corriere. La sua prima opera fu Ricette di Petronilla, che pubblicò nel 1935 a 63 anni.
Tra le autrici più vicine all'Artusi, per successo, oltre che per l'accortezza nel tenere in conto i consigli delle lettrici ― con cui comunicava anche tramite la rivista Preziosa, da lei fondata nel 1915 ― ci fu Ada Boni, nipote di Adolfo Giaquinto, fondatore del Messaggero della Cucina e autore di molte opere di gastronomia. Nel 1925 avrebbe pubblicato il Talismano della felicità, che sarebbe passato dalle 600 pagine alle 1200 negli anni Settanta, in cui vengono proposte ricette presentate in maniera molto chiara. Non si dimentichino poi le varie Giorgina, Donna Mimma, Zia Carolina, Ada Bonfiglio, Emilia Zamara e tante altre autrici di un'epoca che, insieme alle ricette in onore del Regime, avrebbe visto il tramonto dopo la seconda guerra mondiale.
3. La cucina italiana del Settecento
Il Settecento fu un secolo di grandi cambiamenti anche in campo culinario: l'uso delle carni diminuì e si diffuse quello del grano, ma soprattutto del granturco e, solo più tardi — dopo aver superato una forte diffidenza — della patata, dalla quale si iniziò a ricavare anche una farina con cui produrre la pasta. Inoltre, aumentò l'uso del burro — base fondamentale delle salse, immancabili nei pranzi settecenteschi. Si affermarono poi nuove bevande, che affiancarono e sostituirono vino e birra: cioccolato, tè e caffè.
La distillazione dell'alcool, poi, portò all'uso dei distillati di melassa (rum); di frutta (calvados, kirsch, maraschino, ecc.); di cereali (vodka, whisky, gin, ecc.), e dei liquori dolci (in particolare rosolio, ratafià). Ma ciò che costituì proprio una rivoluzione fu, a partire dalla seconda metà del Seicento, l'abbandono graduale dell'uso delle spezie, mantenendo soltanto la cannella e poche altre, e prediligendo invece l'erba cipollina, lo scalogno, i funghi, i capperi, le acciughe. Tutto ciò avvenne sulla base di un nuovo tipo di cucina che distinse i sapori agro e dolce — fin dal Medioevo mescolati assieme — anche attraverso un uso più contenuto dello zucchero, con cui ci si limitò a confezionare preparazioni di credenza da presentare a fine pasto. Questa era dunque la nuova cucina, già prospettata da La Chapelle nel suo Cuisinier moderne (1735) e formulata nella sua totalità a partire dalla pubblicazione, nel 1739, dei Dons de Comus ou les délices de la table attribuito a un certo Marin. Proprio nella prefazione di quest'ultimo ricettario si legge quello che si può definire il manifesto della nouvelle cuisine.
Fu così che nel Settecento le élites francesi, con le loro scelte, influenzarono tutto il panorama europeo, almeno nelle regioni occidentali, come Italia e Spagna. Tra le mode legate al mangiare, le più diffuse furono il mangiare 'pitagorico' (vegetariano) e il bere 'in neve', ossia gelato. Per ciò che riguarda l'apparecchiamento della tavola, le regole si erano semplificate, come dimostrato dalla riduzione dei 'servizi' (le parti che componevano il pasto). Inoltre, emergono altre tipologie di pasto, più veloci, ma pur sempre di gran figura, come i pranzi o le cene in ambigù («vale a dire tutto in una portata senza Zuppe quante volte il Padrone non le ordini espressamente»).
Un altro fenomeno in voga a Parigi, la città che all'epoca dettava la regola in materia di raffinatezze, era quello di fare una sorta di piccolo pranzo a metà giornata, per poi pranzare realmente la sera. Di questo Leonardi, però, dice: «Quello forse a cui gl'Italiani non sapranno uniformarsi, sarà quello dico, di Pranzare la sera; mentre nella nuova maniera di servire le Tavole si è introdotto anche il costume di fare la mattina verso il mezzo giorno una colazione (Dejeunè), e poscia la sera, o prima, o dopo il calar del sole, Pranzare, essendosi trovato questo tempo più comodo per gli Uomini di Grandi affari».
3.0. «L'ancienne cuisine était fort compliquée et d'un détail infini»
«L'ancienne cuisine était fort compliquée et d'un détail infini. La cuisine moderne est une espèce de chimie. La science du cuisinier consiste à décomposer, à faire digérer et à quintessencier les viandes, à tirer des sucs nourrissants et pourtant léger, à les mêler et à les confondre ensemble de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir […]. L'excès d'épices dans l'assaissonnement est l'écueil mediocre plus précieux que l'or quand on les emploie à propos, mais vrais poisons quand on les prodigue, doivent être ménages comme l'or même et dispensés par une main légère que l'intelligence conduise. Sans cela, plus d'onction dans ce que vous faites, vous ruinez tout le fruit d'un long travail […]. Il faut, en satisfaisant la nature, écouter la raison et se ménager dans les plaisirs memes les moyens de les render durables en évitant la satiété».
3.0.1. Il mangiare 'pitagorico'
Il mangiare 'pitagorico', ossia vegetariano, nel Settecento non riguardò più soltanto i poveri, obbligati a non mangiare carne dalle misere condizioni economiche, ma anche i ricchi, in quanto nel secolo dei lumi, la dieta basata sull'uso di vegetali e ortaggi venne proposta come un'alternativa «igienica, leggera e intelligente», nonché illuminata, alla dieta aristocratica dell'età dell'Assolutismo. Come ha notato Montanari, «l'appetito gagliardo e l'abbondanza di carne — antichi segni di forza, di potere, di nobiltà — non furono più oggetto di unanime apprezzamento sociale».
A conferma, si pensi alla pubblicazione nel 1743 dell'opera Del Vitto pitagorico per Uso della Medicina (Firenze, Moucke) del medico toscano Antonio Cocchi, e del libro Del cibo pitagorico ovvero erbaceo per uso de' nobili, e de' letterati di Vincenzo Corrado (Napoli, Raimondi, 1781). Che questa moda del "cibo pitagorico" non fosse rimasta solo teoria lo dimostra proprio un personaggio per il quale lavorò Leonardi: il cardinale François-Joachim de Pierre de Bernis. Egli, infatti, in una lettera inviata a Vincenzo Corrado per commentare positivamente Il Cuoco galante, che conteneva una sezione dedicata al Vitto Pitagorico in cui si trovavano più di cento piccole ricette vegetariane, scrisse: «Io veramente di questo Pitagorico Cibo faccio uso da molti anni a questa parte» (La lettera, datata 12 gennaio 1780). Oltre a questo, anche nell'Apicio moderno c'è una sezione di ricette (Dell'Erbe di Magro, tomo VI, pp. 185-206, 207-217) divisa in due, la cui prima parte — che contiene le ricette imbandite per il cardinale — si apre con queste parole: «Principierò questo articolo dall'erbe solite mangiarsi dal già Eminentissimo Cardinale de Bernis, le quali termineranno, ove dice Tartufi al Vino rosso di Spagna, e che possano servire ancora per Antremé». Se però a "pitagorico" si facesse equivalere "poco sofisticato", sarebbe sbagliato. Le 97 ricette dell'Apicio, infatti, lo dimostrano, essendo quasi tutte di frittura, o di erbe ripassate e ben pepate.
3.1. Le prime traduzioni dei ricettari francesi
La letteratura gastronomica italiana del Seicento aveva visto una ricca produzione di testi di scalcheria (relativi alla gestione della casa) e dell'arte del trinciare le carni, ma non di ricettari veri e propri. A partire dagli ultimi decenni del Seicento si iniziarono a produrre traduzioni di testi francesi, come quella del Cuoco francese ove è insegnata la maniera di condire ogni sorta di vivande, che si proclamava traduzione dell'opera di François de La Varenne (Le Cuisinier françois del 1651).
Sempre a Bologna nel 1724 uscì la libera traduzione del Cuisinier royal et bourgeois di François Massialot, pubblicata col titolo Il cuoco reale e cittadino. Ma il testo che avrebbe costituito la svolta nella produzione editoriale italiana, perché primo a promuovere la "nuova cucina", sarebbe stato Il Cuoco piemontese perfezionato a Parigi, traduzione rimaneggiata della Cuisinière bourgeoise di Menon, pubblicato anonimo nel 1766 a Torino (editore B.A. Re, C.G. Ricca tipografo, un volume in 12°), che fin dal titolo fa emergere una tendenza che si sarebbe affermata nell'Ottocento: la fioritura di testi che promuovono patrimoni gastronomici regionali. Sempre dallo stesso testo francese sarebbe poi derivata, con riferimenti anche ad altri numerosi testi francesi, La Cuciniera piemontese che insegna con facil metodo le migliori maniere di acconciare le vivande sì in grasso che in magro secondo il nuovo gusto, pubblicata a Vercelli, presso Beltramo Antonio Re, nel 1771 (un volume in 12°). Mentre il Cuoco piemontese ha una struttura del tutto definita in capitoli, in cui alle zuppe e minestre seguono le carni (bue, vitello, maiale, montone, agnello, pollame, cacciagione) e i pesci, i legumi e gli ortaggi, le uova, burro e formaggio, l'uso delle spezie, le creme, le frittelle, la pasticceria, ecc., nella Cuciniera piemontese non sembra si segua un ordine definito, e le ricette che nell'indice sono ordinate alfabeticamente si trovano poi sparse nel testo.
Spostandoci in Toscana, nel 1772, presso Stecchi & Pagani, fu stampato a Firenze L'economia della città e della campagna ovvero il cuoco italiano secondo il gusto francese, libero adattamento del Soupers de la cour di Menon. I suoi tre tomi sono così divisi: nel primo sono presenti ricette di brodi, zuppe e salse, oltre che di vitello e uova; nel secondo troviamo ricette di carni (tra cui ancora il vitello) e terrine (pietanze preparate in recipienti circolari o rettangolari, di ceramica con bordi alti); nel terzo sono inserite ricette dell'arte del credenziere (chi si occupa della pasticceria).
Per quanto riguarda la produzione originaria italiana, va ricordata l'Oniatologia ovvero il discorso dei cibi, in quattro tomi (1785 e il 1794 per l'editore Pagani), primo esempio di ricettario pubblicato a dispense, al quale l'editore fiorentino Giuseppe Luchi contrappose nel 1793 Il cuciniere all'uso moderno, sempre a dispense, copia rimaneggiata dell'Oniatologia.
Altri testi da ricordare sono Il Cuoco maceratese di Antonio Nebbia che insegna a cucinare ogni sorta di vivande, tanto di grasso che di magro (Macerata, Dalle stampe di Luigi Chiappini, ed Antonio Cortesi, 1781, un volume in ottavo), e Il Cuoco galante, opera meccanica dell'oritano Vincenzo Corrado (Napoli, stamperia Reimondiana, 1773, un volume in quarto).
3.1.1. Per un confronto
Per un confronto, si veda la ricetta dell'originale francese della Cuisinière (Parigi, presso P. M. Nyon le jeune, 1788, p. 59, Abrégé général pour toutes sortes de Potages) e il corrispettivo Ristretto generale per ogni sorta di minestra e zuppa del Cuoco Piemontese:
Prenez la Viande la plus saine & la plus fraîche tuée, pour qu'elle donne plus de goût à votre bouillon; la plus succulente est la tranche, la culotte, les charbonnades, le milieu du trumeau, le bas de l'aloyau, & le giste à la noix: les pieces les plus propres à servir sur table, sont la culotte & la poitrine. Ne mettez du veau dans vos bouillons que pour quelque cause de maladie. Quand votre viande est bien écumée, salez votre bouillon, mettez dans la marmitte de toutes sortes de legume bien épluchés, ratissés & lavés, comme céleri, oignons, carottes, panais, poireaux, choux; faites bouillir doucement votre bouillon jusq'à ce que la viande soit cuite; passez-le ensuite dans tamis, ou dans une serviette; laissez reposer le bouillon pour vous en serviràce que vous jugerez à propos. Il faut six heures de cuisson pour une piece de boeuf de six livres, & huit pour une de douze à quatorze. Ayez soin de ficeler les légumes pour les retirer entiers, ils vous serviront à garner les potages.
Prendete della carne la più fresca e la più sana, affine che sia più gusto al vostro brodo, e la più sugosa è la culotta, il mezzo della gamba del bue, il basso della costa. I pezzi più propri a servire sopra la tavola sono la culotta ed il petto del bue, bisogna guardarsi dal mettere del vitello nei vostri brodi, fuorché per cagione di malattia: bene schiumata la vostra carne salarete il brodo e metterete nella pignatta ogni sorta di ortaggi ben mondati e lavati, come sceleri, cipollette, carotte, porri, conosca ssere cotta la carne, in seguito lo colarete in una stamigna o in un panno lino, bisogna lasciar riposare il brodo per servirsene nei bisogni. Per un pezzo di bue di sei libre vi vogliono sei ore di cottura, e otto per uno di dodici o quattordici libre. Procurate di legare gli ortaggi per poterli ritirare intieri, per servirvene ad ornare le minestre. (da Silvano Serventi, a cura di, Il Cuoco piemontese perfezionato a Parigi, Società Studi Storici di Cuneo, Società Storica Vercellese, in collaborazione con Slow Food Editore, Milano, 1995, ristampa anastatica dell'ed. uscita presso Carlo Giuseppe Ricca stampatore vicino a S. Rocco, Torino, 1766, p. 95).
Meno fedele, invece, è La Cuciniera piemontese, che nel Ristretto generale per ogni sorta di Minestra, e Zuppa elimina i dettagli finali sul tempo di cottura in relazione alla quantità di carne presenti nell'originale e si aggiungono altri consigli pratici, come quello di tener coperta la carne col brodo durante la cottura, per non farla annerire:
Penderete della Carne la più fresca, e la più sana, affinchè dia più gusto al vostro brodo; la più sugosa si è la Culatta, la punta della Spalla, ed il sottolombo del Manzo; i pezzi più buoni per servire in tavola fono la Culatta, ed il Petto: conviene guardarsi però di mettere la Vitella nei vostri brodi insieme col Manzo, mentre la medesima non può reggere nei bollire, a motivo che quando il Manzo farà arrivato alla sua cottura, la Vitella sarà trapassata, e non ne potrete ricavare verun profitto, e perciò sarà meglio di metterla a parte, abbenchè quella non ad altro sia buona che per umidi, per sughi, e Colì: onde bene schiumata che sia la vostra Carne, vi metterete pochissimo sale, e farete un manipolo di erbe, cioè cipollette, un sellero, un porro, una Carota, e le farete bollire nella vostra Marmitta, e che le suddette erbe siano ben legate per poi levarle a suo tempo, ed il vostro brodo lo farete bollire lentamente fino a tanto che si conosca esser cotta la Carne; in seguito lo colarete in una stamigna, o in un pannolino, e di poi lasciarlo riposare per poi servirvene per i vostri sughi, e colì; conviene guardarsi però, che il vostro allesso, a cui avete levato il brodo, non resti senza brodo, perchè vi diventarebbe nero, e sporco; e perciò vi conviene tenere altro brodo, benché sia di giunte della Carne, purché sia ben polito, e può darglisi l'istesso gusto di quello del Manzo, a cui avrete levato il brodo, e questo si sa, acciocché il Manzo, di cui dovete servirvi per la tavola, non diventi né nero, né insipido; se poi voleste fare una zuppa di buon Cappone… da La Cuciniera piemontese che insegna con facil metodo le migliori maniere di acconciare le vivande sì in grasso che in magro secondo il nuovo gusto, Vercelli, Re, 1771 (ed. di Torino, Soffietti, 1798, pp. 5-6).
3.2. Francesco Leonardi
Francesco Leonardi descrive quelle che furono le tappe fondamentali della propria vita lavorativa nella parte finale della prefazione dell'Apicio moderno: «Io benché Italiano ho fatto il mio noviziato nelle cucine Francesi, e particolarmente in Parigi, in quella del fu Maresciallo di Richelieu; in Napoli in quella del fu Principe di Francavilla [Michele Imperiali Principe di Francavilla (1719-1782); grande mecenate visse dal 1755 al 1777 a Napoli, alloggiando nel Palazzo Cellammare], Cucina del tutto Francese; ho travagliato in diverse campagne di Luigi XV., ho viaggiato per lo spazio di sei anni in una gran parte dell'Europa al servizio di S.E. GIO: Schouvaloff Gran Ciamberlano di S.M.I., al quale sono anche debitore di avere veduto la Capitale della Russia, avendomi egli chiamato in S. Pietroburgo nel 1778., ove sono stato Maestro di Casa di S.A. il Principe Gregorio di Orloff; e finalmente Cuoco, e Scalco di S.M. l'Imperatrice di tutte le Russie Caterina II., che con mio sommo rammarico, e discapito dovetti lasciare a cagione dell'eccessivo freddo del clima nocivo alla mia salute, onde posso dire di aver veduto, ed in conseguenza potuto distinguere, imparare, e lavorare, e rendo ai Maestri dell'arte quella giustizia, che è lor pur troppo dovuta» (I, xxiv-xxv).
Ricordando anche il servizio prestato per il Cardinale de Bernis — citato più volte nell'Apicio — Leonardi inserisce nei propri testi riferimenti puntuali alle proprie esperienze, utili ad avvalorare la veridicità delle affermazioni che si trovano nella prefazione. Inoltre, nel suo Dizionario ragionato degli alimenti (1795) sono molti i riferimenti al suo soggiorno in Russia e ai costumi italiani: («ho io veduto in Pietroburgo la matina essere il freddo a dieci o dodici gradi al di sopra del gelo, e durante il giorno crescere a venti e venticinque, onde taluno ch'era sortito con un semplice rendi gotto di panno prendersi un rafreddore, che colà chiamano in Francese Rafroidissement, e cessare di vivere in termine di due o trè giorni»; «In altri tempi le Nazioni straniere prendevano dagli Italiani la maniera di vestirsi: ora non si sa comprendere il perchè, questi stessi Italiani vogliano imitare il vestimento de' popoli oltramontani, senza riflettere alla diversità de' climi»).
Morto a Roma nel 1824, a ottantotto anni, dovette occuparsi di cucina fin dalla più tenera età e, come un appassionato che desiderava scrivere, oltre che operare ai fornelli, supplì alla sua mancanza di preparazione letteraria con l'osservazione e la lettura dei buoni autori, come egli stesso spiegò.
3.2.1. «Recherà certamente maraviglia di non vedere il nome di un qualche dotto...»
«Recherà certamente maraviglia di non vedere il nome di un qualche dotto, ed esperimentato medico [come autore del Dizionario degli alimenti…]. Questo difetto è in vero grande, imperocchè l'opinione può molto in tutto, e specialmente in produzioni letterarie. Ho procurato perciò di supplire al medesimo con le ricerche, con l'assidua applicazione, con la scelta de' buoni autori, e con la lettura de' loro libri. […] mentre il buon discernimento, ed i talenti possano svilupparsi egualmente in ogni individuo, […]. Il mondo da me veduto, l'avere dimorato per molti anni ne' paesi stranieri, l'essere andato in traccia dei prodotti benefici della Natura, l'averli esaminati con curiosità e precisione, specialmente in ciò che riguarda gli Alimenti […] vi ha non poco contribuito [alla formazione]; inoltre la lettura di parecchi Autori, che hanno trattato queste materie, e quella della medicina assai dottamente, e da me prediletta, ha occupato il più gran tempo della mia vita. Non è stato certamente un'effetto di vanità, o di amor proprio, che mi abbia posto la penna in mano, ma bensì uno spirito di occupazione, ed un vivo desiderio di applicarmi ad uno studio, che ha formato mai sempre la mia maggiore delizia».
(da Leonardi Francesco, Dizionario ragionato degli alimenti in cui si tratta dell'Origine, Natura, Nomi, Uso, Abuso, Scelta, Stagioni, Preparazioni, Effetti, Qualità e Proprietà di ogni sorta di Cibi, e di Bevande, e dei Mezzi Semplici, onde conservarsi in Sanità, e tenere lontane le Malattie, nella Stamperia di Paolo Giunchi. Con Licenza de' Superiori. Roma 1795, in 8°, vol. I (A-BAG), vol. II (BAG-CED), vol. III (CEF-ESE), tomo I, pp. v-vj).
4. La cucina italiana e la "grande cuisine"
Alla voce Cucina dell'Encylopédie, Louis Jaucourt attribuisce ai cuochi d'oltralpe la colpa di aver diffuso la passione per il cibo e le tecniche per soddisfarla: «Gli italiani hanno ereditato per primi i residui della cucina romana; sono loro che hanno fatto conoscere ai francesi la buona tavola, di cui molti nostri re tentarono con editti di reprimere l'eccesso; ma alla fine essa ebbe il sopravvento sulle leggi sotto il regno di Enrico II; allora i cuochi di quel paese transalpino vennero a stabilirsi in Francia, ed è questa una delle cose di cui siamo debitori a quella torma di italiani corrotti che servivano alla corte di Caterina de' Medici».
Nasce, così, la leggenda secondo la quale la cucina italiana sarebbe entrata alla corte di Parigi tramite i cuochi che Caterina de' Medici portò al suo seguito una volta diventata sposa nel 1533 di Enrico di Valois, duca di Orléans, re di Francia dal 1547.
Come affermato da Massimo Montanari, però, «I cuochi italiani potevano ben essere stati dei maestri in Europa, ma ciò che insegnavano (il profluvio di spezie e di zucchero, la mescolanza del dolce e dell'agro) era ancora profondamente legato alla cultura medievale dell'artificio, che proprio sulle tavole dell'Italia rinascimentale raggiunse il più alto grado di perfezione. La perizia tecnica di uno Scappi è fuori discussione, ma il rinnovamento gastronomico francese del XVII secolo si basò su princìpi radicalmente opposti: il rifiuto dell'artificio e delle combinazioni agrodolci, il drastico ridimensionamento delle spezie, l'invenzione di salse a base grassa anziché acida, la ricerca di sapori "naturali". I ricettari italiani del Quattro‑Cinquecento, e i cuochi che li scrivevano o li usavano, non possono essere ritenuti il "modello" di una cucina che si svilupperà su basi teoriche e pratiche del tutto diverse, anzi contrarie. […] Eppure, un contributo l'Italia lo diede. Su un piano diverso, però. Vari studiosi convengono infatti nel riconoscere che l'apporto più significativo riguardò i prodotti più che il gusto. Uno dei caratteri di novità della cucina francese del XVII secolo fu la scelta di valorizzare, contro l'enfasi carnivora della cucina medievale, le verdure e gli aromi dell'orto ‑ una tradizione che soprattutto la gastronomia italiana aveva elaborato e tramandato attraverso i secoli».
Le due cucine, quella francese e quella italiana, dunque, che si influenzarono l'una con l'altra, fino al prevalere, nel XVIII secolo, della prima sulla seconda, si influenzarono vicendevolmente nel tempo. Inoltre, l'importanza stessa data al banchetto doveva essere di diverso grado, come fanno emergere le considerazioni di viaggiatori dell'epoca, come Lalande e Valery.
4.1. Lalande e Valery
Così scrisse Lalande: «La magnificence de ces grandes Maisons [Colonna, Orsini, Barberini, Borghese, Chigi, ecc.] consiste principalement de pàges, de coureurs, de laquais, de caveau, de carrosses; des tableaux précieux & de belles flautes antiques & modernes. Ce n'est ni dans la bonne chere, ni dans le luxe des habits, que leur somptuosité se déploye. On ne donne à manger que raramente & dans de grande occasions; il faut en excepter les Villegiatures, où l'on fait de la dépense; car enfin il faut bien que le revenu des Maisons, qui sont très-riches, soit employé à quelque chose. Ces Maisons riches sont très rares; même parmi les Princes; les autres n'ont qu'un superflu qui peut se consumer aisément par deux ou trois fêtes d'appareil, queleque nôce…» (Lalande Jérôme, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766, a Venise et se trouve a Paris, chez Desaint, 1769, vol. V, p. 130).
Anche Valery, proprio nel capitolo riguardante Roma scriveva: «Cepandand les Italiens dont sobres. La vie des grands est même assez frugale. Les tables diplomatiques, celles de quelques financieres, son à peu près les seulesque l'on cite» (Valery Antoine Claude Pasquin, L'Italie confortable, manuel du touriste, appendice aux voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie, Renuard, Paris 1791, p. 189).
Di lì a quella parte, l'importanza del banchetto come status symbol sarebbe passato nelle mani delle famiglie borghesi, alle quali si iniziarono a dedicare ricettari a partire proprio dal XVIII secolo.
5. I glossari nei ricettari italiani
In Francia prima che in Italia si sviluppò una nuova classe sociale, quella borghese, che, pur non dovendo dare grandi pranzi di rappresentanza, teneva comunque ad avere un decoroso pranzo ordinario e non voleva rinunciare alla raffinatezza in occasione di modesti ricevimenti. Proprio la sua nascita potrebbe essere una delle cause della rinascita della produzione culinaria, come fanno pensare i sottotitoli dei testi pubblicati. Se, infatti, per i testi usciti a fine Seicento il borghese sembra essere, per importanza, solo la terza parte di pubblico dopo i "Grandi" (i ricchi signori presso i quali i cuochi-scrittori lavoravano) e i professionisti, col passare del tempo le cose cambiarono, come dimostrano le parole di Menon nei Soupers de la cour (1755): «ce n'est plus pour les nobles que l'on écreit mais pour les bourgeois».
Se invece si guarda all'Italia, a parte il proseguimento del titolo («et instruire i men periti in questa lodevole professione») del ricettario seicentesco di Bartolomeo Stefani, L'arte di ben cucinare (1662), i cambiamenti sarebbero avvenuti con più lentezza. Il pubblico, però, stava cambiando, come dimostrato dall'inserimento nei ricettari dei glossari. Si tratta di una novità settecentesca, di probabile importazione francese (la Cuisinière bourgeoise di Menon già presentava delle liste di spiegazioni), che si sarebbe diffuso nei testi di cucina ottocenteschi fino a ritrovarlo nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene («VOCI che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero»).
Tra i ricettari settecenteschi, quelli in cui si ritrovano glossari sono: Il Cuoco piemontese; La Cuciniera piemontese; Il Cuoco galante e L'Apicio moderno di Leonardi, cui seguono Gianina ossia la cuciniera della Alpi e Il Cuoco perfetto dello stesso autore. Da un punto di vista del contenuto, confrontando le voci presenti nei glossari, emerge la volontà di fornire il significato di termini visti come troppo tecnici, e di difficile comprensione, poiché molti di derivazione francese. Da un punto di vista formale, invece, tutti i glossari — con la sola eccezione del Cuoco piemontese, il cui glossario riprende quello della Cuisinière bourgeoise — non presentano le voci in ordine alfabetico. Per quanto riguarda le definizioni, quelle del Cuoco galante sono brevi ma efficaci; particolareggiate sono quelle del Cuoco piemontese, e complete — perché seguite dalle ricette esplicative — quelle dalla Cuciniera piemontese.
Le spiegazioni dell'Apicio moderno, invece, sono più complesse, in quanto l'autore dà definizioni più o meno complete e lunghe a seconda del termine. Se, per esempio, Leonardi si sofferma a fornire più di un sinonimo esplicativo per i verbi (per esempio Legare, legata, legherete sul fuoco, significa fare stringere, rendere denso, ovvero infittire, rendere spessa, o densa una salsa, o altro; Passare, passate, passerete sul fuoco, significa soffriggere, soffriggerete, fate soffriggere), per alcuni nomi, invece, fornisce significati del tutto generici (per esempio «Bresa, significa condimento per cuocere Carni, Pesci, Erbe ec.», «Fricandò, significa qualunque sorta di Carne, o Pesce piccato di lardo, o in altra maniera», «Senteminult, Salsa, o Brodo, così nominato»), mentre per altri dà direttamente una spiegazione più tecnica (p. es. «Carbonata, vivanda di Castrato con Cipolle»; in francese il significato era genericamente 'viande grillée' secondo la definizione datane da Jean-François Féraud nel Dictionaire critique de la langue française, 1787-88, s.v. carbonade; Leonardi identifica la parola direttamente con un tipo particolare di preparazione). I glossari dell'Apicio, del Cuoco Piemontese, della Cuciniera Piemontese e del Cuoco Galante presentano molti termini in comune.
5.1. "Il Cuoco Piemontese": "Spiegazione per ordine alfabetico di vari utensili di cucina e di credenza"
Nella Spiegazione per ordine alfabetico di vari utensili di cucina e di credenza nel Cuoco piemontese, dedicata solo agli utensili, si elencano:
- Braggiera, cafettiera, campana, casseruola, compostiera, coltelli, cucchiaro, cioccolatiera, forno, forma, gira-arrosto, graticola, grattugia, lardaiuola, marmitta, molino, mortaio, opianatoio, padella, piatti, poessonière, plafon, schiumora, stufa, stamigna, spiedo, spatola, siringa, timbale, treppiè, tamburo, tortiera.
5.2. "La Cuciniera piemontese": "Spiegazione di certe parole che anche francesi s'usano in Italia"
La Spiegazione di certe parole che anche francesi s'usano in Italia, col modo d'allestire alcune vivande inserito nella Cuciniera piemontese comprende le seguenti voci:
- Braise, salpicon, court bouillon, fricandeaux, daube, hors d'oeuvres, entremets, o sia tramezzo, ragout, capitolade, gigots, hachis, menus droits, remolade, brezzole, rovelle, issue, hatelettes, blanc-manger, julienne, piquatoche, godiveau, andoville di porco, mignonnette, galimafrée.
5.3. "Il Cuoco galante": "Spiega di alcuni termini cucinarj per la manipolazione delle Vivande"
Nella Spiega [sic] di alcuni termini cucinarj per la manipolazione delle Vivande, e per la facile maniera d'intendere, e di servire del Cuoco galante, si elencano:
- bianchire, passare, barda, bardare, inviluppare, arrossare, stagionare, piccare, farsa, farsire, adobare, bucchè, salza, colì, purè, sapore, entrèe, hors-d'oeuvre, entremets, rilevè.
5.4. "L'Apicio Moderno": "Spiegazioni di alcuni Termini Francesi, ed italiani usitati nella Cucina"
Le Spiegazioni di alcuni Termini Francesi, ed italiani usitati nella Cucina, dei quali l'Autore si è servito nella composizione di quest'Opera inserite nell'Apicio, sono:
- Passare, passate, passerete sul fuoco; Gratinare, gratinato, gratinate sul fuoco; Legare, legata, legherete sul fuoco; Liason; Mittonare, mittonate, mittonerete; Carne rosolata del sugo; Fiore di latte; Zeste d'Arancio, Limone ec.; Le coperte; Coprire la tavola; La Tavola scoperta; Minute de' pranzi; Una tavola servita; Primo, e secondo servizio; Antrè, Orduvre, Antremè. Sempre nell'Apicio, nel VI tomo è presente la Spiegazione generale De' Termini Francesi: Sugo, Culì, Consomè, Restoran, Suage, Bresa, Aspic, Tablette, Glassa, Poele, Purè, Ragù, Salpiccone, Ascì, Farsa, Fricandò, Fricassè, Chenef, Matelotta, Carbonata, Aricò, Salmì, Composta, Etuvè, Escaloppe, Emensè, Ruladine, Filetto, Filetti mignoni, Sella, Rot-de-Bif, Filetti di Pesci, Atelette, Tartelette, Rissole, Carrè, Cotelette, Piccare, Lardare, Ambigù, Trussare, Fiambare, Spilluccare, Imbianchire, Panate, Senteminult, Epluche, Asce, Piccante, Farsire, Vol o vant, Malbrè, Galantina.
5.5. Confronto tra glossari
Dal confronto fra i glossari emerge che i termini condivisi riguardano principalmente il servizio, ossia le portate (per esempio entremets e hors-d'oeuvre). Se, però, nei testi piemontesi si tiene a rispettare la grafia francese, nell'Apicio e nel Cuoco Galante, la grafia viene modificata, per adattarla alla pronuncia italiana. Tra i termini condivisi dal noto ricettario di Corrado e da quello di Leonardi — a parte farsa, farsire, passare, piccare e purè — merita attenzione la coppia colì/culì, in quanto attesta un fenomeno molto comune: l'esistenza di forme diverse di adattamento fonetico-grafico di uno stesso termine.
Più generalmente, tralasciando i due glossari del Cuoco piemontese e della Cuciniera piemontese, troppo vincolati al modello francese della Cuisinière, una delle voci più rilevanti del glossario del Cuoco galante è bucchè (definito da Corrado 'mazzetto d'erbe aromatiche che si fa bollire nelle vivande'), termine entrato in italiano fin dalla fine del Seicento e presente, sotto diverse forme, in più di un dizionario dialettale. In questo caso la forma bucchè, corrispondente a quella registrata dal Puoti nel Vocabolario domestico napoletano e toscano (1841), mostra l'esito sicuramente popolare dell'originale francese bouquetomo
Per quanto riguarda le definizioni e il loro stile, si osservino quelle di entrée; blanchir; coulis; farce; farcir; passer; piquer; purée, presenti nell'Apicio e nel Cuoco galante:
- (Apicio moderno) «Antrè, Orduvre, Antremè, e diversi altri nomi Francesi servono per l'ordine, e la distribuzione delle vivande».
- (Cuoco galante) «Entrèes = Vivande di primo servizio».
- (Cuoco galante) «Bianchire = Far per poco bollire in acqua quel che si vuole».
- (Apicio moderno) «Imbianchire, all'acqua bollente, significa prolessare, o allessare qualunque cosa».
- (Cuoco galante) «Colì = Denso brodo estratto dalla sostanza delle carni».
- (Apicio moderno) «Culì, significa Brodo legato».
- (Cuoco galante) «Farsa = Pastume di carne, uova, grasso, ec.».
- (Apicio moderno) «Farsa, significa Carne qualunque, Pesce qualunque, Erba qualunque, pesta, o passata al setaccio».
- (Cuoco galante) «Farsire = Riempire cosa con la farsa».
- (Apicio moderno) «Farsire, significa riempire».
- (Cuoco galante) «Passare = Far soffrigger cosa in qualsisia grasso».
- (Apicio moderno) «Passare, passate, passerete sul fuoco, significa soffriggere, soffriggerete, fate soffriggere».
- (Cuoco galante) «Piccare = Trapassar esteriormente con fini lardelli carne».
- (Apicio moderno) «Piccare, è una specie di recamo, che fassi con piccioli lardelli di lardo tagliati assai regolarmente, e un ago, sopra a qualunque sorta di Carne, o Pesce. Si può piccare ancora con filetti di tartufi, di carote, con fusti di petrosemolo ec.».
- (Cuoco galante) «Purè = Condimento che si estrae dai lecumi, o d'altro».
- (Apicio moderno) «Purè, è questo un Brodo legato con Erbe, o Legumi per qualunque Zuppa, o Salsa».
6. Pellegrino Artusi
Pellegrino Artusi nasce a Forlimpopoli il 4 agosto 1820, da Agostino e Teresa Giunchi. Dopo gli studi nel seminario di Bertinoro, e un periodo di studio a Bologna, Artusi torna nella cittadina romagnola di origine per occuparsi dei commerci della drogheria di famiglia. Nel 1851, poco più che trentenne, in seguito all’irruzione a Forlimpopoli della banda del brigante Stefano Pelloni (detto il “Passatore”), si trasferisce a Firenze con i suoi familiari, e qui continua l’attività commerciale rilevando un banco di tessuti di seta. Grazie al successo raggiunto col commercio, conduce una vita agiata, dedicando il proprio tempo libero alle sue passioni: la letteratura e la gastronomia. Nel 1870, cinquantenne, Artusi si ritira dagli affari e si trasferisce in una nuova casa (in p.zza d’Azeglio 25), insieme ai suoi domestici, tra i quali si ricordano in particolare gli ultimi, Marietta Sabatini pistoiese e Francesco Ruffilli romagnolo, entrambi anche artisti culinari.
Nella sua bella casa di Firenze, Artusi possedeva una ricca biblioteca, i cui volumi ci danno conto della vastità ed eterogeneità degli interessi culturali del padrone di casa. In essa trovavano posto le opere della tradizione classica italiana (dalle Origini all’Ottocento) e della letteratura toscana e fiorentina, ma anche le opere di lingua e i dizionari, tra i quali figurano il Vocabolario Italiano della lingua parlata di Giuseppe Rigutini e Pietro Fanfani, nell’edizione fiorentina di Barbèra. La biblioteca, oggi ricostruibile solo in parte a causa della significativa perdita materiale dei volumi che il fondo ha subito nel tempo, è ospitata nella Biblioteca Civica di Forlimpopoli, intitolata alla sua memoria in virtù di una clausola del testamento dello stesso Artusi, secondo la quale tutti i libri che venivano donati al Comune dovevano servire come «fondamento e principio alla formazione di una pubblica biblioteca da istituirsi a Forlimpopoli».
E proprio attraverso il continuo esercizio letterario e la consultazione delle opere lessicografiche Artusi forma la sua lingua , così ben rappresentata nell’opera che lo ha reso noto a generazioni di italiani e soprattutto di italiane: La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, un manuale di cucina e una raccolta di ricette che Artusi scrive e pubblica a sue spese nel 1891 (prima edizione: 1.000 copie).
Negli anni precedenti Artusi si era esercitato anche come scrittore, scrive ndo alcuni saggi letterari, tra i quali una biografia di Foscolo (Vita di Ugo Foscolo. Note al carme dei Sepolcri. Ristampa del Viaggio sentimentale di Yorick tradotto da Didimo Chierico, 1878) e un commento alle lettere del Giusti (Osservazioni in appendice a trenta lettere di Giuseppe Giusti, 1881), senza però ottenere alcun successo. Di Artusi rimane anche una Autobiografia, scritta nel 1903, ma pubblicata postuma solo nel 1993.
Pellegrino Artusi, scapolo e senza figli, muore novantenne a Firenze il 30 marzo 1911.
6.1. La Forlimpopoli di Artusi
In onore del suo concittadino più illustre, la città di Forlimpopoli, con la collaborazione di Casa Artusi, il primo centro di cultura gastronomica legato alla cucina domestica, organizza ogni anno la Festa Artusiana, una grande manifestazione sul cibo e sulla cultura gastronomica italiana. Durante la “Festa” si offrono ai partecipanti menù ispirati alla cucina di Artusi, si organizzano laboratori di cucina, itinerari gastronomici e incontri con gli esperti del settore.
Nel corso della manifestazione vengono assegnati il Premio Artusi e il Premio Marietta: il primo viene attribuito ad un personaggio che, a qualsiasi titolo, si sia distinto per l’originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo; il secondo, intitolato alla fedele cuoca di Pellegrino Artusi, al miglior cuoco o cuoca (non professionisti), la cui ricetta sia ispirata, sia per gli ingredienti sia per la tecnica di preparazione, alla cucina artusiana.
La Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli conserva, su supporti cartacei e digitali, le 15 edizioni curate direttamente dall’autore dal 1891 al 1911, anno della morte, oltre a numerose traduzioni del libro in altre lingue.
6.2. La lingua della "Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene"
Il merito di aver fondato una gastronomia moderna e di averle dato una lingua chiara e limpida spetta certamente a Pellegrino Artusi, che con le ricette della Scienza in cucina e l’Arte di mangiare bene ha unito l’Italia e gli italiani, a tavola.
Il manuale di Artusi non è dunque un libro di cucina come tanti altri. È infatti un libro che segna un profondo cambiamento rispetto al passato: nuovi sono i contenuti individuati (ingredienti semplici, attrezzature di facile reperibilità, procedimenti lineari), ai quali corrisponde una lingua nuova, freschissima, di matrice toscana, che ottiene il grande risultato di semplificare e uniformare il lessico della cucina, fondando le basi della lingua culinaria moderna.
A questa scelta linguistica Artusi giunge nella maturità, a 71 anni, dopo anni di studio nella ricca e aggiornata biblioteca di casa: qui Artusi – non letterato, non cuoco di professione, ma curioso e attento per i fatti di lingua – legge i testi della tradizione classica italiana, spoglia tante opere della letteratura toscana e fiorentina, consulta le opere di lingua e i dizionari, cui si aggiungono i libri dedicati a settori specifici, come i neologismi e i linguaggi settoriali. Dalla lettura quotidiana di questi libri e dal contatto diretto con la lingua viva della sua città d’adozione (Firenze), Pellegrino Artusi forma la sua lingua della cucina, in perfetto equilibrio tra elementi tradizionali e tratti della lingua parlata, continuamente arricchita e perfezionata man mano che uscivano le diverse edizioni della Scienza in cucina: il risultato è una lingua scorrevole, semplice, familiarmente colloquiale, che assicura al libro un grande successo di pubblico.
Secondo Artusi, così come l’alimentazione, anche la lingua deve tendere al semplice e al naturale, evitando di fare come i cuochi che usano il «gergo francioso», fatto di «nomi che rimbombano e non dicono nulla». Predomina perciò nella Scienza la volontà di razionalizzare, uniformare e livellare (secondo un ideale linguistico manzoniano) la nomenclatura della cucina, mettendo così ordine nella miriade delle denominazioni locali. Così, già dalla prima edizione, nella premessa alla ricetta n. 288 del Cacciucco, Artusi si sofferma proprio sul tipo lessicale cacciucco di area tirrenica, reso con l’equivalente adriatico brodetto (che però a Firenze vale tutt’altra cosa, e cioè una zuppa di pane in brodo legata con uova frullate e agro di limone), con questa conclusione: «La confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia, in Italia, è tale che poco manca a formare una seconda Babele».
Nel raccontare le sue ricette, molte delle quali sono diventate ricette identitarie del “mangiare all’italiana”, il serbatoio lessicale al quale Artusi attinge più volentieri è sicuramente quello del toscano e del fiorentino, con l’impiego di parole ed espressioni dell’uso corrente (adagino adagino riferito al bollire della pentola, rincalzare i cavoli ‘essere sottoterra’, ‘essere morto’, al tocco ‘all’una’), e termini gastronomici e culinari (brigidini ‘piccole cialde impastate con uova, anici e zucchero’, castagnaccio ‘preparato a base di farina di castagne’, popone ‘melone’). Si incontrano anche parole straniere, a volte adattate (bordò ‘(vino) bordeaux’, ponce, e il fiorentinissimo rosbiffe), a volte non adattate (alkermes ‘tipo di liquore’, plum-cake, vol-au-vent) e perfino curiose traduzioni personali (balsamella per ‘besciamella’, sgonfiotto per ‘soufflet’).
Se l’aspetto lessicale è certamente predominante nella visione artusiana della lingua, non bisogna sottovalutare altre componenti: la spigliatezza della sintassi, la ricchezza dei modi proverbiali, il modo confidenziale di rivolgersi ai lettori, che Artusi intrattiene con divagazioni personali e aneddoti, sono il segreto del successo di questo straordinario romanzo della cucina, sul quale si è formato il gusto italiano del Novecento.
7. Il lessico della gastronomia
Il lessico della cucina è caratterizzato da una grande, straordinaria varietà: varietà interna, in primo luogo, dovuta all’apporto multiforme dei dialetti alla lingua unitaria, soprattutto nel Novecento e nel secondo dopoguerra, quando la più ampia circolazione dei prodotti, l’intervento talora decisivo dell’industria alimentare, il costituirsi di un mercato su base nazionale prima e internazionale poi, hanno determinato l’emergere e l’affermarsi del patrimonio dialettale nella lingua nazionale. Con le casse dei maccheroni che già nel Gattopardo si immaginano in viaggio dal sud al nord d’Italia, hanno percorso la penisola termini e prodotti ormai entrati a pieno titolo in un patrimonio condiviso.
E poi varietà esterna, nel duplice aspetto dei termini stranieri (francesi, inglesi, ma ormai anche di altre lingue) entrati nella lingua della gastronomia, in tempi e con modi differenziati, e dei termini italiani che hanno fatto fortuna nel mondo. In questo senso, il settore del cibo e della cucina si presenta come uno dei più ricchi, dinamici, suggestivi, se non il più importante in senso assoluto. L’immagine dell’Italia all’estero o presso gli stranieri è strettamente, intimamente legata all’idea del suo cibo, che costituisce un modello di unanime apprezzamento, si direbbe quasi un mito (si pensi alla sensazionale, universale fortuna della parola pizza). Fra termini tradizionali e termini più moderni, in diversi livelli di pratica culinaria e corrispondenti valori sociali, il cibo italiano è un fattore potente di identità interna e di identificazione del concetto e dell’immagine dell’Italia all’estero.
7.1. Geosinonimi e dialettismi culinari
Ciò che caratterizza principalmente la lingua della cucina in Italia è la varietà. Come non ricordare che il caffèlungo di Roma e Milano corrisponde a quello alto di Firenze, a quello lento di Catania, a quello allungato di Cagliari e a quello mollo di Genova? Si tratta di 'geosinonimi', ossia vocaboli che hanno lo stesso significato, ma che sono usati in aree geografiche diverse all'interno della stessa lingua.
Oltre ai geosinonimi, la lingua della cucina è caratterizzata dalla presenza di molte parole di provenienza dialettale. Come ha scritto Giovanna Frosini: «Sono termini originariamente piemontesi fontina, grissino e gianduiotto; lombardi gorgonzola, mascarpone, stracchino, minestrone, osso buco, brasato, e panettone; veneti lingua salmistrata, musetto, (carne) a scottadito; emiliani zampone, piadina; romaneschi abbacchio e supplì […]; dall'Italia mediana provengono amatriciana, saltimbocca, porchetta, carciofi alla giudia; è meridionale il caciocavallo, meridionali scamorza, taralli, calzone, panzerotto, pastiera; siciliana la cassata. […] Di provenienza emiliano-romagnola sono le tagliatelle (tajadèl di Bologna) […]; così le paste ripiene più famose, i tortellini (bologn. turtlein; nell'italiano antico tortelli, tortelletti valgono ‘pezzi di impasto, con o senza sfoglia di pasta'; il Dizionario moderno di Panzini, nel 1905, registra finalmente tortellini e tortelli col significato attuale), e i cappelletti (i romagnoli caplett; in lingua già in una lettera di Leopardi, e Cappelletti all'uso di Romagna in Artusi ); mentre gli agnolotti provengono, almeno per il nome, dal Piemonte (agnolôt, agnölot). Dal Nord Italia giungono il lombardo risotto (attestato dalla metà dell'Ottocento) e le trenette (da trena ‘cordoncino'), liguri al pari del pesto; sono entrate nell'uso nazionale le romane fettuccine».
Da questa lista di termini si avverte subito che molti di questi dialettismi sono entrati nella lingua standard grazie alla circolazione e alla conoscenza di prodotti e pietanze che venivano preparate originariamente solo in piccole realtà territoriali. Oggi, ad esempio, è facile trovare una cassata in qualsiasi pasticceria, ma quanti chilometri si è disposti a fare per gustare in Sicilia quella "vera"?
7.2. Italianismi gastronomici
Gli italianismi nel mondo costituiscono un fenomeno di grande ampiezza, che registra, secondo le indagini più recenti, oltre ventimila parole e interessa un numero non definito, ma comunque alto, di lingue. La maggior parte degli italianismi, cioè delle parole italiane più diffuse all’estero, viene dal mondo della cultura. Tuttavia, sono molto diffuse anche le parole della cucina, come mostra il numero degli italianismi relativi all’alimentazione entrati in inglese nel Novecento: nella prima metà del secolo rappresentano infatti un quarto del totale, sono circa la metà nel periodo successivo e giungono a superare il 70% verso la fine.
Termini d’origine italiana relativi alla gastronomia si ritrovano nelle lingue europee già nel XVI secolo: ad esempio, maccheroni nella forma adattata macarrones è attestato per la prima volta in spagnolo nel 1517 (macarons, poi macaroni in francese, 1599; macaroni in inglese, 1599); sono di diffusione molto antica pure mortadella in francese (mortadelle, XV secolo) e vermicelli in francese (vermicelle, 1553) e inglese (vermicelli, 1669); parole come antipasto, polenta, bologna sono documentati nei dizionari inglesi a partire dal Cinquecento; le lasagne entrano in francese nello stesso secolo; risale invece alla fine del Settecento la fortuna internazionale della parola confetti; mentre le pappardelle e il panettone fanno il loro ingresso in inglese alla fine del XIX secolo.
Numerosi gli italianismi gastronomici recenti, molti dei quali connessi fortemente al fenomeno dell’emigrazione: così, ad esempio, la fortuna americana di termini come lasagne (1846), salami (1852), risotto (1855), ricotta (1877), spaghetti (1888), mozzarella (1911), rigatoni (1923), scampi (1923), ziti, zucchini, prosciutto (1929), pizza (1935) è da mettere in relazione con la forte presenza della comunità di italo-americani.
Ma il fenomeno dell’italianismo è vivissimo soprattutto nel Novecento, e particolarmente negli ultimi decenni, grazie al rinnovato prestigio della nostra lingua nel mondo legato al successo internazionale dei prodotti made in Italy, sinonimo di eccellenza e di qualità, nei settori della gastronomia, della moda, delle produzioni manufatturiere. Col diffondersi all’estero di nuovi prodotti e piatti della cucina italiana, si assesta un folto gruppo di italianismi gastronomici: non vi è ormai luogo del pianeta in cui non si conoscano e si utilizzino termini come pizza (oggi la parola italiana più nota nel mondo insieme a ciao), spaghetti, espresso e cappuccino, seguiti da cannelloni, mortadella, panna, ravioli, risotto, salame, mediamente noti in una trentina di lingue. Dagli anni settanta e ottanta del Novecento si sono rapidamente affermati, tra gli altri, bruschetta, carpaccio, ciabatta (reso plurale nella forma ciabattas), pesto, rucola, tiramisù (una parola presente in oltre venti lingue, tra cui giapponese, indonesiano, thai e laotiano). Non mancano infine termini anche più specifici, quali ad esempio parmigiano, mozzarella, olio d’oliva, aceto balsamico, così come fra i formati di pasta le farfalle sono ormai conosciute quasi quanto le tagliatelle.
7.2.1. Pizza
La pizza ― focaccia di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno, specie a legna ― è uno degli alimenti simbolo dell'italianità.
Nelle sue due versioni, napoletana (alta e con bordo spesso) e romana (sottile e croccante), non c'è dubbio che la più conosciuta sia la versione "margherita", condita con pomodoro, mozzarella e basilico. Secondo la tradizione questa pizza è stata inventata da Raffaele Esposito, che nel 1889, in occasione della visita delle regina Margherita a Napoli, la preparò così per ricordare i colori della bandiera dell'Italia unita.
Varie sono le ipotesi relative all'origine della parola 'pizza': un'origine germanica, dall'antico alto tedesco bizzo-pizzo (confronta il tedesco moderno Bissen), registrato con il significato di ‘morso' ‘boccone' ‘pezzo' (M. Cortelazzo, P. Zolli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, 5 voll., Bologna, Zanichelli, 1979-1988), o semitica (vedi M. Alinei, E. Nissan, L'etimologia semitica dell'itomo pizza e dei suoi corradicali est-europei, turchi, e dell'area semitica levantina, in “Quaderni di semantica”, XXVIII, n. 1, giugno 2007, pp. 117-136). A supporto di quest'ultima ipotesi, è un dato di fatto che quella che in Italia è conosciuta e si chiama 'pizza' sia imparentata con la pita medio-orientale e turca ― semplice focaccia ― e con la pita araba e balcanica ― farcita e/o condita. Gli studi, infatti, hanno fatto emergere che la diffusione di questo termine riguarda la penisola balcanica, la Turchia e l'intera area araba dell'est, dove la parola pita, in generale, con un'irradiazione dalla sponda sudorientale del Mediterraneo, indica una forma di pane schiacciato, rotondo e poco lievitato. Il termine pizza in passato veniva usato anche per indicare preparazioni dolci, come si può osservare nella Scienza in cucina di Pellegrino Artusi.
Pizza rusteca
Pigliarraje no ruotolo de sciore e lo mpastarraje co no quarto de nzogna no quarto de zuccaro macenato, e sei ova co tutta la velinia, e si te pare che la pasta fosse no poco tostarella nge miette no pucurillo d'acqua fresca; po farraje na pettola stesa co lo laniaturo, facennola doppia quant'a na pizza, e fatta accossì arravuoglie ottuorno a lo laniaturo, sodognarraje de nzogna na tortiera, e nge miette la pasta; po dinto pe mbottunature, sbattarraje ott 'va sana, no quarto de prorola grattata, e mbruoglieno poco de pepe, e si te nge piace no poco de petrosino ntretato, nne miette la mmità dint'a lo ruoto e mmiezo nge miette no bello saciccio, ca se sapisse comme nge fa saporito, fatto a fellucce, e accussì purzì nge miette no quarto de muzzarella, o provola janca, po nge miette l'auta mbottunatura, e ncoppa nge stienne l'auta pasta frolla comm'a chella de sotto; la farraje cocere a lo furno, o sotto a lo tiesto; e caura caura la farraje sciulià dint'a lo vacile sujo, e l'appriesente.
(da La Cucina Teorico-Pratica col corrispondente riposto ed alcune nozioni di scalcare composta dal Signor Ippolito Cavalcanti d. di Buonvicino per uso e divertimento de' suoi amici dilettanti. Con in fine una cucina casereccia in dialetto napoletano, Vittorio Capasso, Napoli 1852, p. 435).
7.2.2. Cappuccino
Il cappuccino è una bevanda calda di origine italiana a base di caffè e latte reso schiumoso dal vapore prodotto dalla macchina del caffè espresso: cappuccino scuro, con molto caffè; cappuccino chiaro, con poco caffè. Talvolta, per completare, si aggiunge una spolverata di cacao o di cannella in polvere.
Così chiamato dal colore che ricorda quello dell’abito dei frati cappuccini, secondo il Grande Dizionario della lingua italiana di De Mauro, la prima attestazione del nome per indicare una ‘bevanda’ risale al 1905, ma la sua diffusione internazionale iniziò a partire dal secondo dopoguerra.
Fra le parole italiane oggi più diffuse all’estero, cappuccino è presente in circa 40 lingue e, in alcune di esse ha persino determinato la formazione di pseudoitalianismi, cioè parole inesistenti in italiano, create all’estero per associare al prodotto il fascino e il prestigio dell’italianità: così, negli Stati Uniti hanno preso piede alcuni nomi di bevande come “frappuccino” (diventato in poco tempo uno dei prodotti di punta di una nota catena multinazionale di caffetterie), “mocaccino”, “freddoccino”.
Solitamente viene bevuto zuccherato, spesso accompagnato da brioche o croissant. Ultimamente si usa decorare il cappuccino con disegni fatti con il bricchetto del latte o strumenti manuali, utilizzando le moderne tecniche dell’“art coffee o latte art”.
Ricetta del Cappuccino
Un cappuccino di qualità è composto generalmente da un terzo di caffè, un terzo di latte e un terzo di schiuma.
Procedimento:
· Preparate un espresso dentro una tazza da cappuccino.
· Dentro un bricco di acciaio inossidabile, la cui altezza sia doppia della larghezza, fate scaldare il latte introducendo il beccuccio del vapore della macchina espresso e muovendo a notevole velocità il bricco stesso dall’alto verso il basso e viceversa per ottenere una dose abbondante di schiuma.
· Versate delicatamente nella tazza un’uguale quantità di latte e di schiuma. Se infatti la schiuma o il latte fossero troppo abbondanti l’equilibrio della bevanda sarebbe danneggiato.
· Completate con uno spruzzo di cacao amaro di ottima qualità.
· Adagiate la tazza sopra il piattino, sul quale sia stato adagiato un normale cucchiaino da caffè.
(da: Professione Barman, a cura di Camillo Massina, Verona, Demetra, 2000, pp. 36-37).
7.2.3. Tiramisù
Tra i dolci della tradizione pasticcera italiana il tiramisù è sicuramente uno dei più golosi e amati. Si tratta di un dolce semifreddo a base di biscotti savoiardi (o pan di Spagna), mascarpone, uova e zucchero, ricoperto da un sottile strato di cacao. Nella ricetta originale non è previsto il liquore, in modo da poter essere consumato anche dai bambini e dagli anziani, e la forma originale del dolce è rotonda anziché rettangolare.
Il tiramisù è un dolce ormai conosciuto in tutto il mondo, divenuto davvero internazionale. Basti pensare che il nome di questo dessert è presente in oltre venti lingue, fino al giapponese e all’indonesiano. Non è un caso, infatti, che tra le dieci ricette più rappresentative della tradizione gastronomica italiana, secondo il sondaggio “Le Ricette d’Italia”, promosso via internet dall’Academia Barilla e «La Cucina Italiana» nel 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ci sia il tiramisù.
Diverse regioni italiane rivendicano la paternità della sua ricetta, ma ormai si crede di poter identificare la terra d’origine nel Veneto, probabilmente a Treviso.
Piuttosto recente la sua invenzione, visto che la ricetta di questo dolce manca nei libri di cucina precedenti agli anni Sessanta. E fino agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso la parola che lo identifica non compare nelle enciclopedie e nei dizionari: bisogna aspettare il 1980, secondo quanto riportato nel Grande Dizionario della lingua italiana di De Mauro, per avere la prima attestazione del nome, con evidente derivazione dalla locuzione tirami su. Tuttavia, sfogliando i ricettari pubblicati tra gli anni Settanta e Ottanta, si può trovare la ricetta di questo dolce, ma sotto un diverso nome e cioè “Crema di mascarpone”.
Come ogni dolce di successo, anche il tiramisù ha dato origine a una serie, pressoché infinita, di varianti. Alcune prevedono la semplice sostituzione di alcuni ingredienti (i savoiardi invece del pan di Spagna, la panna o la ricotta al posto del mascarpone), altre sono vere e proprie rivisitazioni: ecco allora il tiramisù al cioccolato, agli amaretti, ai frutti di bosco, al limone, alle fragole, all’ananas, allo yogurt, alla banana, al lampone, al cocco e persino alla birra.
Ricetta del Tiramisù
Ingredienti: 500 gr. di mascarpone, 200 gr. di zucchero a velo, 30 biscotti savoiardi, 4 uova, liquore (rum o Marsala), cacao amaro.
Preparazione: mezz’ora più due ore per il raffreddamento.
In una terrina capace montate a lungo i tuorli con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema leggera. Incorporatevi il mascarpone, mescolate con cura affinché il composto sia perfettamente amalgamato. Con una frusta (meglio se elettrica) montate a neve fermissima gli albumi e uniteli con molta delicatezza ma velocemente alla crema di uova in modo da non smontare il composto. Versate qualche cucchiaiata di crema sul fondo di una pirofila o di un altro recipiente da tavola, sistematevi un primo strato di savoiardi inzuppati nel liquore e copritelo con abbondante crema. Solverizzate con un cucchiaio di cacao setacciato. Ricominciate con i savoiardi inzuppati, versatevi sopra tutta la rimanente crema e terminate con abbondante cacao fatto scendere da un setaccio. Fate raffreddare il tiramisù in frigorifero per un paio d’ore prima di servirlo. È un dolce ottimo e di preparazione semplicissima.
(da: La nostra cucina, a cura di Francesco Soletti, Edizioni della Specola, [S.I.], 1992, p. 426).
7.2.4. I dolci italiani del Carnevale
Durante la festa del Carnevale, la tradizione gastronomica italiana è ricca di dolci tipici: da nord a sud dell’Italia sono tante le specialità che si possono gustare. Partendo da una base molto semplice, fatta di farina, zucchero, uova e un pizzico di sale, si sviluppano molteplici varianti (circa duecento). Si tratta comunque di dolci semplici da preparare, che hanno nomi, forme, consistenze e contenuti diversi a seconda dell’area geografica da cui provengono, ma in fondo molto simili tra loro.
I più famosi sono senz’altro le chiacchiere ‘dolci di pasta fritta tagliata a strisce e cosparsa di zucchero’. Sono chiamate in modi diversi, spesso piuttosto curiosi, in relazione alla regione o città in cui vengono fatte (in linguistica, queste parole che servono a indicare lo stesso oggetto, ma che hanno altra forma a seconda della zona in cui ci si trova sono dette geosinonimi).
Vediamone alcuni, in ordine geografico: lattughe nella Lombardia orientale; frìtole, galani, gale, cròstoli, gròstoli e crostoi in Veneto; castagnole (di Sacile) in Friuli; schiumette o sciummette in Liguria; bugìe in Liguria e a Pisa; sfràppole, tortelli di carnevale, frittelle ripiene in Emilia; cenci, stracci, fràppole in Toscana (fiocchi ad Arezzo); castagnole, sfrappe e fiocchetti nelle Marche; castagnole e struffoli in Umbria; frappe, sfrappe nel Lazio (in particolare a Roma); cicerchiata in Abruzzo e Molise (fregnacce a L’Aquila); strùffoli, zèppole di San Giuseppe e fritte in Campania; cartellate e sfoglie in Puglia; calzoncelli in Basilicata; zìppulas e orilletas in Sardegna.
Nella ricetta classica, le chiacchiere sono vuote, con evidente allusione alla vuotaggine del contenuto (anche se se ne conoscono numerose varianti ripiene), e forse anche alla spensieratezza del periodo dell’anno in cui si consumano.
Ricetta delle Chiacchiere
Ingredienti per 8 persone: 300 gr. di farina, 100 gr. di zucchero, 50 gr. di burro, due uova, olio, sale, 100 gr. di zucchero al velo vanigliato.
Ponete la farina a fontana sulla spianatoia, incorporatevi le due uova intere, il burro fuso, lo zucchero e una presa di sale. Manipolate a lungo gli ingredienti aggiungendo qualche cucchiaiata di acqua tiepida, se la pasta risultasse troppo solida. Lavoratela per circa un quarto d’ora poi lasciatela riposare per un’ora in luogo caldo, avvolta in un tovagliolo infarinato. Stendete la pasta con il matterello in una sfoglia molto sottile poi ritagliate in questa con la rotellina dentata tanti “nastri” lunghi una decina di centimetri, che annoderete come fossero cocche. Buttateli, pochi alla volta, nell’olio bollente per farli diventare croccanti. Fateli colare dall’unto di cottura su una carta assorbente poi spolverizzateli di zucchero al velo vanigliato.
(da: G. Bonomo, Il Nuovo Libro di Cucina Curcio, Milano, Armando Curcio Editore, 1976, pp. 716-717).
7.2.5. La pasta e i suoi formati
Nota già ai romani e ad altri popoli delle regioni del Mediterraneo, l'uso della pasta si diffuse a partire dal Medioevo. In questo periodo gli arabi introducono in Sicilia la pratica dell'essiccazione, tecnica che avrebbe permesso l'esportazione e la commercializzazione del prodotto. A differenza dei metodi di cottura e di uso attuali, nel Medioevo la pasta veniva sottoposta a una cottura dai tempi lunghissimi e veniva poi usata come contorno, per accompagnare la carne, come tutt'ora avviene nella tradizione tedesca. Inoltre, il modo più comune di condirla era con burro, cacio e spezie dolci.
Soltanto nel XVIII secolo sarebbe comparso l'abbinamento col pomodoro. Dal Seicento, poi, la pasta diventa "piatto unico", affermandosi soprattutto a Napoli, dove gli abitanti da "mangiafoglie" (avevano una dieta povera, a base di cavolo) iniziarono ed essere soprannominati "mangiamaccheroni". I nomi di pasta sono vari e spesso sono legati all'uso locale. Lo stesso termine maccherone nell'Italia meridionale, ad esempio, indica qualsiasi tipo di pasta, mentre più generalmente è usato per indicare una pasta a forma di tubo di diverse dimensioni. Molti dei nomi di pasta, poi, nascono per associazioni di idee, come le sorprese, tipo di pasta da brodo simile al cappelletto ma priva di ripieno. Inoltre, nomi di origine dialettale si sono affermati nell'uso comune, come i romagnoli cappelletti e le romane fettuccine; altri, invece, pur essendo registrati come formato di pasta commercializzato da marchi noti, restano pur sempre legati a un uso territoriale, come gli sciviotti dei pastifici Granoro e Tamma, pasta a forma di tubo, arcuata, rigata o liscia, diffusi soltanto tra Basilicata, Campania e Puglia.
Uno dei formati di pasta più conosciuti all'estero sono gli spaghetti, che, in realtà, sono molto più "giovani" dei vermicelli. Questi ultimi, infatti, compaiono nei ricettari fin dal XIII secolo, a differenza degli spaghetti, registrati per la prima volta nell'Ottocento nel Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini.
Zuppa di Tagliolini
Impastate della farina con quattro, o sei uova, e un poco di sale, secondo la quantità della pasta, che volete fare, maneggiatela, che non sia tanto dura, nè tanto tenera; fatela un poco riposare, stendetela poscia collo stenderello fina come la carta, o tutta in una volta, o in diversi pezzi. Lasciatela alquanto asciugare, indi involtatela a cartoccio, e tagliatela fina a guisa di tanti filamenti. Fate bollire il suage, o altro brodo buono alquanto colorito, giusto il sale, poneteci dentro li tagliolini quella quantità, che richiede la dose del brodo, fateli bollire mezzo quarto d'ora, che non siano nè molto spessi, nè moltobrodosi, e li servirete uniti ad un tondino di parmigiano grattato. (da L'Apicio Moderno di Francesco Leonardi, 1807-1808, pp. 38-39).
Una ricetta speciale: Spaghetti alla Gennaro
7.3. Hamburger, omelette, sushi e kebab: parole straniere in cucina
La lingua della gastronomia è caratterizzata dalla convivenza di termini locali, che riflettono tradizioni regionali, e termini stranieri, di origine diversa, molti dei quali entrati già da molto tempo nella nostra lingua e conservati fino ad oggi: tra Quattro e Cinquecento, per esempio, arrivano dalla Spagna le parole capirotta ‘specie di zuppa’, mirasto ‘vivanda costituita da un pasticcio di volatili o pollame arrostiti a metà, poi lessati in brodo, con aggiunta di spezie, mandorle, zucchero e succo d’arancia e di limone’ (compresa fra le “minestre” nella cucina rinascimentale) e torrone; nel Cinquecento inizia a circolare il cuscùs di origine araba; dalla Francia del Settecento provengono le voci ragù, bignè, croccante, sciampagna (poi nella forma non adattata champagne).
Oggi, la lingua della cucina è molto ricca di forestierismi, che sempre più spesso entrano nella nostra lingua come prestiti non adattati. Ma non tutte le lingue straniere hanno pesato nello stesso modo.
L’influsso più importante (sul piano della quantità di parole trasmesse all’italiano e della continuità dei prestiti) è stato quello francese, favorito dalla vicinanza geografica e dal prestigio della cucina francese in Europa. Molti dei francesisimi gastronomici si stabilizzano nei primi decenni del Novecento e si sono conservati nella forma integrale o non adattata: per esempio béchamel, bon bon, brioche, buffet ‘credenza’, e ‘rinfresco’, charlotte, crème caramel, uova à la coque, dessert, entre-côte, frappé, julienne, marrons glacés, omelette, soufflé, oltre naturalmente a menu. Nella seconda metà del Novecento la pressione esercitata dal francese sull’italiano si attenua, registrando qualche termine specialistico, come crudités (1989), [insalata] niçoise (1958), profiterole (1957), quiche (1989), vinaigrette (1989), e naturalmente nouvelle cuisine (1986), da mettere in relazione con la fortuna di questa nuova moda gastronomica.
L’importanza e la profondità dell’influsso germanico sono state da sempre profonde. Bisogna però arrivare alle soglie e ai primi anni del Novecento per trovare i primi prestiti crudi: krapfen (1891), würstel (1905), strudel (1905) e i prodotti della gastronomia, in primo luogo.
Più recente il contributo dell’inglese e dell’anglo-americano alla lingua italiana della cucina, conseguenza degli effetti del consumismo filo-americano sulla cultura alimentare italiana, e più in generale occidentale, che ha visto ad esempio una diffusione massiccia delle catene dei fast-food (1982): abbiamo così nella nostra lingua quotidiana prestiti integrali come breakfast, brunch (1983), cake e plum cake, chips ‘patatine’ (1989), cornflakes (1965), hamburger (1963), hot dog (1950), ice cream, ketchup (1957), long drink e soft drink (1957, 1986), popcorn (1958), snack (1959), conosciuti da grandi e bambini. I contatti con la cultura anglo-americana hanno favorito il passaggio anche di tecnicismi come cutter, mixer (1970) fra le attrezzature, e di finger-food (2005) ‘cibo preparato in piccole porzioni, in modo da poter essere mangiato con le dita’, modellato su fast-food e simili, che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida e notevole diffusione.
Tra i prestiti non adattati di altra provenienza, in gran parte entrati di recente nell’italiano, si ricordano la paella spagnola, i taco(s) messicani, il greco tzatziki ‘salsa a base di yoghurt, aglio e cetrioli’. Spostandoci verso il Giappone, si hanno le parole surimi ‘cibo a base di pesce, arricchito di condimenti e conservato freddo’ e sushi ‘pesce freddo crudo, tagliato in piccoli bocconi’, oggi usatissime. Di ingresso recente sono anche il kebab turco ‘spiedo di carne arrostita di montone o di agnello’, e il fala(f)fel ‘polpettina di farina di ceci con prezzemolo e spezie’, divenuti popolari in Italia grazie alle immigrazioni provenienti dal Medio Oriente.
Un ultimo sguardo infine alla Cina, da dove viene ad esempio la nota salsa piccante shantung.
8. Le donne in cucina
Vincenzo Tanara nel suo L'economia del Cittadino in Villa, del 1674, scriveva: «Ma veniamo a più stretto paragone, per mostrare in parte la differenza fra la Cuciniera, ed il Cuoco; qualunque servo in Cucina deve esser polito, fedele, & intendente; Chi non sà, che per ordinario è più netto il più sporco Huomo, che la più polita Donna? La Cuciniera, posta la pignatta al fuoco, s'acconcia il capo, dapoi nel tempo, che le vivande si cuocono, con spruzzate dita fila [sic!]; altre cose naturali alle Donne lascio, delle quali in tutto, e per tutto l'Huomo n'è libero. Quanto alla fedeltà dico, che l'Huomo se non per natural desiderio d'honore, almeno per timore sarà sempre più fedele della Donna… » (V.TOMO, L'economia del Cittadino in Villa, Libri VII, Riveduta, ed accresciuta in moti luoghi dal medesimo Auttore, con l'aggiunta delle qualità del Cacciatore, In Venetia, appresso S. Curti, 1674, 1644, p. 176).
Ancora nel 1795 Francesco Leonardi, nel suo Dizionario ragionato (tomo II, p. viii), così si esprimeva: «volgiamo lo sguardo sulle Nazioni Inglese, Olandese, e Tedesca, le di cui Cucine, e Credenze sono di una proprietà sorprendente; tutto è netto, tutto è lucido, tutto è proprio, sono veri studi di chimica Alimentaria; benchè in alcune case di famiglie nobili della Germania, le donne facciano la cucina in preferenza degli uomini; e queste cuochesse sono molto pulite e abili, specialmente nella preparazione delle Erbe, e nella Pasticceria».
È evidente che ancora nell'Italia del Settecento, nonostante si iniziasse a vedere nelle donne un nuovo pubblico dei ricettari (si pensi alla dedica secondaria del Cuoco maceratese del 1781 «a' Giovani Servitori, e Donne di cucina…»), la figura femminile in cucina, a differenza che nei Paesi del Nord Europa, era ancora mal vista.
La stessa Gianina, protagonista del ricettario Gianina ossia la cuciniera delle Alpi (Roma, s.n.1817) scritto da Leonardi, gestore di una locanda ubicata sul passo del Moncenisio dal 1787, proveniva dall'Austria, una nazione in cui le signore di ceto medio e alto si occupavano della preparazione dei cibi più che nella Francia e nella stessa Italia. Nel nostro Paese, in particolare, le donne che sapevano leggere erano ancora un'esigua minoranza e per vedere il primo ricettario scritto da una donna, figura da sempre preposta alle faccende domestiche nelle fasce sociali medio-basse, si avrebbe dovuto aspettare il 1898, quando venne pubblicato Come posso mangiar bene? di Giulia Ferrari Tamburini.
9. I testi
La cucina non è fatta solo di ricette, tradizioni e abitudini tramandate oralmente: a queste si affianca la scrittura della cucina, che accompagna dal Medioevo a oggi la storia della gastronomia e della cultura in Italia. Varie e diversificate sono le forme che il testo di cucina ha assunto nel corso del tempo, tanto da uscire dagli schemi puramente prescrittivi e da assumere i caratteri della narrazione, del racconto, dell’affabulazione. Sistema complesso di contenuti e di scrittura, fra Otto e Novecento il ricettario è divenuto, nei casi più fortunati, un compagno assiduo e fedele della vita domestica, entrando nella quotidianità di generazioni di italiani e soprattutto di italiane.
In questa sezione si troveranno alcuni casi rappresentativi: dall’Apicio moderno di Francesco Leonardi, il ricettario maggiore del Settecento, alla Scienza in cucina di Pellegrino Artusi, vera chiave di volta nella storia della gastronomia italiana, per l’operazione unitaria che in essa si realizza nei contenuti e nella lingua, al Talismano della felicità di Ada Boni, portafortuna – fin dal titolo beneaugurante – per le giovani spose del Novecento; e non potevano mancare alcuni esempi dei periodici più diffusi, dall’«Almanacco» Sonzogno alla «Cucina Italiana», la rivista più prestigiosa, caratterizzata dalla presenza in redazione di una vera, grande cucina.
9.1. "L'Apicio Moderno"
L'Apicio moderno ossia l'Arte di apprestare ogni sorta di vivande, pubblicato per la prima volta nel 1790 in 6 tomi, in ottavo, poi una seconda volta (col semplice titolo di Apicio moderno), nel 1807-1808, accompagnato dall'Apicio moderno ossia l'Arte del credenziere (sempre per i tipi di Giunchi, a Roma), è il ricettario più ampio del Settecento, sia rispetto alla produzione editoriale italiana, sia francese.
Scritto da Francesco Leonardi, cuoco romano di formazione francese, di fama internazionale, che operò al servizio di eminenti personaggi, come il Cardinale de Bernis, ambasciatore francese presso la Santa Sede, sia in Italia sia all'estero (arrivò persino in Russia, lavorando per Caterina II), l'opera si presenta come il riassunto della tradizione (Apicio ricorda la gloria degli antichi maestri dell'arte culinaria di Roma, in quanto ad un certo Apicius fu attribuito il De re coquinaria, antico ricettario) e dell'innovazione in cucina (moderno era un aggettivo comune nei titoli di ricettari francesi ma assente fino ad allora nei titoli italiani). Così, accanto a piatti tipicamente italiani, come le preparazioni a base maiale (mortadelle e cotechini) o piatti composti a base di pasta, si ritrovano ricette francesi e di altre nazionalità (come il Pasticcio di Cibulette in IV, 260 o la Zuppa Russa di Ortica in I, 59), ben 22 ricette di patate (pomi di terra) e ben 40 ricette di pomodoro (pomidoro), ortaggio il cui uso non era ancora comune in Francia e di cui Leonardi è il primo in Italia a fornire ricette di salsa, sugo e conserva.
Il risultato è un'opera di più di 3000 ricette in cui Leonardi non manca di rivelare il gusto della cucina italiana, ma anche quello suo personale, sfoggiando ricette tradizionali (p. es. pangiallo), esotiche (p.es. ricette alla Russa o alla Biela Russa) e di sua invenzione. Inoltre, nell'Apicio Leonardi inserisce una parte abbastanza ampia riguardante la descrizione di vari tipi di aceto e di vino, di cui non si è trovato riscontro in altri testi. L'opera, completa in quanto a contenuti, venne scritta da Leonardi per un pubblico sempre più ampio, tanto da richiedere particolari accorgimenti linguistici, proprio in un periodo in cui la lingua italiana tutta, e quella del settore culinario in particolar modo, era influenzata fortemente dal modello francese. Leonardi usa, infatti, la tecnica di trascrivere foneticamente i termini francesi, cioè secondo la grafia italiana «per maggiore intelligenza di quelli, che non sanno quell'idioma»; inserisce una Spiegazione di alcuni termini francesi, ed Italiani usitati nella Cucina nel primo tomo (pp. lv-lvj) e una Spiegazione Generale de' Termini Francesi nel sesto tomo (pp. 318-321). Inoltre, si serve di note di commento e varia le ricette e i sostantivi usati a seconda della tipologia di persona cui si rivolge, in un continuo cambiamento del modo di scrivere, utile a soddisfare la fame di tutti i suoi lettori.
9.1.1. I contenuti
- Il primo tomo è dedicato a brodi, zuppe, e salse di grasso, al manzo, e alla vitella mongana;
- il secondo all'agnello, al capretto, all'abbacchio, al majale, e parte della polleria;
- il terzo alla polleria, al «selvaggiume grosso, e picciolo», alle terrine, e ai piatti composti;
- il quarto «ai ragù, ai salpicconi», alle farse, alle guarnizioni, alle erbe, alle uova, alle creme, alle gelatine, ad altri piatti diversi, e alla pasticcieria;
- il quinto a ogni sorta di brodi, zuppe, e salse di magro, ai ragù di magro con alcuni di grasso, e a tutti i pesci in generale «apprestati sì di grasso, che di magro»;
- il sesto agli arrosti, ai rifreddi, ai crostacei, alle conchiglie, alle erbe di magro, alla pasticcieria di magro, ai pesci salati e sfumati, alle vivande da riservirsi sulla mensa, a al modo di conservare «diverse sorta d' erbe, quello di estrarre la farina de' pomi di terra».
9.1.2. Il pubblico dell'opera
«Quest'Opera pertanto, che io presento al Pubblico, mi lusingo, che non solo potrà essere utile alle persone della professione, ma eziandìo a quelle di una condizione diversa, tanto relativamente alla salute, che all'economia di qualsivoglia famiglia, potendovi ognuno ricercare di che divertirsi nel voler fare la Cucina; imperciocchè oltre a quei piatti di prezzo soliti servirsi alle tavole de'Grandi, ve ne sono una gran quantità a portata d'ogni ceto di persone, tanto sullo stile Italiano, che Francese».
(Apicio, tomo I, pp. xx).
9.1.3. Le variazioni nella scrittura
«Volesse il Cielo che il talento dei bravi Cuochi giungesse a tanto di fare col poco il molto, ma infelicemente tutte le cose che si voglian fare, per semplici che siano richiedono sempre un certo bisogno, e quantitativo, di cui non se ne può fare a meno, senza rovinare il più bello, e lungo travaglio. Dirò dunque su questo particolare, che il Consomè, il Suage, il Restoran, il Biondo di Mongana, ec. sono tutti nomi che per loro stessi non significano niente. I brodi si restringono a trè, cioè il Brodo bianco, il Brodo colorito, ed il Brodo legato. […] Ecco tutti i brodi».
(Apicio, tomo II, pp. xxxiv-xxxv).
Inoltre: «Non vorrei, che un apparato di tanti brodi, zuppe, salse, e nomi ignoti spaventassero l'onesto cittadino, e gli facessero supporre essere quest'opera inutile per lui. No? Sarebbe questo un mal'inteso supposto, mentre dovendo essa servire sì per il grande, e magnifico, che per il semplice, e mediocre, ho dovuto principiare con quei fondamenti, che portono seco le regole dell'arte, per poi insensibilmente calare al fine che mi sono proposto, volendo assolutamente che possa apportare profitto a chiunque ne sia provveduto. […] Onde non dee recar meraviglia se nella maggior parte delle salse vi bisogna qualche poco di vino di Sciampagna, essendo questo un condimento, che ognuno, che sappia alquanto la professione non lo deve ignorare, imperocchè l'anima delle salse è il vino bianco, e specillante lo Sciampagna. Ciò nonostante chi non lo avesse, o non potesse farne tal uso, potrà in tal caso servirsi del vino bianco ordinario, ma che non sia dolce. In quanto poi alli brodi […] basta che abbiano corpo, e sostanza […]. Riguardo poi alla carne, che viene prescritta anche di questa se ne può mettere meno, oppure niente, basta soltanto porvi qualche dadino di prosciutto, ma tale difficoltà potrà accadere in un ordinario molto ristretto, e regolato… »
(Apicio, tomo II, p. 64).
9.2. "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie"
La prima edizione della Scienza in cucina di Pellegrino Artusi esce a Firenze, presso la Tipografia Landi, nel 1891, e contiene 475 ricette. Il successo è immediato e il libro diventa subito uno dei pochi e veri best-sellers dell’editoria italiana. L’opera si arricchisce negli anni successivi di nuove ricette – alcune delle quali inviate dagli stessi lettori –, fino a raggiungere nell’ultima edizione curata dall’autore, la 14a (1910), il numero definitivo di 790 (e in Appendice La cucina per gli stomachi deboli).
La cucina di Artusi si basa principalmente sulle tradizioni gastronomiche romagnolo-bolognese e toscano-fiorentina, nelle quali l’autore individua il nucleo essenziale della cucina dell’Italia appena unita. Ad arricchire le conoscenze gastronomiche contribuiscono i numerosi viaggi che Artusi compie, in calesse o in treno, nelle grandi città del Nord, dell’Italia centrale, fino al Sud (non oltre Napoli), in un lungo periodo di tempo che va dal Risorgimento all’Unità d’Italia, sino ai primi anni del ’900.
La Scienza in cucina non è dunque un repertorio completo delle tradizioni culinarie della penisola, e molte sono le regioni (soprattutto meridionali) che vi mancano. Tuttavia, se l’Italia è solo in parte rappresentata dalle ricette di Artusi, la sua opera ha il grande merito di definire e offrire – per la prima volta – un codice alimentare e culinario nazionale. Accanto alle ricette della cucina regionale italiana, compaiono alcuni piatti stranieri e piatti di sua invenzione: tutti, prima di finire nelle pagine del manuale, vengono provati e riprovati da Artusi e perfezionati dai cuochi di casa, la toscana Marietta Sabatini e il romagnolo Francesco Ruffilli.
Dai brodi ai liquori, passando attraverso minestre, antipasti (“principii”), secondi e dolci, le ricette di Artusi mettono insieme piatti della cucina borghese e popolare, con ingredienti semplici e piatti poveri come la “Zuppa di fagiuoli” e la “Trippa col sugo”, e nella quale forti sono i legami con la cucina contadina, come nella ricetta del “Pollo alla contadina” e delle “Braciuoline alla contadina”.
Il libro, che vuole essere un “manuale pratico per le famiglie”, insegna una cucina per la cui buona riuscita bastano pochi elementi: passione, ingredienti di prima qualità, attrezzature accessibili, procedimenti precisi e lineari. Ed è pure, come dice ancora il titolo, una cucina “scientifica”, il frutto cioè di una scienza: deriva, infatti, da alcuni principi, che sono in primo luogo quello dell’economia (calcolo dei costi, ma anche recupero degli avanzi) e dell’igiene.
Artusi rinnova anche la lingua usata per parlare di cucina, ponendo le basi del linguaggio gastronomico moderno. E la sua scelta linguistica, di fronte all’esigenza di dare una lingua unitaria alla cucina italiana, individua nel fiorentino parlato il modello linguistico da seguire; per questo motivo, non è sbagliato definire Artusi “il Manzoni della lingua gastronomica italiana”.
La chiarezza della lingua, il tono cordiale e colloquiale con il quale l’autore si rivolge ai suoi lettori e alle sue lettrici per descrivere le ricette, ma anche gli aneddoti, le storie, le osservazioni gustose, i riferimenti personali che vi inserisce, fanno della Scienza in cucina non solo un manuale di ricette, ma anche un piacevole testo da leggere.
L’Artusi è ancora oggi il libro più letto sulla cucina italiana e numerose sono le traduzioni del testo (in inglese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco e francese) attualmente disponibili.
9.2.1. Ricette della cucina romagnolo-bolognese: Tortellini alla bolognese
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, p. 10-12)
N. 8 - Tortellini alla bolognese
Quando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza, che se la merita. È un modo di cucinare un po’ grave, se vogliamo, perchè il clima così richiede; ma succulento, di buon gusto e salubre, tanto è vero che colà le longevità di ottanta e novant’anni sono più comuni che altrove.
I seguenti tortellini, benchè più semplici e meno dispendiosi degli antecedenti, non sono per bontà inferiori, e ve ne convincerete alla prova.
Presciutto grasso e magro, grammi 30.
Mortadella di Bologna, grammi 20.
Midollo di bue, grammi 60.
Parmigiano grattato, grammi 60.
Uova, N. 1.
Odore di noce moscata.
Sale e pepe, niente.
Tritate ben fini colla lunetta il presciutto e la mortadella, tritate egualmente il midollo senza disfarlo al fuoco, aggiungetelo agli altri ingredienti ed intridete il tutto coll’uovo mescolando bene. Si chiudono nella sfoglia d’uovo come gli altri, tagliandola col piccolo stampo del N. 7. Non patiscono conservandoli per giorni ed anche per qualche settimana. Con questa dose ne farete poco meno di 300, e ci vorrà una sfoglia di tre uova.
Bologna è un gran castellazzo dove si fanno continue magnazze, diceva un tale che a quando a quando colà si recava a banchettar cogli amici. Nell’iperbole di questa sentenza c’è un fondo di vero del quale, un filantropo che vagheggiasse di legare il suo nome a un’opera di beneficenza nuova in Italia, potrebbe giovarsi. Parlo di un Istituto culinario, ossia scuola di cucina a cui Bologna si presterebbe più di qualunque altra città pel suo grande consumo, per l’eccellenza dei cibi e pel modo di cucinarli.
Nessuno apparentemente vuol dare importanza al mangiare, e la ragione è facile a comprendersi; ma poi, messa da parte l’ipocrisia, tutti si lagnano di un desinare cattivo o di una indigestione per cibi mal preparati. La nutrizione essendo il primo bisogno della vita è cosa ragionevole l’occuparsene per sodisfarlo meno peggio che sia possibile.
Dico dunque che il mio istituto dovrebbe servire per allevare delle giovani cuoche le quali, naturalmente più economiche degli uomini e di minore dispendio, troverebbero facile impiego e possederebbero un’arte in mano che, portata nelle case borghesi, sarebbe un farmaco alle tante arrabbiature che spesso avvengono nelle famiglie a cagione di un pessimo desinare.
Ho lasciato cader questa idea così in embrione ed informe: la raccatti altri, la svolga e ne faccia suo pro qualora creda l’opera meritoria. Io sono d’avviso che una simile istituzione ben diretta, accettante le ordinazioni de’ privati e vendendo le pietanze già cucinate, si potrebbe impiantare, condurre e far prosperare con un capitale e con una spesa relativamente piccoli.
Se vorrete i tortellini anche più gentili aggiungete alla presente ricetta un mezzo piatto di cappone cotto col burro, un rosso d’uovo e la buona misura di tutto il resto.
9.2.2. Ricette della cucina toscano-fiorentina: Ricciarelli di Siena
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1911, pp. 431-432)
N. 620 – Ricciarelli di Siena
Zucchero bianco fine, grammi 220.
Mandorle dolci, grammi 200.
Dette amare, grammi 20.
Chiare duovo, N. 2.
Odore di buccia d’arancio.
Sbucciate le mandorle, asciugatele bene al sole o al fuoco e pestatele finissime nel mortaio con due cucchiaiate del detto zucchero versato in diverse volte; poi uniteci il resto dello zucchero mescolando bene.
Montate le chiare in un vaso qualunque e versateci le mandorle così preparate e la buccia dell’arancio grattata. Mescolate di nuovo con un mestolo e versate il composto sulla spianatoia sopra a un leggiero strato di farina per fargliene prendere soltanto quella ben poca quantità che occorre per tirare leggermente col matterello una stiacciata morbida, grossa mezzo dito. Allora tagliateli con la forma qui sotto segnata e ne otterrete da 16 a 18 per cuocerli nel seguente modo:
Prendete una teglia, fatele uno strato di crusca alto quanto uno scudo e copritelo tutto di cialde per posarvi su i ricciarelli e cuocerli al forno a moderato calore onde restino teneri. In mancanza del forno, che sarebbe il più opportuno, servitevi del forno da campagna.
Dopo cotti tagliate via la cialda che sopravanza agli orli di queste paste, che riescono di qualità fine.
9.2.3. Piatti stranieri: Krapfen
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, pp. 87-88)
N. 115 – Krapfen
Proviamoci di descrivere il piatto che porta questo nome di tedescheria ed andiamo pure in cerca del buono e del bello in qualunque luogo si trovino; ma per decoro di noi stessi e della patria nostra non imitiamo mai ciecamente le altre nazioni per solo spirito di stranieromania.
Farina d’Ungheria, grammi 150.
Burro, grammi 40.
Lievito di birra quanto una grossa noce.
Uova, uno intero e un rosso.
Zucchero, un cucchiaino.
Sale, una buona presa.
Prendete un pugno della detta farina, ponetela sulla spianatoia e, fattole un buco in mezzo, stemperatevi entro il lievito di birra con latte tiepido e formatene un pane di giusta sodezza, sul quale inciderete un taglio in croce per poi conoscer meglio se ha rigonfiato. Ponete questo pane in un tegamino o in una cazzarolina nel cui fondo sia un sottilissimo strato di latte, copritela e lasciatela vicino al fuoco onde il pane lieviti a moderatissimo calore: vedrete che basterà una ventina di minuti. Lievitato che sia mettetelo in mezzo alla farina rimasta ed intridetela colle uova, col burro liquefatto, collo zucchero e col sale. Se questo pastone, riesce troppo morbido, aggiungete tanta farina da ridurlo in modo che si possa distendere col matterello alla grossezza di mezzo dito. Così avrete una stiacciata dalla quale con un cerchio di latta taglierete tanti dischi della grandezza come alla pag. precedente.
Ammesso che ne facciate 24, prendete un uovo o altro arnese consimile e colla punta del medesimo pigiate nel mezzo di ognuno dei dischi per imprimergli una buca. In 12 dei detti dischi ponete un cucchiaino di un battutino tirato col sugo e la balsamella, composto di fegatini, animelle e presciutto tagliati a piccoli pezzi. Bagnate i dischi all’intorno con un dito intinto nell’acqua e sopra ciascuno soprapponete un altro disco dei 12 rimasti vuoti; quando saranno tutti coperti premete sopra ai medesimi un altro cerchio di latta di dimensione eguale a quello qui sopra indicato, onde si formi un’incisione all’ingiro.
Ora che avete questi 12 pasticcini ripieni bisogna lievitarli e ciò otterrete facilmente ponendoli vicini al fuoco; ma a lieve calore. Quando saranno rigonfiati bene friggeteli nel lardo o nell’olio in modo che sieno ricoperti dall’unto e serviteli caldi come fritto o piatto di tramesso il quale, per la sua apparenza e bontà, sarà giudicato piatto di cucina fine.
Se volete che servano per dolce non avete altro a fare che riempirli di una crema alquanto soda o di conserva di frutta spolverizzandoli, dopo cotti, di zucchero a velo.
9.2.4. Marietta Sabatini
Originaria di Massa e Cozzile, un piccolo paese della provincia di Pistoia, Marietta Sabatini è nota per essere stata per tanti anni la cuoca e la cameriera di Pellegrino Artusi, insieme a Francesco Ruffilli, originario di Forlimpopoli.
Fondamentale è stato il contributo dei due fedeli domestici alla riuscita di quell’impresa culinaria ed editoriale che fu l’ideazione, la stesura e la diffusione della Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene: nella cucina della bella abitazione fiorentina di Artusi, infatti, tutti i piatti venivano provati e riprovati più volte, e perfezionati grazie ai consigli di Marietta e Francesco.
Così racconta il lavoro di Artusi Marietta in una intervista pubblicata sulla rivista gastronomica «La Cucina Italiana» il 15 febbraio 1932: «L’unico suo divertimento era lo scrivere. Il libro lo cominciò quasi per ischerzo. Poi vide che gli veniva bene e vi si appassionò. A poco a poco venne ad avere una corrispondenza con persone d’ogni ceto e d’ogni parte d’Italia. Scriveva sempre. Si alzava la mattina alle otto e si metteva a tavolino fino all’ora del pranzo. Poi riprendeva a scrivere per qualche ora. Ed era un continuo alternarsi fra lo studio e la cucina, la penna e le pentole. Si provavano le ricette, tutte, una ad una. […]».
Morto scapolo e senza figli, Artusi lascia per testamento a lei e a Francesco Ruffilli i diritti d’autore del suo libro.
Una curiosità: alla fidata Marietta, Pellegrino Artusi dedica la ricetta del panettone descritta nel manuale perché «La Marietta è una brava cuoca e tanto buona ed onesta da meritare che io intitoli questo dolce col nome suo, avendolo imparato da lei» (I ed., p. 262).
Per renderle omaggio, il Comune di Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, organizza da diversi anni il “Premio Marietta”, in collaborazione con Casa Artusi e in occasione della Festa Artusiana. Si tratta di un concorso nazionale per cuochi dilettanti, che prevede l’assegnazione del premio finale al miglior cuoco o cuoca (non professionisti), la cui ricetta sia ispirata, sia per gli ingredienti sia per la tecnica di preparazione, alla cucina artusiana.
Ancora in suo onore, è stata costituita nella Scuola di cucina di Casa Artusi l’“Associazione delle Mariette”, che conta oggi più di cento soci, allo scopo di valorizzare e promuovere la cucina domestica e le tradizioni gastronomiche popolari, con particolare attenzione alla cucina romagnola.
9.2.4.1. Rina Simonetta, "Parliamo di Pellegrino Artusi"
Parliamo di Pellegrino Artusi
Una figura alta, slanciata; figura giovanile nonostante i capelli bianchi; figura distinta e signorile, mi accoglie nel salotto, con un sorriso. L’intima stanza dove la signora mi riceve è tutta una festa di sole, di fiori, di piante verdi, di luce.
– Si accomodi signora, e mi permetta di offrirle un caffè. Con una tazza davanti, stando sedute attorno al tavolo, si discorre meglio.
– È vero. Ciò dà subito un senso di intima affettuosità, anche a due persone che si conoscono poco...
– Ma che hanno subito simpatizzato fra loro. Probabilmente perchè in quest’epoca di finzioni, di frivolità, di leggerezze, le loro anime si sono incontrate immediatamente. E lei, nonostante la sua giovinezza e il suo viso di bambina, ha la sentimentalità del nostro ottocento!
– Cara signora, com'è buona, e so io sola, quanto è stata buona con me. Ora poi sono venuta per chiederle un altro favore!
– Dica pure...
– Vorrei parlare con Lei un poco della vita di Pellegrin Artusi. Di questo Dante della cucina, di quest’uomo di cui tanto si parla sempre. C’è chi dice che fosse un cuoco, chi sostiene trattarsi di un gran signore e chi invece sostiene trattarsi di uno scrittore di professione. Un letterato lo era certamente perchè il suo libro è quanto di più perfetto, più utile e divertente si possa trovare in tal materia. Era Fiorentino o Bolognese? Le due città se lo disputano... insomma di lui si sono dette tante cose, ma realmente nessuno ne sa la vera storia.
– L’accontenterò, signora, sebbene io sia sempre restìa a parlare del signor Artusi. Perchè egli era tanto modesto, tanto semplice che voleva rimanere nell’ombra.
– E invece il suo libro ne ha fatto l’uomo più conosciuto che esista...
– Già. Ma egli non l’aveva scritto a questo scopo. Egli scriveva soltanto perchè ciò gli piaceva, perchè la cucina lo appassionava e per avere un’occupazione che gli fosse di distrazione...
– Come mai gli venne quest’idea?
– L’Artusi nacque in un piccolo paese della Romagna. La sua famiglia era agiata, il padre commerciava in seta, il figliolo studiava e le sorelle accudivano alla casa.
– Aveva delle sorelle?
– Sì, due. Un giorno una terribile tragedia si abbattè su di lui. Era l’epoca in cui il «Passatore» faceva strage in quei luoghi. Una notte penetrato in casa dell’Artusi con i suoi uomini ne fece scempio. Pellegrino che era giovanissimo cercò di difendere la sua casa, i suoi cari. Ma non gli fu possibile. Accerchiato d’uomini, dopo una forte lotta fu sopraffatto da quei banditi. Ad un tratto, mentre egli veniva trattenuto a viva forza, alcuni briganti si impadronirono di una delle sorelle e dinnanzi ai suoi stessi occhi, tenendolo legato...
– Dio mio! che orrore!
– La povera fanciulla fuggì. Fu ritrovata l’indomani, mentre camminava sui tetti delle case. Era impazzita.
– È una tragedia terribile!
– Artusi non volle più rimanere nel paese natìo. Partì. Partì per Firenze dove cercò un impiego. Assillato dall'orrendo ricordo di quella notte, cercava di distrarsi scrivendo. Spesso, perfino negli ultimi anni, era preso da un tremito convulso, che lo scuoteva sempre, ogni qualvolta rammentava la terribile notte.
– Quanto deve aver sofferto!
– Spaventosamente. Quando io lo conobbi, prese a volermi un gran bene. Mi trattava come una figlia. Mi teneva al corrente di tutte le sue cose, ed io, umile donnina, lo aiutavo come e più che potevo.
– E il libro?
– Le ho già detto che l’unico suo divertimento era lo scrivere. Il libro lo cominciò quasi per ischerzo. Poi vide che gli veniva bene e vi si appassionò. A poco a poco venne ad avere una corrispondenza con persone d’ogni ceto e d’ogni parte d’Italia. Scriveva sempre. Si alzava la mattina alle otto e si metteva a tavolino fino all’ora del pranzo. Poi riprendeva a scrivere per qualche ora. Ed era un continuo alternarsi fra lo studio e la cucina, la penna e le pentole. Si provavano le ricette, tutte, una ad una. Accanto a lui instancabile era sempre il suo cuoco che gli voleva tanto bene. Io pure non lo lasciavo mai. Altri compagni fedeli gli erano i due gatti ai quali dedicò la prima edizione del suo libro.
– I suoi gatti?
– Sì. Nella prima edizione c’è una prefazione, una dedica, per questi suoi fedeli amici, che sempre vicini a lui in cucina gli tenevano compagnia e guardavano estatici il gioco delle sue bilance.
– Provava tutte le ricette?
– Tutte! E talvolta riuscivano, talvolta no. Per il cappone in vescica, per esempio, sciupò 8 capponi! Finchè un piatto non risultava quale egli lo voleva, lo manipolava, provava riprovava, senza mai rinunziare. Ed alla fine ne conseguiva il premio desiderato: la nuova ricetta.
– Erano prove costose!
– Sì molto. Ma le soddisfazioni che provava lo ricompensavano. La cucina era per lui un campo d’azione. Un luogo di studio. Io ho ancora e tengo come fossero gioielli le sue bilance, i suoi arnesi, tutto quanto gli era necessario ed egli adoperava sempre. Mi pare ancora di vederlo!
– A parte la cucina e lo scrivere, che vita faceva?
– Leggeva molto... Aveva pochi amici, ma buoni. Il commendatore Bemporad è stato uno dei migliori. Accettava qualche invito a pranzo, ma assai di rado. Era un terribile giudice delle pietanze sapeva al solo assaggio riconoscere gli ingredienti e trovare qualsiasi difetto, immediatamente. A parte la cucina gli piaceva leggere. Invecchiato però, gli si era molto indebolita la vista e per non farlo stancare ero io che leggevo per lui.
– Non le era fastidioso leggere ad alta voce?
– No. Per lui nulla poteva essermi di peso. E poi lèggere mi piaceva. Ma mi ci sono logorata gli occhi. Quando morì stavamo leggendo l’Eneide...
– Libri classici dunque?
– Sì. Ma anche altri. Romanzi no. Non gli piacevano. Era un uomo coltissimo, ed amava istruire anche me. Ed io gli ero tanto riconoscente per questo.
– Ed il suo cuoco?
– Lo nominò suo erede come me. Ma ora è morto. Il signor Artusi lasciò un gran patrimonio che divise tutto in opere di beneficenza. Il libro invece lo lasciò a noi che lo avevamo assistito ed aiutato, ed ai quali voleva tanto bene...
La signora Sabatini si interrompe. La sua voce trema un poco. Ho abusato della sua bontà. Tutti i ricordi più cari le tornano alla memoria e le danno una emozione che può appena contenere. È tanto cara, ha un tale dolce aspetto di nonna buona ch’io a stento trattengo lo slancio di gettarle le braccia al collo. Il sole che sta per tramontare in questo stupendo inverno fiorentino, dora le cime delle piante nei giardini, bacia le erbe odorose che crescono copiosissime sul grazioso terrazzo, si posa come una striscia d'oro su un tavolo d'ebano intarsiato d’avorio. È ora di andarmene. Mentre prendo commiato, promettendo di tornare, sento una punta di nostalgia per quella casa così serena, così buona, così raccolta, nella quale abita una donna dalla voce soave e riposante. Con tristezza discendo le scale di quell’intimo luogo che è stato come un faro luminoso di guida e d’aiuto per tante donnine inesperte di tutto il nostro paese... E penso a chi le guida oggi... cui spedisco queste note affrettate.
9.2.4.2. Il Panettone Marietta
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1911, p. 417)
N. 604 - Panettone Marietta
La Marietta è una brava cuoca e tanto buona ed onesta da meritare che io intitoli questo dolce col nome suo, avendolo imparato da lei.
Farina finissima, grammi 300.
Burro, grammi 100.
Zucchero, grammi 80.
Uva sultanina, grammi 80.
Uova, uno intero e due rossi.
Sale, una presa.
Cremor di tartaro, grammi 10.
Bicarbonato di soda, un cucchiaino, ossia grammi 5 scarsi.
Candito a pezzettini, grammi 20.
Odore di scorza di limone.
Latte, decilitri 2 circa.
D’inverno rammorbidite il burro a bagno-maria e lavoratelo colle uova; aggiungete la farina e il latte a poco per volta, poi il resto meno l’uva e le polveri che serberete per ultimo; ma, prima di versar queste, lavorate il composto per mezz’ora almeno e riducetelo col latte a giusta consistenza, cioè, nè troppo liquido, nè troppo sodo. Versatelo in uno stampo liscio più alto che largo e di doppia tenuta onde nel gonfiare non trabocchi e possa prendere la forma di un pane rotondo. Ungetene le pareti col burro, spolverizzatelo con zucchero a velo misto a farina e cuocetelo in forno. Se vi vien bene vedrete che cresce molto formando in cima un rigonfio screpolato. È un dolce che merita di essere raccomandato perchè migliore assai del panettone di Milano che si trova in commercio, e richiede poco impazzamento.
9.2.5. Piatti poveri: Zuppa di fagiuoli e Trippa col sugo
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, pp. 33-34)
N. 39 - Zuppa di fagiuoli
Si dice, e a ragione, che i fagiuoli sono la carne del povero; e infatti quando l’operaio, frugandosi in tasca, vede con occhio malinconico che non arriva a comperare un pezzo di carne che basti per fare una buona minestra alla famigliuola, trova nei fagiuoli un alimento sano, nutriente e di poca spesa. C’è di più; i fagiuoli, restando molto in corpo, quetano per un pezzo gli stimoli della fame; ma... anche qui c’è un ma come ce ne sono tanti nelle cose del mondo, e già mi avete capito. Per ripararvi, in parte, scegliete fagiuoli di buccia fine o passateli: quelli dall’occhio hanno meno degli altri questo peccato.
Per rendere poi la zuppa di fagiuoli più grata al gusto e più saporita, dato che se ne debba fare una quantità sufficiente a quattro o cinque persone, fatele un soffritto in questa proporzione: prendete un quarto di cipolla, uno spicchio d’aglio, un pizzico di prezzemolo e un bel pezzo di sedano bianco. Tritate finissimi questi odori colla lunetta e metteteli al fuoco con olio a buona misura; siate generosi a pepe. Quando il soffritto avrà preso colore, unitevi due ramajuoli della broda dei fagiuoli, aggiungete un poco di sugo di pomidoro o di conserva, fate alzare il bollore e versatelo nella pentola de’ fagiuoli.
Per chi aggradisce nella zuppa un poco d’erbaggio può mettere in questa il cavolo nero, prima lessato e fatto bollire alquanto nel liquido del soffritto suddetto.
Ora non resta che bagnare il pane, che avrete già preparato avanti con fette arrostite, grosse un dito e poi tagliate a dadi.
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, p. 154)
N. 206 - Trippa col sugo
La trippa, comunque cucinata e condita, è sempre un piatto ordinario. La giudico poco confacente agli stomachi deboli e delicati, meno forse quella cucinata dai Milanesi, i quali hanno trovato modo di renderla tenera e leggiera. In alcune città si vende già lessata e questo fa comodo; non trovandola tale lessatela in casa e preferite quella grossa cordonata. Lessata che sia tagliatela a striscie larghe mezzo dito ed asciugatela fra le pieghe di un canovaccio. Mettetela poi in una cazzaruola a soffriggere nel burro e quando lo avrà tirato, aggiungete sugo di carne o, se non avete questo, sugo di pomodoro; conditela con sale e pepe, tiratela a cottura più che potete e quando siete per levarla, gettatevi un pizzico di parmigiano.
9.2.6. Cucina contadina: Pollo alla contadina e Braciuoline alla contadina
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, pp. 125-126)
N. 166 - Pollo alla contadina
Prendete un pollastro e steccatelo con alcune ciocchette di ramerino e con uno spicchio d’aglio diviso in quattro o cinque pezzi. Mettetelo al fuoco con un battutino di lardone e conditelo con sale e pepe di fuori e di dentro. Quando sarà rosolato da tutte le parti aggiungete pomodori a pezzi, toltine i semi e, quando questi saranno disfatti, bagnatelo con brodo od acqua. Rosolate a parte nell’olio, nel lardo o nel burro alcune patate crude tagliate a spicchi, fate loro prender sapore nell’intinto del pollo e servitele per contorno. Al lardone battuto sostituite il burro, se volete il pollo di gusto più delicato.
(Tratta da Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie, Firenze, Tip. Landi, 1891, pp. 142-1143)
N. 190 - Braciuoline alla contadina
Per me, che si ribellano al mio gusto, le lascio mangiare ai contadini; ma, poichè ad altri potrebbero non dispiacere, ve le descrivo.
Preparate le braciuoline con carne magra di vitella battuta bene, ungetele coll’olio e conditele con poco sale e pepe. Fate un composto di olive, capperi strizzati dall’aceto e un’acciuga, tritando il tutto ben fine. Lasciatelo così semplice, oppure aggiungete un rosso d’uovo e un pizzico di parmigiano; riempitene le braciuoline, legatele e quindi cuocetele con burro e sugo di pomodoro oppure in un soffritto di cipolla.
9.2.7. Le copertine delle traduzioni
Le copertine di alcune delle traduzioni (inglese, spagnolo, tedesco e francese) del manuale di Pellegrino Artusi:
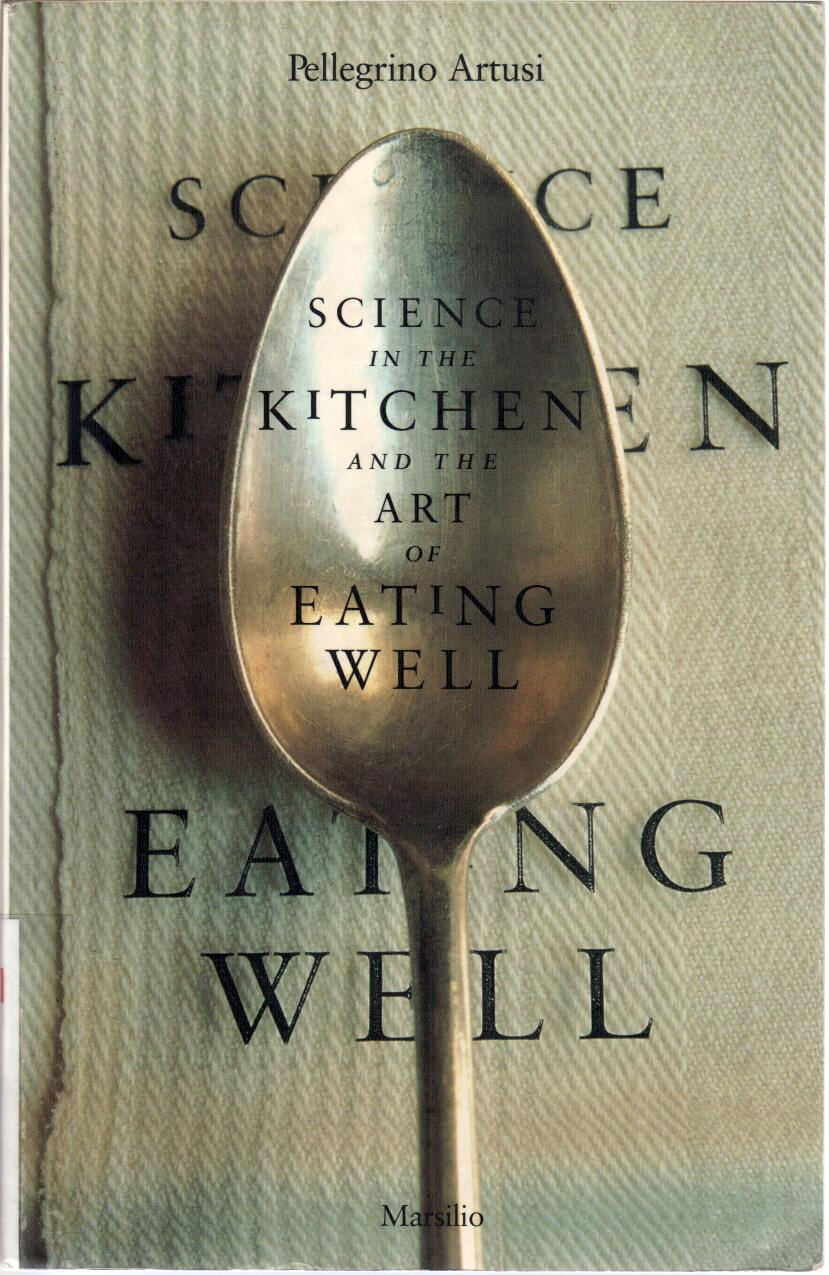
Science in the kitchen and the art of eating well; New York: Marsilio, 1997.

Exciting food for southern types; London: Penguin books, 2011
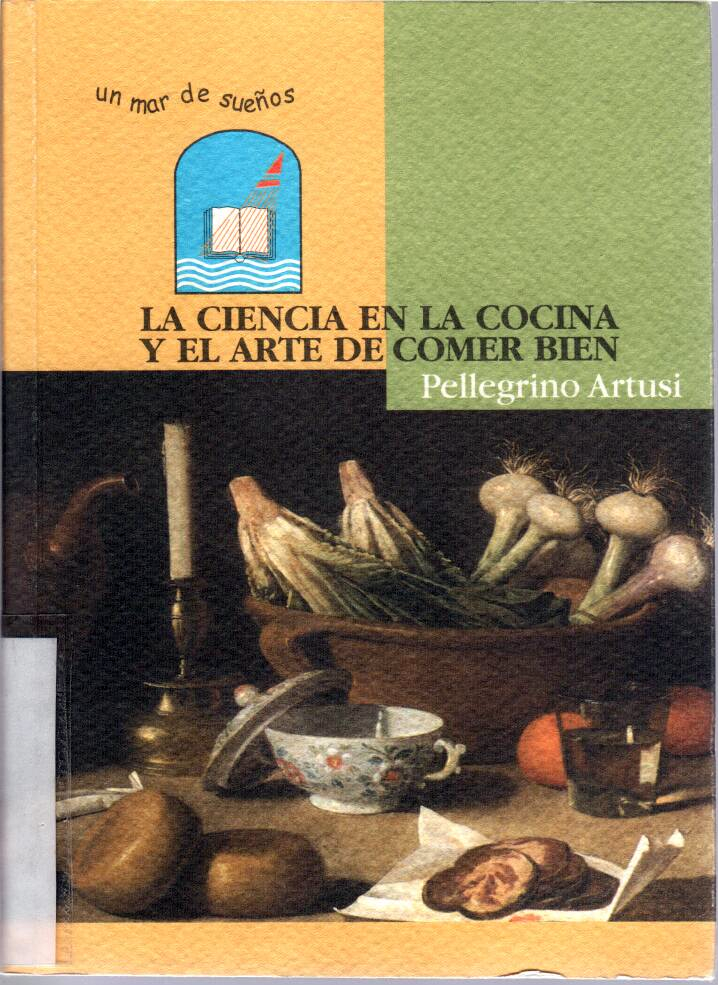
La ciencia en la cocina y el arte de comer bien; Martorano di Cesena: Arci solidarieta cesenate, 2004.
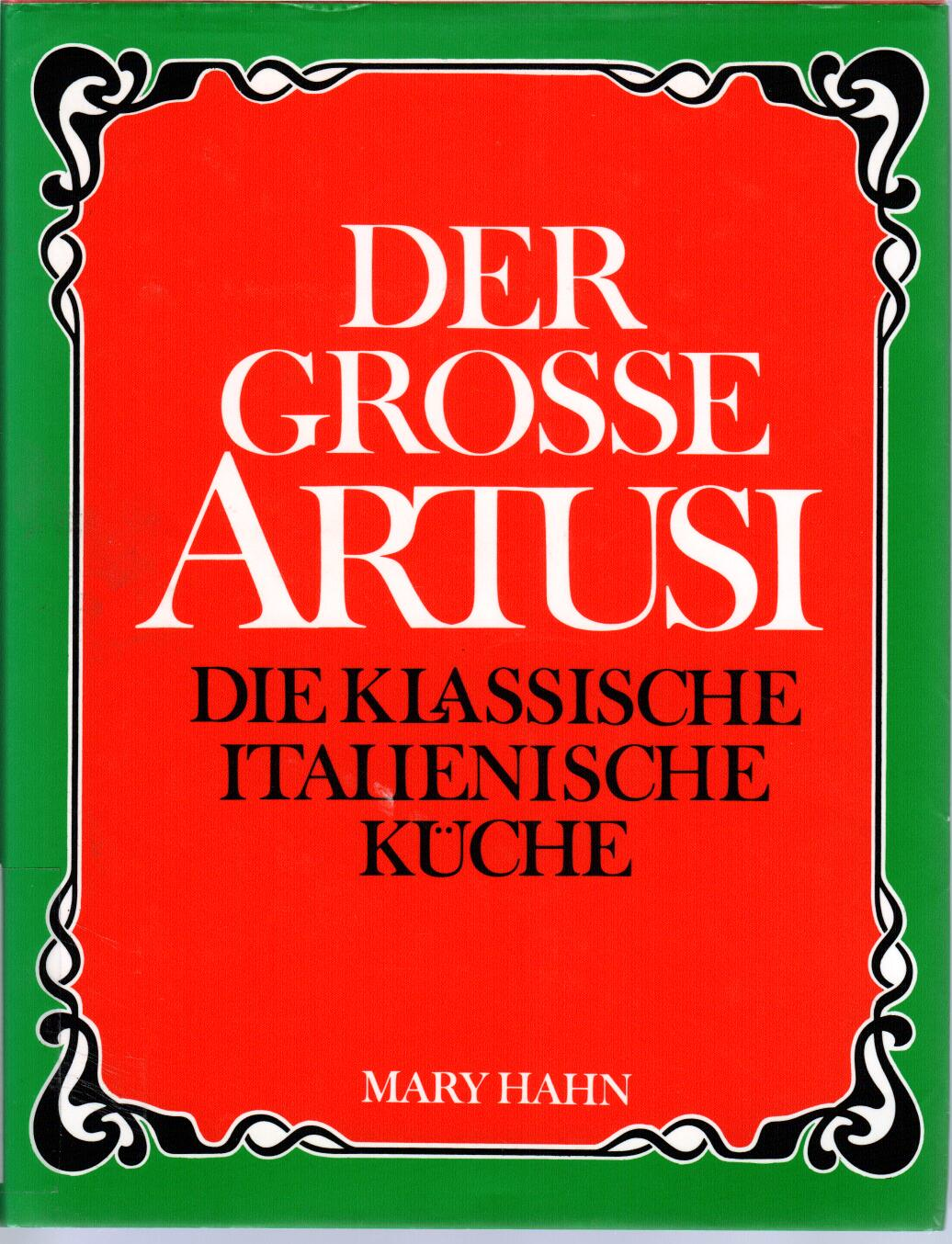
Der Grosse Artusi: die Klassische Italienische Küche; München: Mary Hahn, 1982.
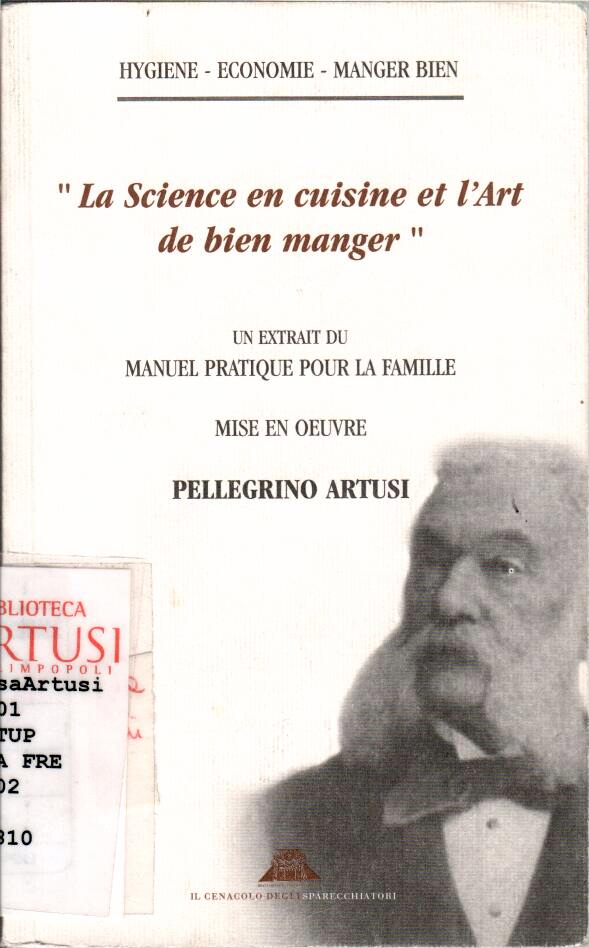
La science en cuisine et l’art de bien manger; Firenze: Il cenacolo degli Sparecchiatori, 2002.
9.3. "La cucina italiana"
«La Cucina Italiana» è il più noto e autorevole mensile italiano di gastronomia e cultura alimentare.
Come recita l’attuale sottotitolo della rivista, «dal 1929 il mensile di gastronomia con la cucina in redazione», il periodico ha una lunga tradizione e si distingue dalle altre riviste di cucina, sia in Italia sia all’estero, per la presenza di una grande cucina in redazione nella quale tutte le ricette vengono preparate, assaggiate e fotografate prima di essere pubblicate. Le ricette sono spiegate minuziosamente e spesso riportano le proprietà e il valore nutritivo degli ingredienti che le compongono. Ci sono le ricette della “Cucina regionale” e della “Cucina dal mondo”; quelle della “Cucina pratica”, per preparare piatti generalmente di facile esecuzione, ipocalorici e poco costosi; le ricette della “Scuola di cucina” della rivista, descritte e fotografate passo dopo passo; e, infine, le ricette inviate dai lettori al mensile. Particolarmente curata è inoltre la parte dedicata ai vini e ai vitigni italiani, con gli approfondimenti tecnici contenuti nella “Scuola del sommelier”.
Il mensile ha oggi una diffusione media di 100.000 copie all’anno e, accanto ai dodici numeri mensili, realizza ogni anno tre “Speciali”. Sul sito internet della rivista si trovano anche i menù degli “Speciali” dedicati alle feste e alle ricorrenze particolari, con ricette e video-ricette sui piatti tradizionali del Natale, della Pasqua ecc.
Oltre alle ricette, particolare attenzione viene rivolta alle moderne tendenze nutrizionali, alla dietetica e all’educazione alimentare di adulti e bambini; completano la rivista articoli dedicati all’arredo della tavola, al turismo enogastronomico, e alla scoperta di ristoranti e cuochi famosi in Italia e nel mondo. Tra le rubriche, “In dispensa”, in cui si propone una selezione di prodotti di grandi e piccole aziende alimentari, anch’essi precedentemente provati e testati dalla redazione.
Il mensile di cucina è da alcuni anni tradotto e pubblicato all’estero: negli Stati Uniti, direttamente da Quadratum Publishing Usa e, su licenza, negli altri Paesi: Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Repubblica Ceca e Slovacca; e, in lingua araba, nel MENA (medio oriente, nord Africa).


Tra le iniziative più recenti, nel 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Academia Barilla: e «La Cucina Italiana» hanno promosso via internet una grande operazione culturale, “Le Ricette d’Italia”, allo scopo di individuare le dieci ricette più rappresentative della tradizione gastronomica italiana.
9.3.1. Storia della rivista
Il primo numero della «Cucina Italiana», dal significativo sottotitolo «Giornale di gastronomia per le famiglie e per i buongustai», esce a Milano il 15 dicembre 1929, pubblicato dall’Istituto Editoriale Italiano di Umberto Notari. La rivista ha periodicità mensile, ma ha il formato, il tipo di carta e il numero delle pagine (otto) di un quotidiano. Il direttore è lo stesso Notari, affiancato dalla moglie Delia Pavoni e da un «Comitato di degustazione» di cui fanno parte Massimo Bontempelli, Filippo Tommaso Marinetti, Paolo Buzzi.
Oltre a proporre ricette e consigli gastronomici, «La Cucina Italiana» pubblica anche articoli firmati da donne scrittrici e ricette di poeti italiani, come quella di Giovanni Pascoli sul Risotto romagnolo, pubblicata nel giugno 1930. Nello stesso anno, Marinetti pubblica il “Manifesto della Cucina Futurista” ripubblicato nel gennaio 1931, nel quale si propone un «programma di rinnovamento totale della cucina», che ha tra i suoi principi «l’abolizione della pasta asciutta».
Numerose le rubriche regolarmente presenti nella rivista: la “Tavola dei buongustai”, con ricette raffinate, inviate da artisti, scrittori, personalità della politica e della finanza, a quella di segno opposto, “La tavola di tutti i giorni”, con ricette semplici, inviate dalle abbonate. Abbiamo anche “La rubrica della Massaia Moderna”, “La dispensa e la cantina”, la “Piccola Posta”, e, dal 15 aprile 1930, “Il mercato alimentare”.
Nel dicembre 1930 il mensile, il cui motto è “Mangiar meglio, spender meno”, lancia un concorso nazionale “La Massaia Italiana contro il caro-vita”: il risparmio, il valore dei cibi buoni e sani, l’igiene e la sanità, il riutilizzo degli avanzi rappresentano principi fondamentali, continuamente ribaditi all’interno della rivista.
Nel novembre 1932 la redazione si trasferisce a Roma ed entra a far parte del gruppo editoriale del quotidiano «Il Giornale d’Italia», sempre sotto la guida di Delia Notari.
Nel 1934, col passaggio della direzione a Fanny Dini, «La Cucina Italiana» si presenta come una moderna rivista per signore: cambia formato, le 8 pagine diventano 32, in quarto, e si introducono le illustrazioni. Anche il contenuto muta e nuove sono le rubriche dedicate alla bellezza (“La vostra bellezza, signora!”), all’arredamento della casa (“La donna e la casa”), alle giovani donne della borghesia perché diventino “perfette massaie” (“Consigli a Rosetta”) e, dall’aprile 1935, la rubrica sulla moda (“La pagina della moda”); vi è persino uno spazio per il galateo intitolato “Signorilità”, curato dalla contessa Elena Morozzo Della Rocca.
Nell’ottobre 1937 la prima pagina del mensile si presenta come una copertina vera e propria, e diventa a colori due anni dopo.
Nel luglio 1943 «La Cucina Italiana» interrompe le pubblicazioni, a causa della guerra. Torna a uscire nel gennaio del 1952, a Milano, diretta da Anna Gosetti della Salda coadiuvata dalla sorella Fernanda, entrambe apprezzate autrici di libri di cucina. Il sottotitolo cambia e diventa “Rivista di cucina e convivialismo fondata dal 1929”; si inseriscono nuove rubriche e gli articoli spaziano dalla moda, al giardinaggio, all’arredamento della casa. Uno spazio è riservato alle ricette regionali e agli articoli sulle cucine straniere.
Nel 1981 Anna Gosetti lascia la direzione della rivista a Paola Ricas; nello stesso anno, la rivista viene acquistata dalla Editrice Quadratum, che tuttora la pubblica.
9.3.2. "Risotto romagnolo"
(da “La Cucina italiana”, giugno 1930, prima pagina della rivista)
Risotto romagnolo
Ricetta di Giovanni Pascoli
Volendo dimostrare che la cura della cucina, il gusto della tavola, non sono antitetiche di Poesia, il nostro giornale si compiace pubblicare ricette in versi di poeti contemporanei.
Anche se non fu scritta apposta per noi, come le altre pubblicate fin qui su La Cucina Italiana, non possiamo omettere quella del «risotto romagnolo», dovuta al più squisito fra i moderni lirici italiani — il Pascoli.
Amico, ho letto il tuo risotto in.... Ahi!
È buono assai! Soltanto è un pò futuro
con quei tuoi: «tu farai, vorrai, saprai!».
Questo è del mio paese, è più sicuro
perchè.... presente. — Ella à tritato un poco
di cipollina in un tegame puro.
V’à messo il burro dal color di croco
o zafferano (è di Milano!) a lungo
quindi à lasciato il suo cibreo sul fuoco.
Tu mi dirai «burro e cipolla?»
Aggiungo che v’era ancora qualche fegatino
di pollo, qualche buzzo, qualche fungo.
Che buono odor veniva dal camino!
Io già sentivo un poco di ristoro
dopo il mio greco, dopo il mio latino!
Poi v’ha spremuto qualche pomodoro;
A lasciato covare chiotto chiotto,
infin ch’à preso un chiaro color d’oro.
Soltanto allora ella v’ha dentro cotto
Il riso crudo come dici tu.
Già suona mezzogiorno; ecco il risotto
il buon risotto che mi fa Mariù.
GIOVANNI PASCOLI
9.3.3. "Frittura cervellotica"
(Da “La Cucina italiana”, MAGGIO 1930, p. 5)
Una ricetta di Fernando Cervelli
Frittura cervellotica
Blò-glò-blò-blò-glò-glò! Quando l’olio che sia di sentorpiccante canta così, farvi annegare romboidi di cervello d’animali vigorosi prima fatti stemperare — i romboidi e non gli animali — nell’acqua caldasemibollente.
Crz crzz crzzz crzzzz... quanto in tono minore la padella canta così, togliere precipitosamente i pezzi: caricare subito su altrettante piattaforme di sfilacci di calze di suocera (foglie d’indivia verdissime) prima spruzzate d’aceto millaromatico, nel centro d’ogni rombo un chiodo di garofalo: servire in tavola scottante, mentre ancòra l’olio rimasto sui romboidi continua la sua canzone esplosiva pronunciando a denti stretti un ben marcato, viva Marinetti. — FERNANDO CERVELLI.
9.3.4. Piatti delle feste tradizionali
Colomba casalinga
Dosi per 2 colombe da 650 g circa: 250 g di lievito madre, oppure una biga preparata con 150 g di farina; 100 di acqua a temperatura ambiente e 1 g di lievito di birra ( preparata la sera prima). Il mattino seguente: impastare la biga ( o il lievito madre) con 100 ml di latte tiepido, 10 g di miele, 5 g di lievito di birra, 250 g di farina “forte”. Lasciar lievitare sino a raddoppio del volume, poi aggiungere: 2 tuorli, un uovo, 150 g di zucchero, 200 g di burro morbido a pezzetti, tutto lentamente, poi 200 g di farina forte e lavorare per 20 minuti, incorporare 100 g di canditi. Porre in stampo, riempiendo sino a metà. Far lievitare sino al raddoppio in luogo caldo e umido. Tritare 50 g di mandorle dolci e 10 g di mandorle amare, 50 g di nocciole e mescolare con 100 g di zuchero, 10 g di fecola e due albumi. Glassare le colombe. Spolverare con 50 g di granella di zucchero. Cuocere in forno statico a 190 per 10 minuti circa. e quindi a 160 per 35 minuti circa. Lasciar raffreddare sospese e rovesciate).
9.4. "Il talismano della felicità"
Uno dei ricettari femminili più noti, Il Talismano della felicità di Ada Boni, pubblicato per la prima volta dalle Edizioni della Rivista Preziosa (Roma) nel 1925, è stato un punto di riferimento sicuro per generazioni di massaie. La fortuna dell’opera è testimoniata dalle numerose riedizioni che si sono susseguite, a distanza di pochi anni l’una dall’altra, ognuna delle quali arricchita e modificata rispetto alla precedente, di pari passo con un crescente successo che continua fino ad oggi, non solo in Italia, ma anche all’estero.
Nelle prime edizioni, il libro si apre con un Proemio scritto da Enrico Boni, marito di Ada e cultore di gastronomia, nel quale si tessono le lodi del grande cuoco francese Augusto Escoffier, autore della Guide culinaire e, fra gli italiani, di Adolfo Giaquinto, zio della stessa Boni e autore di pregevoli ricettari per la casa. Sferzante è invece la critica nei confronti di Artusi, definito dal Cavalier Boni come «l’autore che riuscì a vendere stracci e orpelli per sete rare e oro», capace di scrivere «con olimpica indifferenza le sciocchezze più madornali». Neppure Ada Boni risparmia l’Artusi e non mancano le critiche (esplicite o allusive) che gli riserva nel testo di alcune sue ricette.
Le destinatarie del Talismano sono le «dame di fine eleganza e di impeccabile buon gusto» della borghesia e dell’aristocrazia italiana, appena sposate o prossime alle nozze, del tutto – o quasi – inesperte in cucina. Con il tono autoritario e didascalico che la contraddistingue, la Boni si rivolge a loro nella prefazione al testo («Alle lettrici»), promuovendo il Talismano come un prezioso aiuto per raggiungere la felicità coniugale:
Molte di Voi, Signore e Signorine, sanno suonare bene il pianoforte o cantare con grazia squisita, molte altre hanno ambitissimi titoli di studi superiori, conoscono le lingue moderne, sono piacevoli letterate o fini pittrici, ed altre ancora sono esperte nel «tennis» o nel «golf», o guidano con salda mano il volante di una lussuosa automobile. Ma, ahimè, non certo tutte, facendo un piccolo esame di coscienza, potreste affermare di saper cuocere alla perfezione due uova alla «coque». […] Pensate che non vi può essere una vera felicità là dove viene trascurata una parte così essenziale della nostra vita di tutti i giorni: l’alimentazione. […] Con piena coscienza noi vi diciamo: Signore, perfezionate sempre più le vostre cognizioni di cucina; Signorine, imparate a ben cucinare. Un «menu» semplice e ben eseguito è la pace della famiglia, ed è anche la certezza di veder apparire a casa il vostro compagno non appena i suoi affari o il suo impiego lo lasceranno libero.
Si passa poi, dopo una parte dedicata alle “Nozioni fondamentali di cucina”, al ricettario vero e proprio, diviso per argomenti. Grande spazio alle carni, ai primi piatti (minestre, minestroni, maccheroni, risotti ecc.), agli erbaggi, ma ancora più numerose le prescrizioni per i dolci. Attento anche agli aspetti pratici (ricette facili, costi contenuti, riutilizzo degli avanzi), il volume si conclude con un’appendice con utili consigli, per esempio, su come arredare una cucina, sull’“arte di comporre un menù”, a seconda dei pasti e delle occasioni, su come apparecchiare la tavola per un pranzo e servire i vini: tutto ciò che serve insomma per diventare una perfetta padrona di casa.
Il titolo così ben augurante, che insieme alla felicità matrimoniale evocava il potere magico del libro, hanno fatto diventare il Talismano della felicità una sorta di portafortuna per le giovani spose, che dagli anni ’20 ad oggi lo ricevono spesso come regalo di nozze.
9.4.1. Ada Boni: la biografia
Ada Giaquinto nasce a Roma nel 1881 e fin da giovane si interessa alla cucina, seguendo gli insegnamenti dello zio paterno, Adolfo Giaquinto, chef, insegnante, autore di fortunati libri di ricette e fondatore all’inizio del Novecento della prestigiosa rivista gastronomica «Il Messaggero della cucina».
Il matrimonio con Enrico Boni, scultore e scrittore, discendente di una ricca famiglia di orafi romani, le consente una vita agiata tra la casa di palazzo Odescalchi e, d’estate, la grande villa sul litorale di Santa Marinella.
Su suggerimento del marito, che con lei condivide la passione per la cucina, fonda nel febbraio 1915 la rivista «Preziosa», diventandone la direttrice-proprietaria. Rivolta soprattutto alle signore della borghesia, «Preziosa» si presenta come una rivista moderna, ricca di indicazioni, spunti e consigli di economia domestica, utili per poter dirigere personalmente la casa senza affidarsi alle persone di servizio. Il mensile bandisce anche dei concorsi per le migliori ricette, con l’onore della pubblicazione sulla rivista, accompagnata dalla foto della vincitrice. «Preziosa» viene pubblicata fino al dicembre 1943, riprende nel gennaio 1946, per cessare definitivamente le pubblicazioni con il numero di dicembre 1959.
Nel 1925 appare, pubblicato dalle Edizioni della Rivista Preziosa, Il Talismano della felicità, l’opera imponente che l’ha resa famosa. Pensato per le spose della borghesia romana e italiana – che già leggeva «Preziosa» –, nel ricettario si raccolgono anche le migliori ricette apparse negli anni precedenti sulle pagine della rivista.
L’interesse per la cucina spinge inoltre Ada Boni ad aprire una scuola di cucina, a curare una serie di conversazioni radiofoniche settimanali e a scrivere altri libri di cucina.
Del 1929 è La Cucina Romana. Contributo allo studio e alla documentazione del folklore romano (Roma, Edizioni della Rivista Preziosa), un’opera interessante che raccoglie le ricette della tradizione culinaria romana, con particolare attenzione a quei piatti di cui si stava perdendo il ricordo; e del 1949, Prime esperienze di una piccola cuoca (Roma, Colombo).
Verso la fine degli anni Cinquanta, Ada Boni inizia a collaborare con la rivista «Arianna» dell’editore Mondadori, curandone la rubrica “Il talismano di Arianna”, con un evidente richiamo nel titolo al suo famoso ricettario. Nella stessa rivista, pubblica (a puntate) la sua Cucina Regionale Italiana, successivamente riunita in volume (Milano, Mondadori, 1975).
Ada Boni muore a Roma nel 1973.
9.4.2. Ricetta: "Fiori di zucca"
Fiori di zucca
ed. Talismano 1927, pp. 349-350.
I fiori di zucca sono dei fiori alquanto disgraziati, perchè contrariamente a quanto avviene pei loro confratelli che abbelliscono i giardini, nessuno vuol prenderli sul serio. E' un torto dellumanità, la quale ne ha anche dei peggiori sulla coscienza. Del resto questi modesti fiori, così spesso e volentieri presi i n giro, si prendono la loro brava rivincita offrendo un cibo molto simpatico. Per lo più i fiori di zucca si fanno fritti, semplici o ripieni. In un caso come nell'altro è necessario che essi siano freschissimi e non molto aperti. La loro toletta culinaria è assai semplice. Se ne spunta un po’ il gambo, si liberano da qualche filamento, si lavano, si asciugano in un panno, ed eccoli pronti. Se volete friggerli al naturale non dovete far altro che immergerli in una pastella d’acqua e farina e metterli in padella. Se volete invece riempirli potrete seguire diversi sistemi. Potrete infatti, dopo averli delicatamente privati dell’anima, infarcirli con della mollica di pane grattata e impastata con olio, prezzemolo trito, qualche acciuga in pezzettini e un pizzico di pepe; oppure con delle fettine di mozzarella o provatura, e prosciutto; oppure con provatura e alici. Potrete anche riempirli con un po’ di besciamella, nella quale si possono unire, a scelta, dei dadini di gruyère, o una fettina di carne arrostita e tritata, o dei funghi cotti e tritati. Non avete dunque che l’imbarazzo di scegliere. Riempiti i fiori di zucca, si immergono nella pastella, o meglio ancora si passano nella farina e nell’uovo sbattuto, e si friggono.
9.4.3. Ricetta: "Frittelline di Carnevale"
Frittelline di carnevale
ed. Talismano 1927, pp. 452-453.
Mettete sulla tavola di cucina otto cucchiaiate di farina (200 grammi) due uova intiere, una grossa noce di burro, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e la raschiatura di un po’ di buccia di limone. Impastate il tutto senza troppo lavorare la pasta, che lascerete riposare per mezz’ora in luogo fresco. Stendetela poi col rullo di legno, come una pasta da tagliatelle, avvertendo di tenerla molto sottile e aiutandovi, per stenderla, con un po’ di farina. Servendovi del tagliapaste a rotella o in mancanza di questo, di un coltello, dividete la sfoglia in tante striscie larghe un paio di dita e poi ritagliate queste striscie in tanti pezzi della lunghezza di circa dieci centimetri. Friggete questi pezzi nell’olio o nello strutto finchè abbiano preso un bel colore d’oro pallido e siano divenuti leggeri e croccanti. Sgocciolate le frittelline, e quando saranno fredde accomodatele in un vassoio con salvietta spolverizzandole di zucchero. A Roma si chiamano «frappe» e si usa, anzichè ritagliare le striscie in pezzi, conservarle lunghe dando ad esse la forma di ampi nodi.
9.5. "Almanacco della cucina gustosa-economica"
Nella serie degli «Almanacchi» pubblicati dall’editore milanese Sonzogno esce l’Almanacco della cucina gustosa-economica 1941, stampato presso la Tipografia di Alberto Matarelli nel 1940. Il formato è in 8°, le pagine sono 226, e costa 4 lire. L’intera serie nasce come supplemento annuale della «Rivista delle famiglie», mensile illustrato con articoli di attualità, storia e costume, fondato nel 1933. Così come negli altri numeri del periodico, la copertina mostra un’immagine abbellita della donna di casa; in questo c’è una donna sorridente che solleva un grande piatto colmo di frutta: le mani sono curate, il vestito è grazioso, il trucco e la pettinatura perfetti. Il volume è compilato a cura di una non meglio identificata “Giorgina”, autrice anche nel 1940 del ricettario Piatti nuovi – prelibati – economici. Complemento ai libri di cucina, pubblicato anch’esso presso Sonzogno.
Come si legge nel frontespizio, il volume «contiene n° 650 ricette pratiche, economiche fra le più gustose», ripubblicate da Sonzogno nell’anno seguente, 1942, in un volume dal titolo La cucina economica, 650 ricette. Vivande sane, gustose, nutrienti realizzabili con minima spesa e con minimo consumo di grassi. La prefazione, firmata dalla stessa Giorgina, richiama a una cucina economica, fatta di cibi sani, nutrienti e gustosi, quella che può facilmente preparare anche la massaia meno esperta. Segue un piccolo ed essenziale glossario terminologico dal titolo Un po’ di terminologia (es. Battere a neve. Si dice delle chiare d’uovo che separate cautamente dal tuorlo si battono con la frusta o la forchetta fino a ridurle una massa densa e schiumosa) e due paginette con alcuni consigli elementari da usare in cucina (es. Per spellare più facilmente i pomodori lasciateli immersi qualche minuto in acqua bollente; Per sgusciare agevolmente le uova sode fatele raffreddare appena fuori del fuoco in acqua corrente; Servite sempre il fritto su un piatto guarnito di un tovagliolino e accompagnato da spicchi di limone). Per quanto riguarda il ricettario vero e proprio, Giorgina usa un linguaggio chiaro per scrivere le sue brevi e concise ricette: si inizia con il brodo e le minestre in brodo, cui seguono le paste asciutte-gnocchi-risotti. gli antipasti (i principii) freddi e caldi, le salse, le uova, i pesci, le carni, i piatti a base di ortaggi e legumi, le ricette per i dolci (Torte, dolci al forno, dolci al cucchiaio, dolci di pasticceria), quelle per le marmellate, le confetture e le conserve.
Non mancano, alla fine, le prescrizioni per bevande, sciroppi e liquori, i cui nomi vengono spesso tradotti se di provenienza non italiana: ad esempio vino caldo per “vin brulé”, code di gallo per “cocktail”. Sorprende il numero elevato di piatti a base di carne, in prevalenza di vitello, manzo, polli-piccioni-uccelli, meno quelli per il maiale o la selvaggina e i conigli. Tra una sezione di ricette e l’altra l’autrice inserisce i Consigli per la massaia, suggerimenti pratici di economia domestica per la massaia, per esempio su come conservare i cibi (Per conservare le uova), sul riutilizzo delle rimanenze (Per utilizzare le rimanenze dei pezzi di sapone), o sulla cura della casa (Come togliere macchie di caffè e di cioccolata, Per levare tracce d’umidità alla biancheria, Come distruggere gli insetti).
9.5.1. "Maccheroni ripieni"
Tratta da Giorgina, Almanacco della cucina, Milano, Sonzogno, 1941, p. 26
54. Maccheroni ripieni
54. MACCHERONI RIPIENI: 500 gr. di maccheroni; 100 gr. di carne; 50 gr. di lingua; parmigiano; 100 gr. di burro; farina; latte; un uovo; 15 gr. di funghi.
Tritate finissima la carne (avanzata) con la lingua e i funghi cotti in un poco d’olio, amalgamatevi un pugnello di mollica di pane imbevuta nel latte, condite di sale, pepe, noce moscata, legate con un uovo e mettete a parte; preparate una balsamella non troppo soda con 40 gr. di burro, 30 di farina, un bicchier di latte, e fate cuocere per 3/4 dei grossi maccheroni dal largo buco in acqua salata, allineandoli poi a sgocciolare su un tovagliolo. Prendete un piatto imburrato che regga al fuoco e copritene il fondo coi maccheroni che avrete riempito con un cucchiaio del composto di carne, distendetevi sopra uno strato di balsamella, qualche pezzetto di burro, un po’ di pangrattato, mettete altri maccheroni e continuate fino a esaurimento degli ingredienti. Terminate con la balsamella e mettete a gratinare in forno.
9.5.2. "Gnocchetti di farina"
(ibid., p. 30)
68. GNOCCHETTI DI FARINA
68. GNOCCHETTI DI FARINA: 400 gr. di farina; 100 gr. di burro; 2 uova; latte; parmigiano.
Battete a schiuma 40 gr. di burro in una terrina, fategli assorbire la farina versata a pioggia, diluite con un bicchier di latte e due uova intiere frullate a parte. Lavorate la pasta fino a quando essa si distacchi in blocco dalla terrina, poi gettatela a cucchiai in acqua bollente ben salata e fate cuocere dieci minuti, scolate, spruzzate d’acqua fredda, condite di parmigiano e di 60 gr. di burro rosolato.
9.5.3. "Risotto con frutti di mare"
(Ibid., pp. 33-34)
80. RISOTTO CON FRUTTI DI MARE
80. RISOTTO CON FRUTTI DI MARE: Un chilo di datteri; 100 gr. di olio ; aglio e prezzemolo; 300 gr. di riso; peperoncino.
Lavate a lungo i datteri (o peoci o vongole), metteteli al fuoco con due mestoli d’acqua e a mano a mano che si aprono sgusciateli e metteteli a parte senza gettare l’acqua di cottura. Fate rosolare nell’olio un pugno di prezzemolo tritato fine con due spicchi d’aglio, aggiungete i datteri, rimescolate, gettate il riso, condite di sale, pepe, peperoncino, e quando tutto l’unto sarà stato assorbito tirate a cottura coll’acqua di cottura dei datteri versata, calda, poco per volta. Servite caldissimo.
10. Bibliografia
- Pellegrino Artusi, Autobiografia, a cura di Alberto Capatti, Bra, Slow Food Editore, 2003.
- Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, introduzione e note a cura di Piero Camporesi, Torino, Einaudi, 1995 [1a ed. 1970; Introduzione alle pp. ix-lxxxvi].
- Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, a cura di Alberto Capatti, Milano, Rizzoli, 2010.
- Atti dei Convegni Artusiani 1997-2009, in Pellegrino Artusi, <http://www.pellegrinoartusi.it/convegni-artusiani/>.
- Claudio Benporat, Storia della gastronomia italiana, Milano, Mursia, 1990.
- Patrizia Bertini Malgarini, L’italiano fuori d’Italia, in Storia della lingua italiana, III, Le altre lingue, a cura di Luca Serianni, Pietro Trifone, Torino, Einaudi, 1994, pp. 883-922.
- Piero Camporesi, La terra e la luna. Alimentazione, folclore, società, Milano, Mondadori, 1989.
- Alberto Capatti, Lingua, regioni e gastronomia dall’Unità alla seconda guerra mondiale, in Storia d’Italia. Annali, 13, L’alimentazione, a cura di A. Capatti, Alberto De Bernardi, Angelo Varni, Torino, Einaudi, 1998, pp. 755-801.
- Alberto Capatti, Massimo Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Lorenzo Coveri, Parole e chiacchiere. Sui nomi, e non solo, di un dolce di Carnevale in Italia, «Bollettino dell’Atlante linguistico italiano», III s., XXXII (2008), pp. 95-102.
- Renzo Cremante, Noterelle Artusiane, «Studi e problemi di critica testuale», IV (1972), pp. 216-229.
- Emilio Faccioli, L'arte della cucina in Italia. Libri di ricette e trattati sulla civiltà della tavola dal XIV al XIX secolo, Torino, Einaudi, 1987.
- Giovanna Frosini, Un gentiluomo in cucina: Pellegrino Artusi fra lingua e gastronomia, in L’italiano a tavola. Linguistic and Literary Traditions. Atti del Convegno per la VI Settimana della lingua italiana nel mondo (Londra, 28 ottobre 2006), a cura di Anna Laura Lepschy, Arturo Tosi, Perugia, Guerra Edizioni, 2010, pp. 79-91, pp. 84-88.
- Giovanna Frosini, L’italiano in tavola, in Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di Pietro Trifone, Roma, Carocci, 2006, pp. 41-63 [2a ed. 2009, pp. 79-103].
- Giovanna Frosini, La «Scienza» degli italiani. Storie di un libro fortunato, in Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, ristampa anastatica della prima edizione 1891, Firenze, Giunti, 2011, pp. 11-34.
- Giovanna Frosini, «Lo studio e la cucina, la penna e le pentole». La prassi linguistica della «Scienza in cucina» di Pellegrino Artusi, in Storia della lingua e storia della cucina. Atti del VI Convegno ASLI, Associazione per la storia della lingua italiana (Modena, 20-22 settembre 2007), a cura di Cecilia Robustelli, Giovanna Frosini, Firenze, Cesati, 2009, pp. 311-330.
- Giovanna Frosini, La cucina degli italiani. Tradizione e lingua dall’Italia al mondo, in Marco Biffi-Vittorio Coletti-Paolo D’Achille-Giovanna Frosini-Paola Manni-Giada Mattarucco, Italiano per il mondo. Banca, commerci, cultura, arti, tradizioni, a cura di Giada Mattarucco, Premessa di Nicoletta Maraschio e Francesco Sabatini, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 85-107.
- Marzia Paola Moroni Salvatori, Ragguaglio bibliografico sui ricettari del primo Novecento, in Storia d’Italia. Annali, 13, L’alimentazione, a cura di Alberto Capatti, Alberto De Bernardi, Angelo Varni, Torino, Einaudi, 1998, pp. 889-925.
- Parole da gustare. Consuetudini alimentari e saperi linguistici. Atti del Convegno «Di mestiere faccio il linguista. Percorsi di ricerca» (Palermo-Castelbuono, 4-6 maggio 2006), a cura di Marina Castiglione, Giuliano Rizzo, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2007.
- Giuseppe Polimeni, I sinonimi in cucina: nomi di piatti e di elementi nelle ricette di Pellegrino Artusi, in Il secolo artusiano. Atti del Convegno di Firenze-Forlimpopoli (30 marzo-2 aprile 2011), a cura di Giovanna Frosini, Massimo Montanari, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 91-104.
- Saperi e sapori mediterranei. La cultura dell'alimentazione e i suoi riflessi linguistici. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 13-16 ottobre 1999), a cura di Domenico Silvestri, Antonietta Marra, Immacolata Pinto, Napoli, Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, 2002, 3 voll.
- Storia della lingua e storia della cucina: parola e cibo. Due linguaggi per la storia della società italiana. Atti del VI Convegno ASLI, Associazione per la storia della lingua italiana (Modena, 20-22 settembre 2007), a cura di Cecilia Robustelli, Giovanna Frosini, Firenze, Cesati, 2009.
- Giuseppe Vidossi, Appunti sulle denominazioni dei pani e dei dolci caserecci in Italia, «Archivio glottologico italiano», XXX (1938), pp. 69-109 [ora in G. Vidossi, Saggi e scritti minori di folklore, Torino, Bottega d'Erasmo, 1960].
Il progetto "L’italiano in cucina"
Questa sezione costituisce una prima realizzazione del progetto intitolato L’italiano in cucina. Per un Vocabolario storico della lingua italiana della gastronomia, nato dalla collaborazione fra l’Accademia della Crusca e Academia Barilla di Parma, istituzione che promuove la tradizione gastronomica italiana nel mondo.
Il progetto prevede la costituzione – già avviata – di una banca-dati di testi di cucina a partire da quello fondativo di Pellegrino Artusi (1891) per arrivare alla seconda guerra mondiale, senza escludere i più significativi testi precedenti. I materiali vengono digitalizzati e poi acquisiti in formato testuale in modo da renderli consultabili e fruibili ai fini della realizzazione di un vero e proprio vocabolario storico della lingua della gastronomia italiana, lessico che rientra nella più ampia impresa, che l’Accademia della Crusca sta progettando, di un Vocabolario dell’italiano post-unitario.