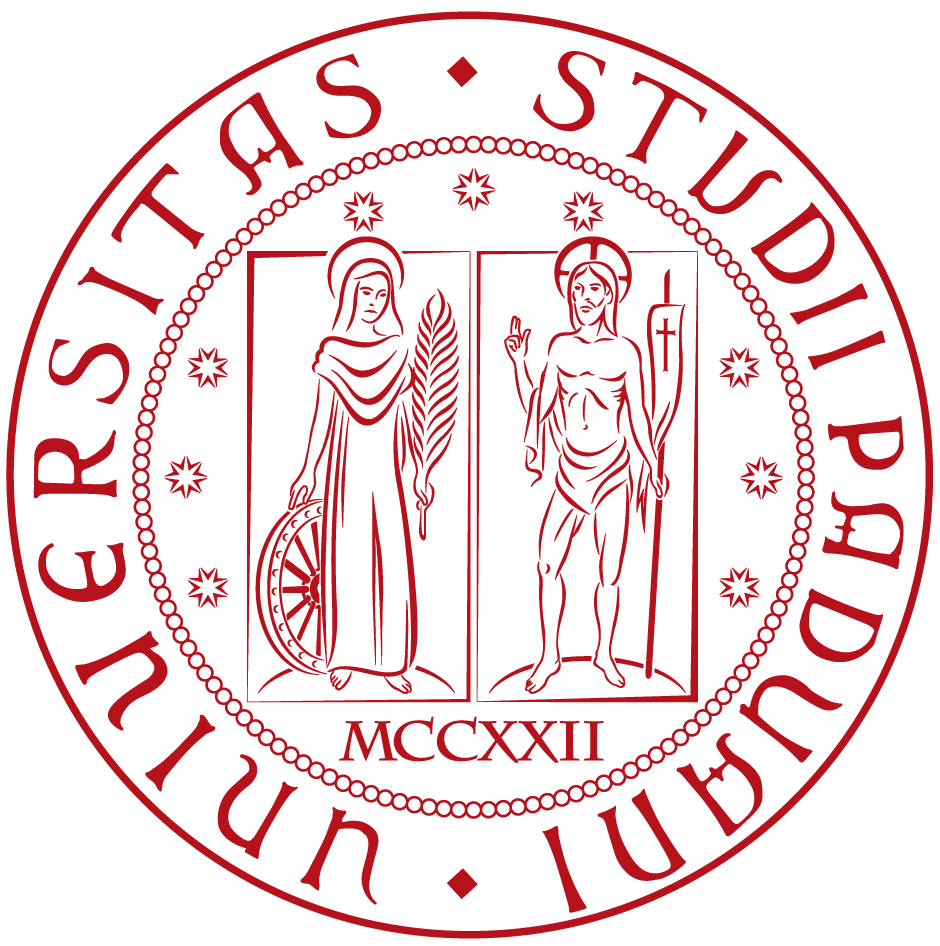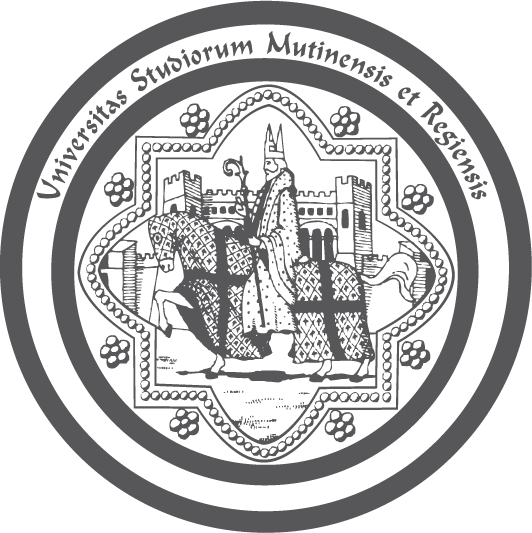Basilicata: tratti linguistici
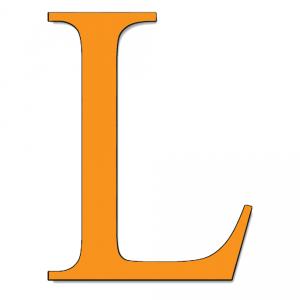
Tratti fonetici (Potenza)
- Palatalizzazione non sistematica della s seguita da c come in šcarola ma non in scarparo.
- Tendenza a non raddoppiare le consonanti b e g intervocaliche a differenza di quanto avviene nell’italiano regionale meridionale (conservativo di influenza galloitaliche): si ha quindi roba e non robba, agire e non aggire.
- Pronuncia aperta della è dove ci si aspetterebbe una é (per un incontro di tra abitudini fonetiche settentrionali con altre di tipo meridionale), quindi vènde, scènde, se ne frèga (o frèca).
- Troncamento della sillaba finale nei participi passati come venù, o in parole tronche anche in dialetto come ad esempio uagliò.
Tratti morfosintattici (Potenza)
- L’aggettivo possessivo precede i nomi di parentela (mentre nei dialetti meridionali è prevalente lo spostamento del possessivo in fondo al nome del tipo sòreta ‘tua sorella’), quindi mi frà ‘mio fratello’, ta ssuora ‘tua sorella’.
- Prevalenza della preposizione locativa in, dove l’italiano regionale meridionale predilige a, quindi ngasa (‘in casa’) invece di a casa.
- Presenza di dialettismi passati nell’italiano locale come gn’è ‘c’è’ che viene usato in alcuni casi al posto del tipico meridionale stare per ‘essere’; la forma anna per ‘deve’, quindi anna venì ‘deve venire’.
Lessico
Nel lessico potentino fagliare (con il relativo participio presente fagliante) per ‘sbagliare’ è stato riconosciuto come probabile provenzalismo, mentre tra i dialettismi passati in italiano troviamo chitaro ‘freddo’, chiatrare ‘gelare’, un cittadino ‘un tale’, cuscio ‘rozzo’, legittimo ‘sobrio’, pelliccio ‘cafone’, scuma ‘persona volgare’, tònza ‘pozzanghera’. Tra i regionalismi letterari, di carattere genericamente meridionale, sanno la mia faccia ‘conoscono’, cacciare il discorso ‘tirare fuori’, chiatto ‘ grasso’, non fidarsi più ‘non sentirsela, non farcela’, regalare ‘dare la mancia’. Numerosi anche i nomi del lessico gastronomico con cavatelli, fusilli, ferretti, strazzata o ruccolo ‘focaccia rotonda con buco al centro’.