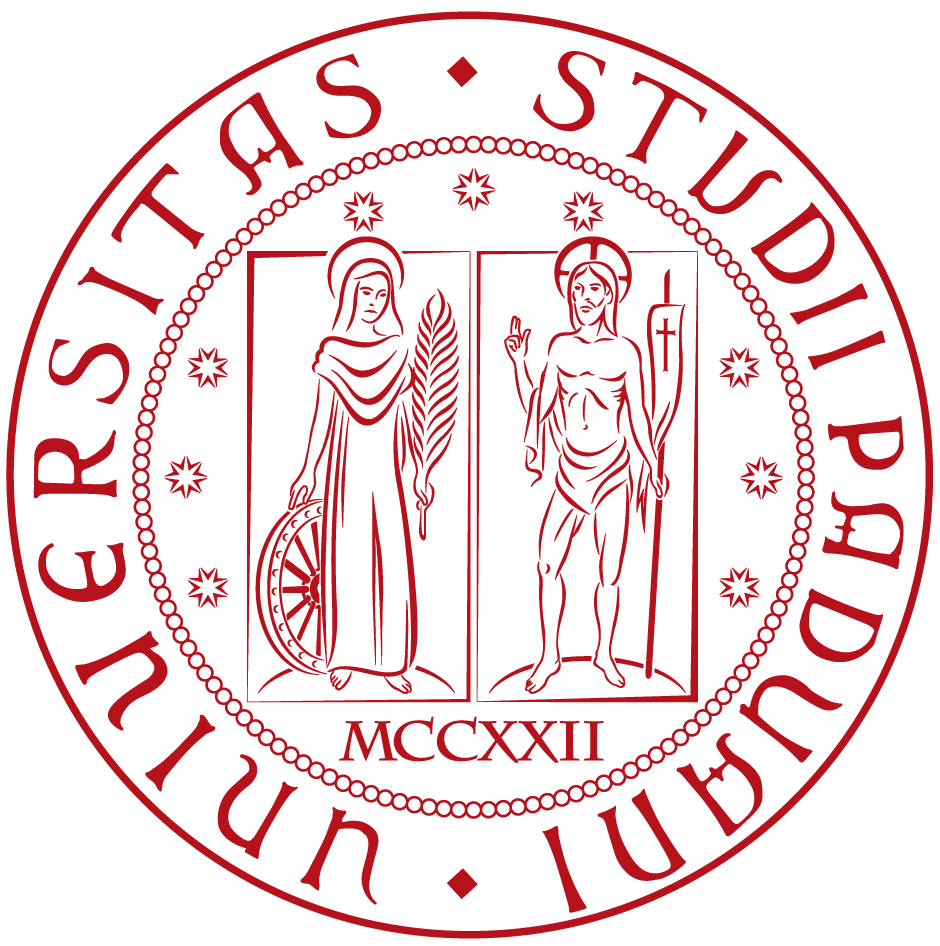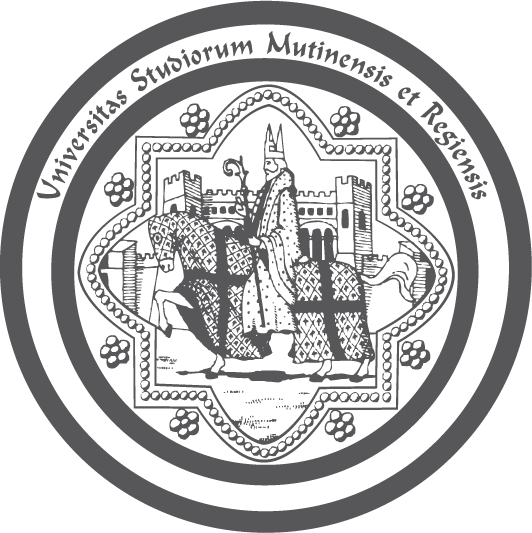La lingua di Alfieri

A proposito della lingua che Alfieri usa nelle sue tragedie pi√Ļ mature, Antonio Sorella scrive che il letterato «ha raggiunto ormai una scaltrita padronanza del linguaggio tragico, tanto da avvertirlo come a s√© stante, differente da quello di tutti gli altri generi letterari cos√¨ come da quello della conversazione quotidiana. Da questo atteggiamento deriva la propensione verso frasi rotte o fortemente sincopate»[1].
Un esempio della sintassi franta del linguaggio tragico di Alfieri è dato dal brano seguente, tratto dal Saul, nel quale il protagonista risponde con asprezza al figlio Gionata che gli prospetta scenari di pace dopo la vittoria sui Filistei:
SAUL
Or, forse
me tu vorresti di tua stolta gioia
a parte? me? ‚Äí Che vincere? che spirto ?...
Piangete tutti. Oggi, la quercia antica,
dove spandea gi√† rami alteri all’aura,
innalzerà sue squallide radici.
Tutto è pianto, e tempesta, e sangue, e morte:
i vestimenti squarcinsi; le chiome
di cener vil si aspergano. Sì, questo
giorno, √® fatale; a noi l’estremo, √® questo.
[Vittorio Alfieri, Saul, a cura di A. Momigliano, Firenze-Messina, D’Anna, 1962; Atto II, sc. 2, p. 61)]
La «scaltrita padronanza» di cui parla Sorella √® frutto di un lungo apprendistato: la lingua d’origine era per Alfieri, nato nel Piemonte sabaudo, il francese e in francese scrisse le sue prime lettere e i suoi primi scritti letterari, come francese era la sua lingua di conversazione. Ma quando nel ľ76 lasci√≤ Torino per la Toscana, intendeva “spiemontesizzarsi” e “sfrancesizzarsi”, facendosi cittadino del regno ideale delle lettere e cercando nel toscano della tradizione pi√Ļ alta l’italiano dei suoi eroi. Come scrive nella lettera di risposta a quella inviatagli da Ranieri de’ Calzabigi «la nostra lingua, diversamente da tutte le altre nelle vicende sue, √® nata gigante, e direi, come Pallade dalla testa di Giove, tutta armata».
[1] Antonio Sorella, La tragedia, in Storia della lingua italiana, a cura di L. Serianni e P, Trifone, Torino, Einaudi, 1993, vol. I. I luoghi della codificazione, p. 781.