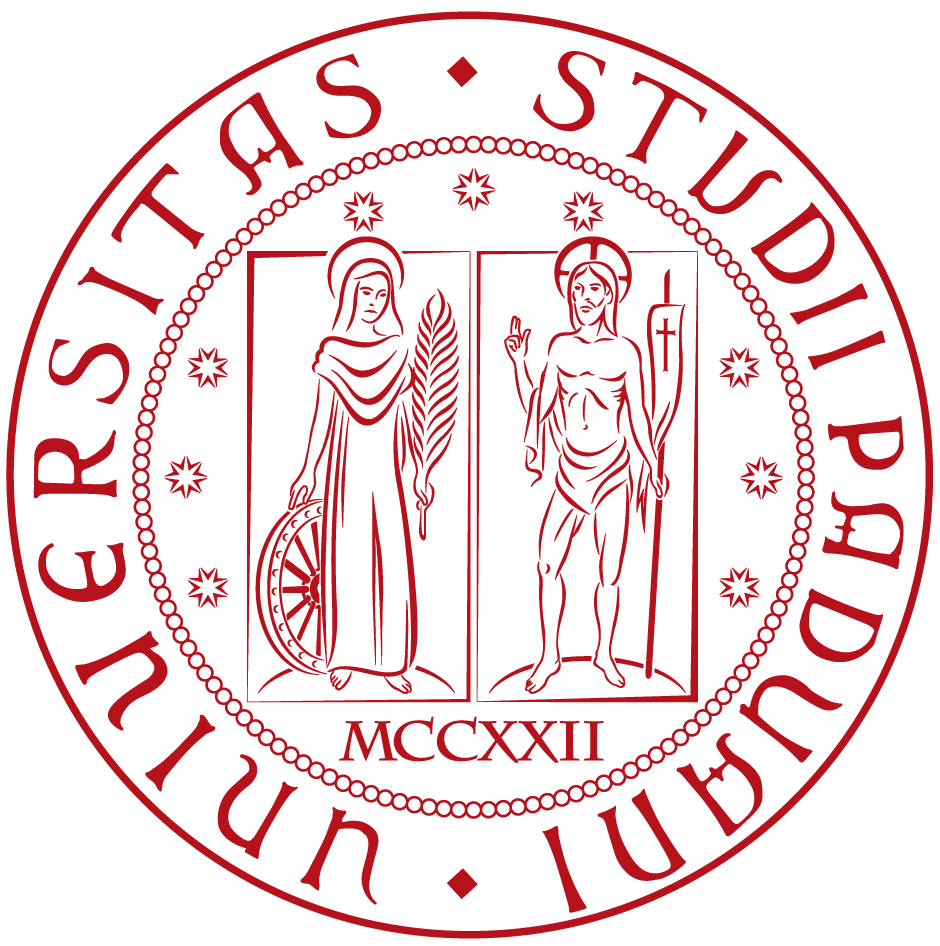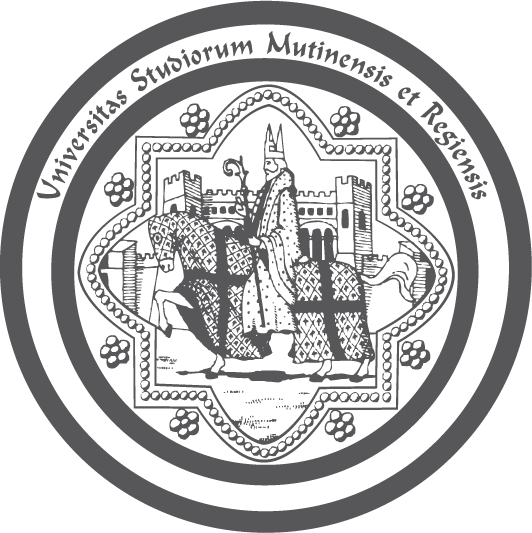"I Promessi Sposi": Gertrude

Manzoni racconta la storia di Gertrude, la monaca di Monza, nel capitoli cap IX e X dei Promessi Sposi.
Il personaggio complesso e misterioso di Gertrude, da tutti chiamata la signora, è introdotto dalle parole del padre guardiano a cui Agnese e Lucia, giunte al monastero di Monza, domandano notizie sulla potente badessa che dovrebbe offrire loro rifugio e ospitalità:
– La signora, – rispose quello, – è una monaca; ma non è una monaca come l’altre. Non è che sia la badessa, né la priora che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani: ma è della costola d’Adamo; e i suoi del tempo antico erano gente grande, venuta di Spagna, dove son quelli che comandano; e per questo la chiamano la signora, per dire ch’è una gran signora.
L'avversativa ma e le disgiunzioni né e né sono tratti linguistici ricorrenti nella descrizione di Gertrude, utilizzati per segnalare anche a livello sintattico le contraddizioni e gli opposti sentimenti che regnano nel suo animo. La prima immagine che Manzoni dà di lei è quella di una prigioniera, in piedi (ritta) dietro una finestra d'una forma singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo, stretta dentro bende candide che le cingono la fronte e le circondano il viso, come per impedire ogni movimento. Eppure la bellezza di questa donna che poteva dimostra venticinque anni è sbattuta, sfiorita, quasi scomposta.
Il ritratto fisico della monaca di Monza è giocato su continui contrasti, nell'alternarsi del chiaro con lo scuro (velo nero, bianchissima benda, nero saio, fronte non d'inferiore bianchezza, occhi neri neri, gote pallidissime) e dell'immobilità con il movimento; nella figura dritta rigida e che appare all'inizio dietro le sbarre, si iniziano subito a intravedere e diventano sempre più frequenti segnali di tipo opposto: la fronte si raggrinza spesso, come per una contrazione dolorosa, le sopracciglia si ravvicinano, con un rapido movimento,il corpo ha mosse repentine, irregolari e troppo risolute.
Ancora una volta la presenza dell'avversativa ma (ma d'una bellezza sbattuta [...], ma non d'inferiore bianchezza [...], Ma quella fronte […], ma alterato [...])sottolinea questa lacerazione interna.
Sono soprattutto gli occhi neri neri della Signora a esprimere il contrasto più stridente: due occhi che a volte fissano con superbia, a volte si chinano in fretta, come per cercare un nascondiglio, a volte sembrano chiedere affetto, corrispondenza, pietà , a volte, per un istante, rivelano la presenza di un odio profondo e radicato (inveterato), a stento tenuto a freno (compresso), un non so che di minaccioso e feroce. Sono occhi misteriosi, difficili da decifrare: chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo. Manzoni termina questo ritratto in bianco e nero con l'immagine del ciuffo di capelli neri che sfugge dal velo non si sa se per dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, una pennellata scura sulla tempia bianca, un segno appena accennato (ciocchettina) eppure così evidente di un travaglio interiore difficile da nascondere e da tenere a freno.
Dopo che la signora ha concesso ad Agnese e Lucia ospitalità nel suo convento, Manzoni inizia a narrare per esteso la storia della monaca misteriosa.
Si scopre così che Gertrude era ultima figlia del principe ***[1], gran gentiluomo milanese che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell’uno e dell’altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservar la famiglia, a procrear cioè de’ figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera. Con profonda pietà Manzoni racconta il feroce condizionamento esercitato su una bambina ignara, destinata ancor prima di nascere a soddisfare le regole spietate della famiglia e della società, incarnate dal principe suo padre:
La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l’idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa d’alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavan monache; e que’ regali eran sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto; come cosa preziosa, e con quell’interrogare affermativo: – bello eh? –
Saranno vani tutti i tentativi di Gertrude di sottrarsi a quella vocazione imposta, a una vita che non sente sua. Il condizionamento psicologico esercitato inesorabilmente dal padre instilla in lei un forte senso di colpa, che fa leva sul suo bisogno di affetto ed alla fine la piega e la costringe e corrisponde alle aspettative della famiglia:
Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, d’esser trattata diversamente. Pensò al padre, alla famiglia: il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici; e provò una gioia improvvisa. Dietro questa, una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo, e un ugual desiderio d’espiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c’era entrata con tanto ardore. S’alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera piena d’entusiasmo e d’abbattimento, d’afflizione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.
Attraverso questa storia esemplare, lo scrittore condanna in modo durissimo una società in cui l'interesse economico e i principi dinastici calpestano gli affetti e i diritti della persona, utilizzando senza scrupolo la sacralità della vocazione monastica. Così inizia il capitolo X, dedicato ancora a Gertrude:
Vi son de’ momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco d’istanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrifizio: come un fiore appena sbocciato, s’abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prim’aria che gli aliti punto d’intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, son quelli appunto che l’astuzia interessata spia attentamente, e coglie di volo, per legare una volontà che non si guarda.
Gli anni della sua infelice giovinezza sono segnati da un continuo tormento e dallo scivolare inesorabile verso un destino a cui Gertrude sogna e s'illude di potersi sottrarre:
Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro sé stessa, faceva tristamente il conto dell’occasioni, che le rimanevano ancora di dir di no; e prometteva debolmente e confusamente a sé stessa che, in questa, o in quella, o in quell’altra, sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri, non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre; talché, quando, con un’occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c’era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa, e fu, per un istante, tutta contenta.
Alla fine soccombe alla sua fragilità e alla volontà della famiglia:
Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d’entrar più presto che fosse possibile, nel monastero. Non c’era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà; e, condotta pomposamente al monastero, vestì l’abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre.
Per narrare la storia di Gertrude Manzoni utilizza in modo estremamente efficace una modalità di scrittura detta reticenza (dal latino reticere, tacere) o sospensione, che consiste nell'interrompere improvvisamente un discorso per dare l'impressione di non voler o di non poter proseguire, lasciando al lettore il compito di immaginare ciò che è accaduto e come si è conclusa la vicenda. L'esempio più significativo di reticenza è rappresentato dall’espressione la sventurata rispose, con cui Manzoni fa comprendere la tragica conseguenza della scelta di Gertrude:
Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.