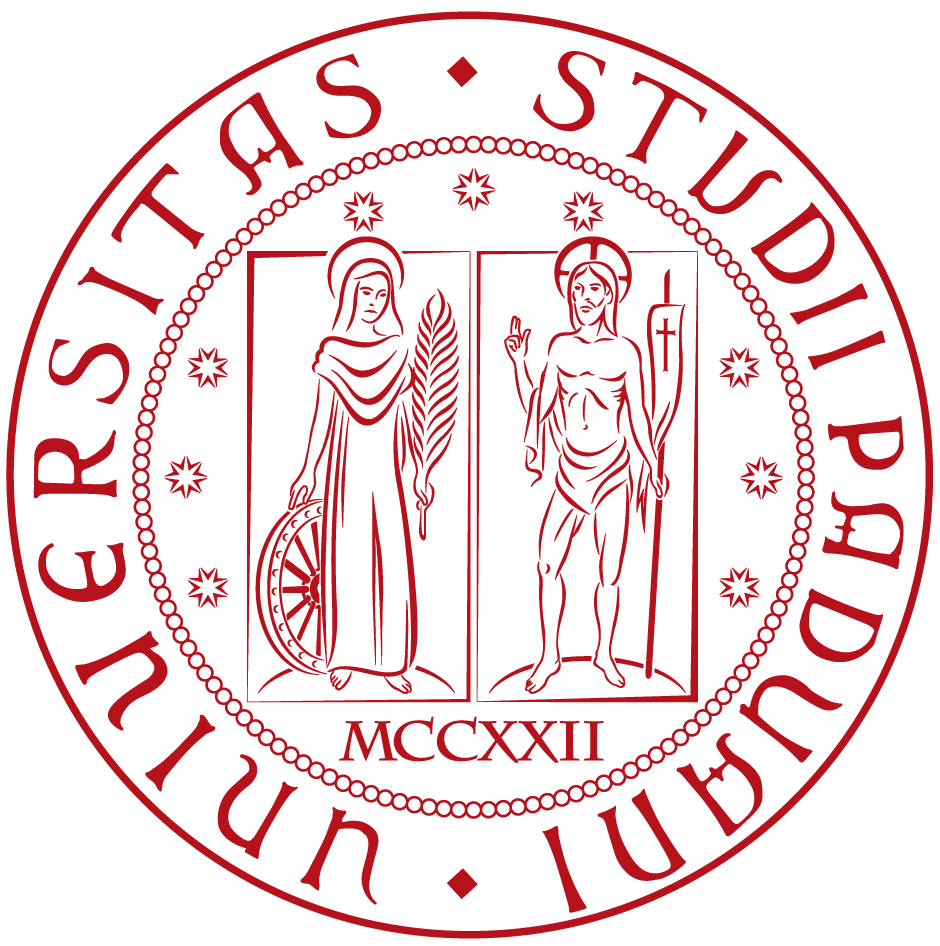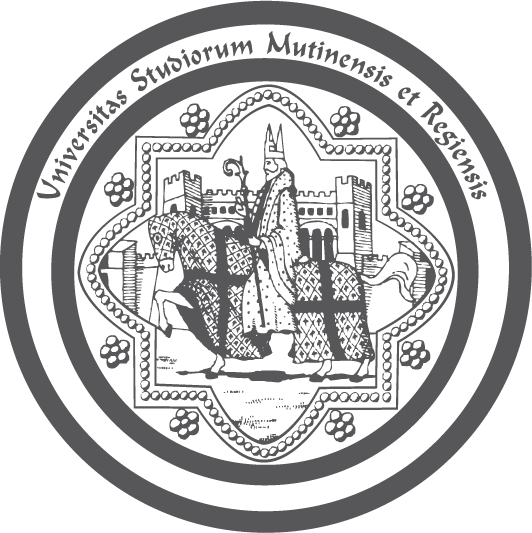Toscana: testi
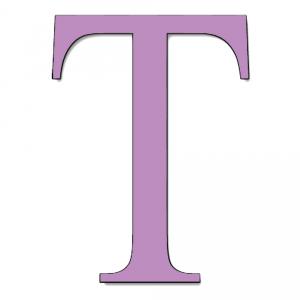
Da Romano Bilenchi, La Siccità (Firenze, 1941), [tratto da L. Caretti e G. Tellini, Testi del Novecento letterario italiano, Milano, Mursia, 1990, pp. 898-900]
Un errore geografico
Gli abitanti della città di F. [Firenze] non conoscono la geografia; la geografia del loro paese, di casa propria. Quando da G. [loalità probabilmente immaginaria] andai a studiare a F. mi avvidi subito che quella gente aveva un’idea sbagliata della posizione del mio paese nativo. Appena nominai G. mi dissero: «Ohé, maremmano!».
Un giorno, poi, mentre spiegava non ricordo più quale scrittore antico, il professore d’italiano cominciò a parlare di certi pastori che alle finestre delle loro capanne tenevano, invece di vetri, pelli di pecore conciate fini fini. Chissà perché mi alzai , dall’ultimo banco ove sedevo, e dissi: – Sì, è vero: anche da noi i contadini appiccicano alle finestre delle loro casupole pelli di coniglio o di pecora al posto dei vetri, tanto è grande la loro miseria –. Chi sa perché mi alzai e dissi così; […] Appena in piedi dinanzi alla classe sentii ogni impulso frenato e m’accorsi d’averla detta grossa. Sperai che il professore non fosse al corrente degli usi della mia provincia, ma lui, a quella uscita, alzò la testa dal libro e disse: – Non raccontare sciocchezze –. Dopo un momento rise e tutti risero, anche per compiacerlo. – Ma aspettiamo un po’ – disse poi – forse hai ragione. Il tuo paese, G., non è in Maremma? È probabile che in Maremma vadano ancora vestiti di pelle di pecora.
Di nuovo tutti si misero a ridere. […]
Cominciai, e questo fu il mio errore, a rispondere a ciascuno di loro, via via che aprivano bocca. Ero uno dei più piccoli e ingenui della classe, e ben presto fui preda di quella masnada. Benché appartenessero a famiglie distinte, c’era fra loro soltanto un figlio di bottegaio di mercato arricchito, come avevo potuto osservare dalle mamme e dai babbi che ogni mese venivano alla scuola, me ne dissero di ogni colore. Infine con le lacrime agli occhi, approfittando di un istante di silenzio, urlai: – Professore, G. non è in Maremma.
- È in Maremma.
- No, non è in Maremma.
- È in Maremma – disse il professore a muso duro. – Ho amici dalle tue parti e spesso vado da loro a cacciare le allodole. Conosco bene il paese. È in Maremma.
- Anche noi di G. andiamo a cacciare le allodole in Maremma. Ma dal mio paese alla Maremma ci sono per lo meno ottanta chilometri. È tutta una cosa diversa da noi. E poi G. è una città – dissi.
- Ma se ho veduto dei butteri proprio al mercato di G. – disse lui.
- È impossibile. Sono sempre vissuto lì e butteri non ne ho mai veduti.
- Non insistere, non vorrai mica far credere che io sia scemo?
- Io non voglio nulla – dissi – ma G. non è in Maremma. Al mercato vengono venditori ambulanti vestiti da pellirosse. Per questo si potrebbe affermare che G. è in America.
- Sei anche spiritoso – disse lui. – Ma prima di darti dello stupido e di buttarti fuori di classe dimostrerò ai tuoi compagni come G. si trovi in Maremma.
Mandò un ragazzo a prendere la carta geografica della regione nell’aula di scienze […] Sulla carta […] il professore riuscì a convincere i miei compagni, complici la scala 1:1.000.000 e altre storie, che G. era effettivamente in Maremma. […]
Tacqui avvilito. Da quel giorno fui “il maremmano”. Ma ciò che m’irritava di più era, in fondo, l’ignoranza geografica del professore e dei miei compagni.
 Da Vasco Pratolini, Le ragazze di Sanfrediano (Firenze, Vallecchi, 1952 [Ia uscita in rivista nel 1949], pp. 5-7)
Da Vasco Pratolini, Le ragazze di Sanfrediano (Firenze, Vallecchi, 1952 [Ia uscita in rivista nel 1949], pp. 5-7)
Il Rione dei beceri modello. Il rione di Sanfrediano è «di là d’Arno», è quel grosso mucchio di case tra la riva sinistra del fiume, la Chiesa del Carmine e le pendici di Bellosguardo.; dall’alto, simili a contrafforti, lo circondano Palazzo Pitti e i bastioni medicei; l’Arno vi scorre nel suo letto più disteso, vi trova la curva dolce, ampia e meravigliosa che lambisce le Cascine.
Quanto v’è di perfetto, in una civiltà diventata essa stessa natura, l’immobilità terribile ed affascinante del sorriso di Dio, avvolge Sanfrediano, e lo esalta. Ma non tutto è oro ciò che riluce. Sanfrediano, per contrasto, è il quartiere più malsano della città; nel cuore delle sue strade, popolate come formicai, si trovano il Deposito Centrale delle Immondizie, il Dormitorio Pubblico, le Caserme. Gran parte dei suoi fondaci ospitano i raccoglitori di stracci, e coloro che cuociono le interiora dei bovini per farne commercio, assieme al brodo che ne ricavano. E che è gustoso, tuttavia, i sanfredianini lo disprezzano ma se ne nutrono a fiaschi.
[…] Ci pensa l’allegro, rissoso clamore della sua gente, ad animarli: dal rivendugliolo e stracciaiolo, all’operaio delle non lontane officine, all’impiegato d’ordine, all’artigiano marmista, orefice, pellettiere le cui donne hanno anch’esse, nella più parte, un mestiere. Sanfrediano è la òpiccola repubblica delle lavoranti a domicilio: sono trecciaiole, pantalonaie, stiratrici, impagliatrici che dalla loro fatica, sottratta alla cura della casa, ricavano ciò che esse chiamano il “minimo superfluo” di cui necessita una famiglia, quasi sempre numerosa, alla quale il lavoro dell’uomo apporta, quando c’è, il solo pane e companatico.
Questa gente di Sanfrediano, che rappresenta la parte più becera e più vivace dei fiorentini, è la sola a conservare autentico lo spirito di un popolo che perfino dalla propria sguaiataggine seppe ricavare della leggiadria; e dal suo ingegno, in verità, una perpetua improntitudine.
 Da Giovanni Nencioni, Autodiacronia linguistica («Quaderni dell’Atlante Lessicale Toscano», 1, 1983)
Da Giovanni Nencioni, Autodiacronia linguistica («Quaderni dell’Atlante Lessicale Toscano», 1, 1983)
Immaginate dunque, a Firenze, a cavallo della prima guerra mondiale, un bambino figlio di piccoli borghesi in via di diventare medio-borghesi (uno dei quali si serviva dell’intelletto soprattutto come congegno computistico per sbarcare il lunario), rallevato in casa e diviso fra una casa dove sonavano soltanto le voci della famiglia, e la scuola elementare; privo di confronti linguistici che non fossero coi compagni di scuola, coi nonni e gli zii, con qualche amico dei genitori, con le donne di servizio, per lo più campagnole; privo anche dell’informazione che oggi diciamo convogliata dalle immagini e voci artificiali del cinema sonoro, della radio, della televisione. Un bambino addirittura bamboccio. Ignaro e selvatico, ma schietto: né sornione, né machione, né gestroso, un ficoso che spelluzzica, fa le boccucce e tutti dicono: «Che calìa!» Ma screanzato e piccoso sì, nonostante l’aspetto bofficione: quando metteva peso ritto, erano forbici fino in fondo. La nonna paterna lo spacciava come «ignorante», la mamma, che lo coccolava, riparava ogni volta nel dire che il bambino aveva le cheche e che era fatto così: che delle più piccole cose faceva tanti casimisdei. Il babbo gli rinfacciava la mania, il ripicco, concludendo sempre: «Questo figliolo non ha punto gnegnero. Andrà sempre in cerca di Frignuccio». E difatti era un diociliberi: una ne faceva e una ne pensava, le cavava di sottoterra. Ora gli saltava il grillo di stare alle smerie negli sparaventi e sotto una sizza che levava il pelo, o di strogolare fradicio mézzo nella molletta sotto un’acqua che Dio la mandava; ora, acquattato dietro la cantonata, beccava con la fionda quel randellone del figliolo del dirimpettaio, che era un fumino, o tirava di scancìo una gragnola di sassolini nella sua finestra; ora si fabbricava una rozza ma tonante polvere nera con salnitro, carbone e zolfo. «E un dicatti – faceva indispettita la nonna materna (quella che aveva conosciuto Collodi prima che scrivesse Pinocchio) –, è un dicatti che non c’è preso un coccolone, che non è successa una disgrazia. Ma che vi gira? Labbrate a quello Dio, botte dell’ottanta ci vorrebbero! Se fosse ai ferri miei, lo vedresti !» «Checchè – diceva la mamma, contraria alla pedagogia manesca –, checchè! Non è con le botte che i ragazzi metton giudizio». «Parole sante – ribadiva la nonna – ma non per le buone lane. Con quelle non c’è verso».
E davvero non c’era verso di fargli metter giudizio, né con le buono né con le cattive. A volte la buona lana sortiva di casa tutto pulito, e forse con le meglio intenzioni, ma tornava sudicio come un baston di pollaio. Mi par di vederlo: nero come il bracino, con sulla pelle una roccia alta un dito che ci voleva il sapone da cucina a portarla via, e col grembiule pieno di gore, che insieme al sapone ci voleva il ranno; quando non s’era fatto un sette nei calzoni (figuratevi) di fustagno o di rigatino, che gli diventavano subito ragnati, tanto li arrotava. Per non dire delle corse a rotta di collo, delle arrampicate, delle scalmane: eccotelo stanco rifinito, trafelato, coperto di vidaleschi, di pinzi, dì cocciòle. A vederlo conciato a quel modo, segnato come un ecceomo, anche la mamma gli appioppava una sfilza di titoli di cui brindellone e bracalone erano i più zuccherati. Ma poi, rimboccandosi le maniche : «Santa pazienza! Ovvia, rifacciamoci daccapo!».
Brindellone sì, bighellone mai, perché, bisogna rendergli giustizia, quel diociliberi a scuola ci andava, e ci andava spedito. Si levava a bruzzico per ripassare le poesie imparate a memoria e, una volta a cecce dietro il suo banco, stava zitto e attento. Non era uno che se la sbirbava, insomma, e non c’era bisogno di sfegatarsi a raccomandargli: «Portati bene!». E sì che a scuola quel vecchio maestro, che seminava frasconi striminzito nel suo sarrocchino, dava esercizi che erano supplizi: come «Ricopiate per intero cinque volte la coniugazione del verbo amare!». A casa poi, quando era il tempo di far le lezioni, avresti detto che un accidente senza requie come quello si sarebbe buttato a finirle intrafinefatta a costo di chissà che scerpelloni; invece no: stava a sizio ore e ore, chiotto chiotto, e lavorava di buzzo buono a farle perbene. Non poteva soffrire le libréttine, e neanche la calligrafia: tra le due ugge, tarabaralla! Pure, picchia e ripicchia riuscì a far di conto e a farsi leggere. Ma quel tiritessi, quel biribissaio dell’analisi logica e dell’analisi grammaticale, quelle due cose somiglianti e differenti, distinte e confuse, prima di ritrovarcisi dovette prendere un impegno d’onore con se stesso e vincere la tentazione di fare berlicche berlocche. Per fortuna ogni tanto in quel grigiume c’era una speratina di sole: una filastrocca, una poesia, un raccontino.
Come divertimenti, si contentava di poco. Balocchi non ne aveva certo a bizzeffe; per lo più si baloccava smontando i pochi che gli regalavano e, di nascosto, qualche orologio di casa, per scoprirne l’ingegno.


Da Marco Vichi, Morte a Firenze (Prma, Guanda, 2009, pp. 253-254)
Allo stadio scese dal camion, salutò i militari e se ne andò con la 1100. Si mise in contatto con la questura: niente di nuovo, come sempre. Disse alla sua guardia che avrebbe richiamato più tardi e chiuse il collegamento. Sperava che la trattoria di Cesare fosse aperta, visto che non era stata raggiunta dall’inondazione. Imboccò viale Lavagnini, e quando vide la vetrata illuminata si sentì sollevato. Aveva proprio voglia di fare due chiacchiere con totò.
I tavoli erano quasi tutti occupati, e un vocio compatto riempiva la sala. Scambiò qualche parola con Cesare, ovviamente racconti di melma e di fango.
«Vado da Totò.»
«Stasera non c’è molta scelta.»
«Mi va bene tutto.» Salutò Cesare e s’infilò in cucina. Totò gli fece un sacco di feste, come se non lo vedesse da un anno. Gli raccontò che l’acqua era arrivata a venti centimetri dal suo appartamento, e per un giorno intero era rimasto bloccato in casa.
«E la tua Nina?»
«Nessun pericolo, sta a Serpiolle.»
«Quand’è che vi sposate?»
«Un po’ di pazienza, è appena un anno che ci conosciamo… Che fame avete commissario?»
«In tutto il giorno ho mangiato solo un panino.»
«Ribollita e ossobuco va bene?»
«Benissimo…»
«Meglio per voi, c’è solo quello» rise il cuoco.
«Mi sarei mangiato anche una cipolla a morsi.» Dopo un minuto si ritrovò davanti un mastello di ribollita fumante, e ascoltando i racconti di Totò la finì tutta, con l’aiuto di diversi bicchieri di vino. Attaccò l’ossobuco con il contorno di fagioli, più affamato di prima. Pane a volontà. Il fiume di parole del cuoco allagava la cucina. Bordelli si limitava a grugnire, e intanto sentiva crescere la voglia di rivedere Eleonora. La torta alla crema la mandò giù a fatica, a differenza del vin santo che scorreva bene. Come al solito aveva mangiato e bevuto troppo, e giurò che la prossima volta… Alle dieci rifiutò la grappa e si alzò.