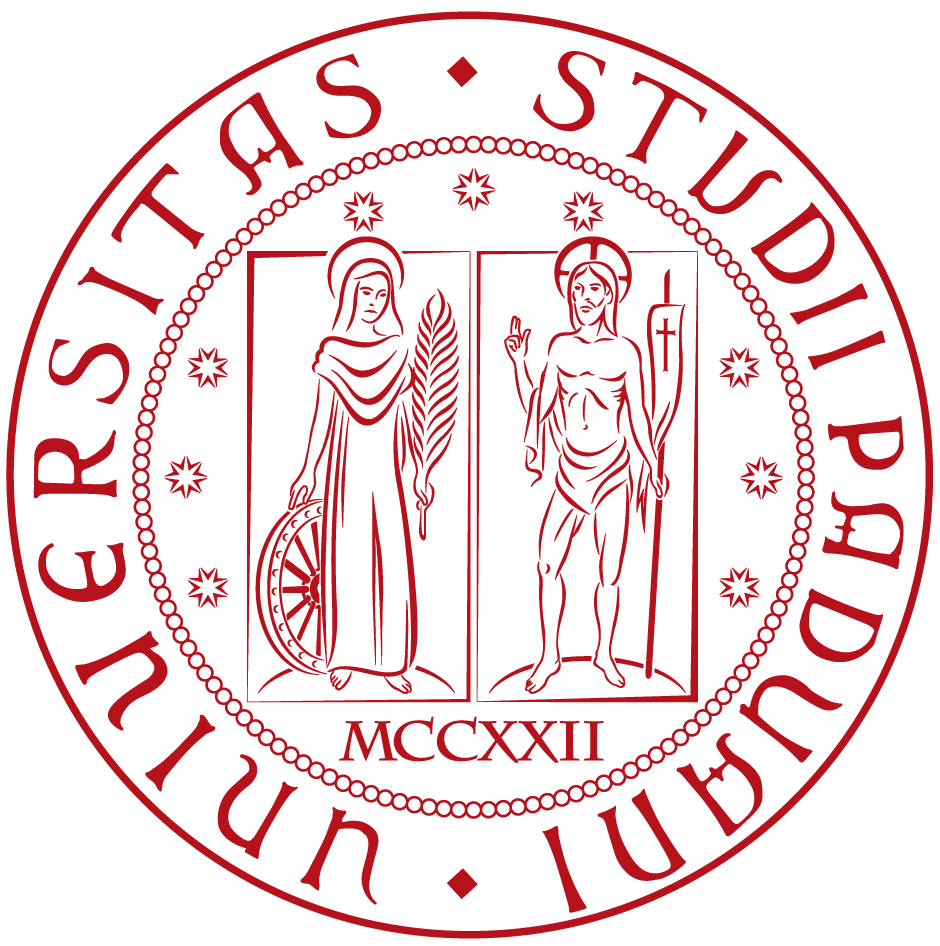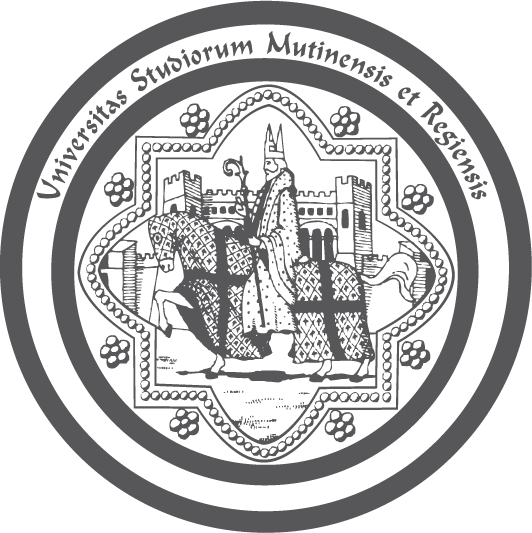Veneto: testi
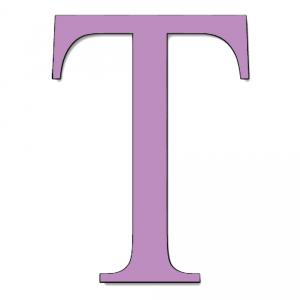
Idioma gentile:
A noi piccolo veneziano. A te pure, quando che parli italiano, vien fatto di ficcare il che da per tutto, e non sei buono da liberartene, e dici: non so cosa che voglia dire, non so cosa che ci vorrebbe; e ti scappa detto lasciarsi tirar giù per «lasciarsi indurre» e che bello e che caro, e incapricciarsi in una cosa, e non s’indubiti, e l’aspetta un momento; e ti sfugge ben sovente scampare per «scappare» e balcone per «finestra» e altana per «terrazza» e sgabello per «comodino». E che dire del tuo in fatti che usi spesso nel senso di «insomma», mettendo nella frase una contraddizione di termini che mi fa spalancare la bocca? – Sarà un capolavoro, come tutti dicono; ma in fatti non mi piace. – Hai ragione di burlarti degli idiotismi altrui, ma in fatti ne dici tu pure. [da E. De Amicis, Idioma gentile, Milano, Treves, 1920 [1906], p. 50]
da M. Rigoni Stern, Polenta e formaio zè bon, in Racconti della Resistenza, Torino, Einaudi, 2005
La malga Hotara comparve improvvisamente dentro la conca. Il fumo usciva dal camino e sotto, lungo gli sporti, si era accumulata la grandine.
Le pozze dell’abbeverata riflettevano il cielo e anche le vacche vi si specchiavano. La mandria, tranquilla e sparsa, pascolava l’erba verdissima tra il bianco delle pietre e della grandine. Un cane grigio e fulvo si avvicinò ai due senza abbaiare; li annusò e poi scodinzolò. Luisa chiese permesso a voce alta e spinse la porta.
Il casaro [chi fa il formaggio] stava rimestando il latte con la lira [attrezzo per lavorare il formaggio] dentro la grande caldaia per rompere la cagliata; una donna anziana era seduta su una panca a rammendare un paio di scalfarotti [calzerotti di lana pesante]. – Levatevi di dosso quella roba bagnata e avvicinatevi al fuoco, - disse la donna […]
Intorno a mezzogiorno arrivarono in casara [luogo dove si lavora il formaggio] anche i due ragazzi che erano fuori a sorvegliare le vacche. Salutarono i nuovi ospiti con cortesia. Il casaro che era andato a governare il formaggio [controllare la salatura del formaggio] nella stanza della salagione, rientrando disse: - È cotta, buttala fuori.
La polenta gialla e soda fu in un attimo in mezzo alla tavola e il suo profumo si diffuse per la stanza. […]
Mio nonno Gigi mi diceva che un tempo si mangiava solamente polenta e formaggio.
È la seconda volta che nomina suo nonno, - osservò il casaro.
È stato qui a fare il partigiano. –
L’uomo alzò la testa dal piatto: - Come si chiamava? – chiese.
Si chiamava Luigi Millo, è ancora vivo. –
Come si chiamava qui, da partigiano. –
Come puoi ricordare, - intervenne la donna, - allora eri un ragazzo.-
Lo chiamavano Teròn, anche come nome di battaglia, perché era del sud.
Il teròn! – esclamò il casaro. – Ci faceva ridere quando voleva parlare in dialetto. Mi diceva sempre: «Bocia [ragazzo], polenta e formaio zè bon, ma zè bon anche spaghetti con la pommarola ’coppa».
da L. Meneghello, Libera nos a malo, Milano, Mondadori, 1986
Una parola credo di averla introdotta io a malo, un pomeriggio. Eravamo in molti nel cortile della nonna, c’era un mucchio di sabbia e stavamo facendo certe invenzioni capricciose di castelli e torri, con grande eccitazione e trambusto. A un certo punto vidi che la costruzione accennava a incrinarsi e dissi: “Crolla!”. La parola magica sentita da me chissà dove, sconosciuta a tutti gli altri ma immediatamente capita, si sparse come una vampata. Tutti borbottavano “crolla, crolla”, affaccendandosi, mentre la nostra opera si accasciava. La parola nuova era l’evento stesso.
Avevo avuto delle avventure con le parole fin dal tempo dell’asilo (o come si diceva scola-l’esìlo), dove il mio arrivo era stato amareggiato da un’inattesa esperienza linguistica e insieme sociale. Fu quando espressi ingenuamente il proposito di fare pissìn, la sola espressione che conoscevo in materia, e fui deriso a lungo come una specie di signorina da quei sodi popolani tra i due e i cinque anni che dicevano soltanto pissare.
Enrico ha problemi linguistici analoghi a quelli che avevo io alla sua età. È stato a Vicenza con sua mamma, che è l’Annamaria, e s’è incantato ad ascoltare due signore che parlavano in italiano davanti a una vetrina. “Ciò”, disse alla mamma, “che lingua ze che le parla quelle lì?” L’Annamaria si vergognò molto, e stabilì di cominciare a dargli lezioni d’italiano ancora quella sera stessa.
da M. Paolini e G. Vacis, Il racconto del Vajont, Milano, Garzanti, 1997
La diga!
Quattro minuti…
“È cascà la dig…”
Quattro minuti da quando l’acqua salta la diga a quando arriva a Longarone… Corre a 80 all’ora dentro quella gola, l’acqua. Irrompe come un treno in corsa, grande come cinquemila treni uno dietro l’altro!
Quattro minuti per decidere come muori o come vivi… “Via, a piedi, su per la montagna, corri, corri… “Via! Quelli che prendono la macchina, quelli che ciapa il motorin… “Aspettami vigliacco…”Quelli che prendono a piedi su per la montagna, che par che non ce la faranno mai, sono gli unici che si salvano. E trema tutto… “Aspetta vigliacco!”. E cominciano a volar coppi. Cosa fai?... Quelli che vanno a casa…
[…]
E intanto s’intorbidisce l’aria… Comincia a tremar la terra, a volar travi, careghe [sedie], e spacca le antenne e spacca i rami… È tutto torbido, torbido, torbido… questo rumore… Vento che ti assorda la terra che ti trema sotto i piedi… E lo capisci che sta arrivando acqua, perché c’è l’odor dell’acqua…