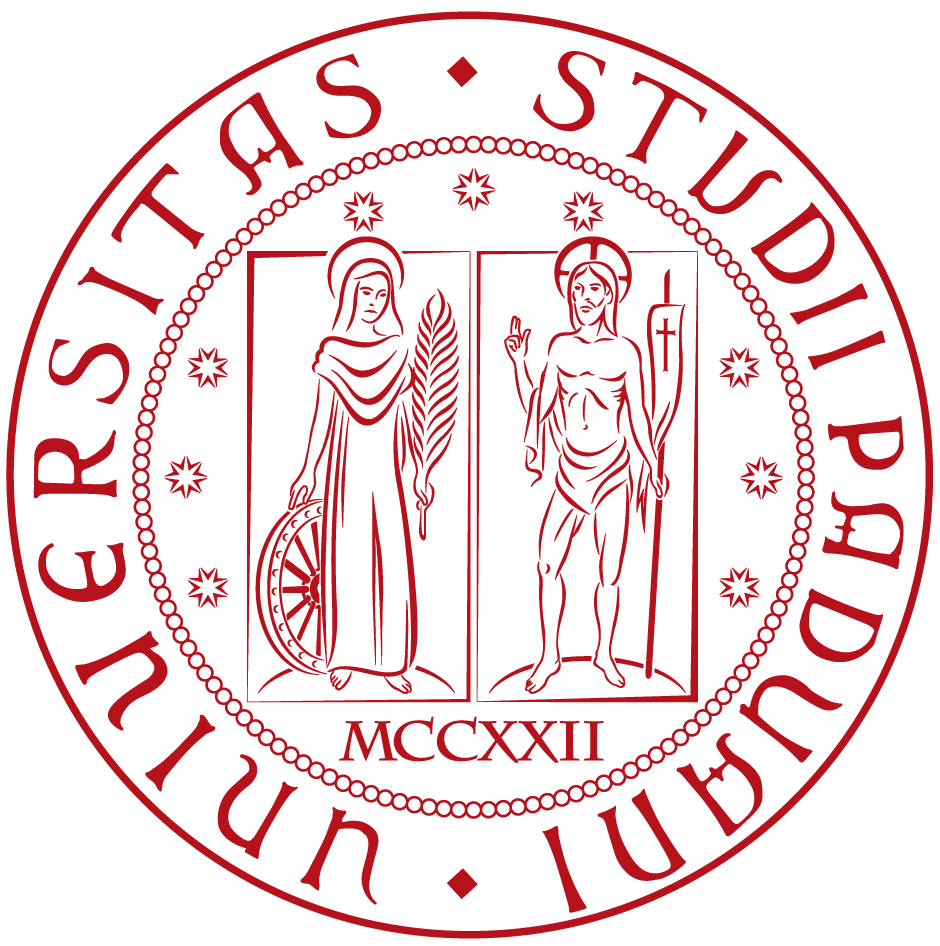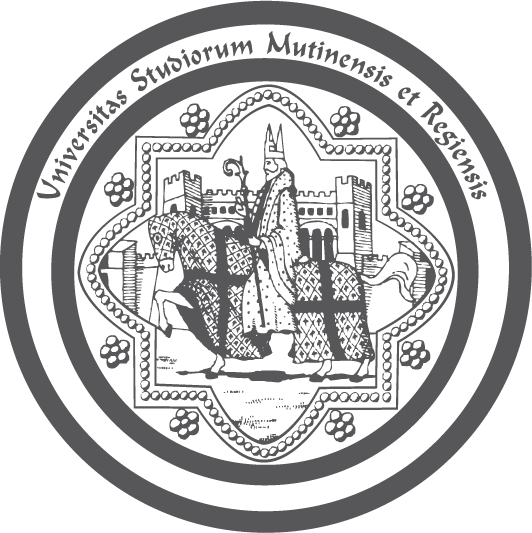1. Definizione
L’espressione italiano popolare è attestata già nell’Ottocento (si trova, per es., negli Opuscoli sulla lingua italiana di Giovanni Romani, Milano, Silvestri, 1827, p. 407), ma deve il suo successo, negli studi linguistici italiani, a Tullio De Mauro, che lo definì come il «modo di esprimersi di un incolto che, sotto la spinta di comunicare e senza addestramento, maneggia quella che ottimisticamente si chiama la lingua ‘nazionale’, l’italiano» (De Mauro 1970, p. 49). Successivamente Manlio Cortelazzo, offrendo una descrizione sistematica della ‘grammatica’ dell’italiano popolare, lo presentò come «il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto» (Cortelazzo 1972, p. 11): definizione un po’ diversa, perché mette in risalto gli aspetti di devianza rispetto alla norma più che gli scopi comunicativi, ma non incompatibile con quella demauriana.
Grazie a questi due studi (ai quali va aggiunto il volume di Spitzer del 1921, tradotto in italiano nel 1976, che analizza le lettere dei prigionieri della prima guerra mondiale), l’espressione si è stabilizzata nella linguistica italiana per indicare una precisa varietà di lingua marcata in basso lungo l’asse diastratico (Berruto 1993 e 2012; Berretta 1988). C’è anche una definizione alternativa, quella di «italiano dei semicolti» (Bruni 1984; D’Achille 1994), che intende sottolineare, anche sulla base del fatto che la varietà è documentata prevalentemente da testi scritti (lettere, diari, autobiografie), la sia pur limitata competenza scrittoria di coloro che si esprimono in italiano popolare, caratterizzati dal punto di vista sociolinguistico proprio per il loro basso grado di istruzione.