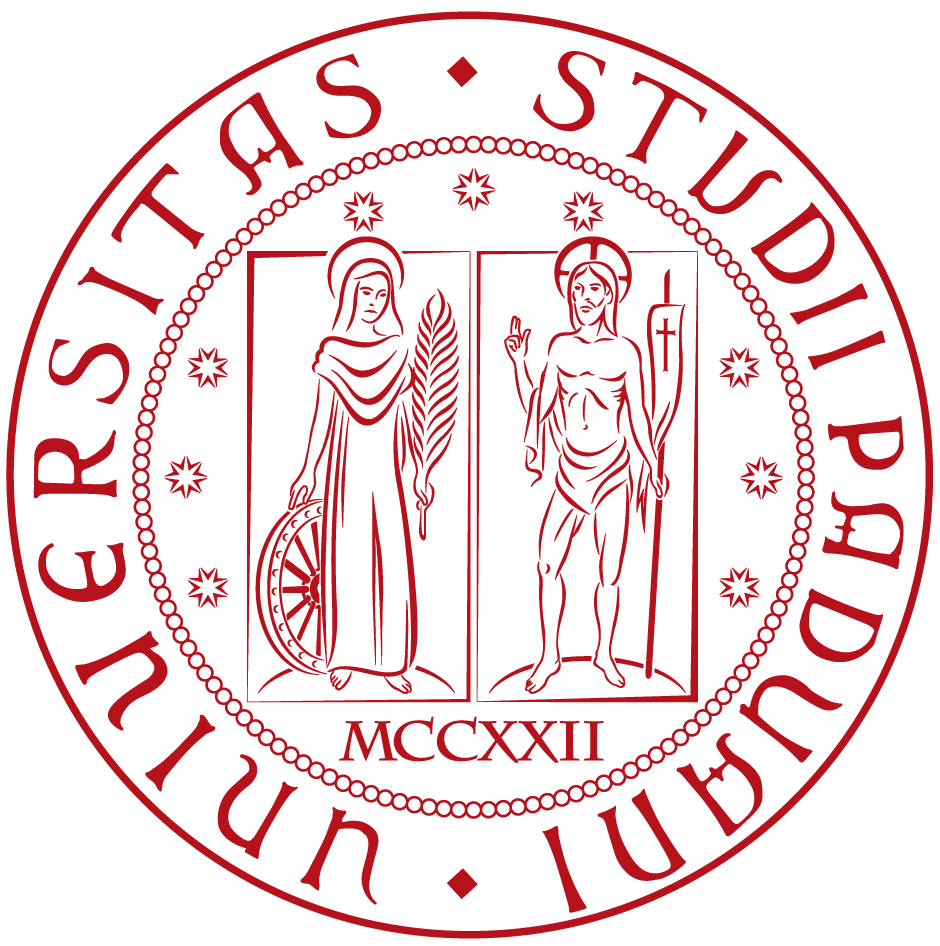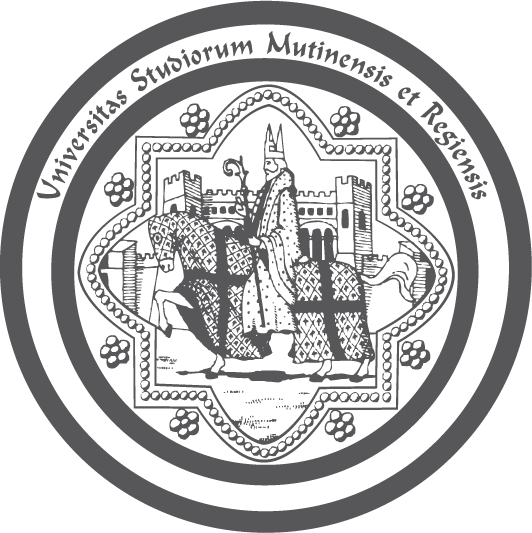"L'ultimo canto di Saffo"

Composta nel 1822 a Recanati in soli sette giorni, la canzone ha come protagonista la poetessa greca Saffo, vissuta fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Secondo la leggenda[1] Saffo, brutta e deforme, si suicida perché il bellissimo Faone non ricambia il suo amore. Leopardi riprende questa antica storia e dà voce alla poetessa che, di notte, alla tenue luce della luna (verecondo raggio) si chiede perché l’empia sorte e la natura superba l’abbiano condannata a non far parte dell’infinita beltà che la circonda. A lei, che ha desiderato invano e con tutte le sue forze (implacato desio) l’amore, la felicità e la gloria (sperate palme) non resta che la morte (il Tartaro m’avanza): il suo nobile spirito (prode ingegno) apparterrà per sempre alla dea Proserpina (tenaria Diva), regina dell'Oltretomba, dove scorre silenzioso il fiume Averno (silente riva). Questo tragico destino è comune all’umanità : nei versi Saffo fa riferimento a se stessa (a me non ride, me non saluta) ma si identifica anche con tutti i viventi (nostro dolor, nascemmo al pianto). La canzone, composta a breve distanza da Alla primavera o delle favole antiche, segna una tappa importante nell’evoluzione del pensiero di Leopardi dal pessimismo storico al pessimismo cosmico.
Placida notte, e verecondo raggio
Della cadente luna; e tu che spunti
Fra la tacita selva in su la rupe,
Nunzio del giorno; oh dilettose e care
mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,
Sembianze agli occhi miei; già non arride
Spettacol molle ai disperati affetti.
Noi l’insueto allor gaudio ravviva
Quando per l’etra liquido si volve
E per li campi trepidanti il flutto
Polveroso de’ Noti, e quando il carro,
Grave carro di Giove a noi sul capo,
Tonando, il tenebroso aere divide.
Noi per le balze e le profonde valli
Natar giova tra’ nembi, e noi la vasta
Fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto
Fiume alla dubbia sponda
Il suono e la vittrice ira dell’onda.
Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella
Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta
Infinita beltà parte nessuna
Alla misera Saffo i numi e l’empia
Sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni
Vile, o natura, e grave ospite addetta,
E dispregiata amante, alle vezzose
Tue forme il core e le pupille invano
Supplichevole intendo. A me non ride
L’aprico margo, e dall’eterea porta
Il mattutino albor; me non il canto
De’ colorati augelli, e non de’ faggi
Il murmure saluta: e dove all’ombra
Degl’inchinati salici dispiega
Candido rivo il puro seno, al mio
Lubrico piè le flessuose linfe
Disdegnando sottragge,
E preme in fuga l’odorate spiagge.
Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso
Macchiommi anzi il natale, onde sì torvo
Il ciel mi fosse e di fortuna il volto?
In che peccai bambina, allor che ignara
Di misfatto è la vita, onde poi scemo
Di giovanezza, e disfiorato, al fuso
Dell’indomita Parca si volvesse
Il ferrigno mio stame? Incaute voci
Spande il tuo labbro: i destinati eventi
Move arcano consiglio. Arcano è tutto,
Fuor che il nostro dolor. Negletta prole
Nascemmo al pianto, e la ragione in grembo
De’ celesti si posa. Oh cure, oh speme
De’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,
Alle amene sembianze eterno regno
Diè nelle genti; e per virili imprese,
Per dotta lira o canto,
Virtù non luce in disadorno ammanto.
Morremo. Il velo indegno a terra sparto
Rifuggirà l’ignudo animo a Dite,
E il crudo fallo emenderà del cieco
Dispensator de’ casi. E tu cui lungo
Amore indarno, e lunga fede, e vano
D’implacato desio furor mi strinse,
Vivi felice, se felice in terra
Visse nato mortal. Me non asperse
Del soave licor del doglio avaro
Giove, poi che perir gl’inganni e il sogno
Della mia fanciullezza. Ogni più lieto
Giorno di nostra età primo s’invola.
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra
Della gelida morte. Ecco di tante
Sperate palme e dilettosi errori,
Il Tartaro m’avanza; e il prode ingegno
Han la tenaria Diva,
E l’atra notte, e la silente riva.